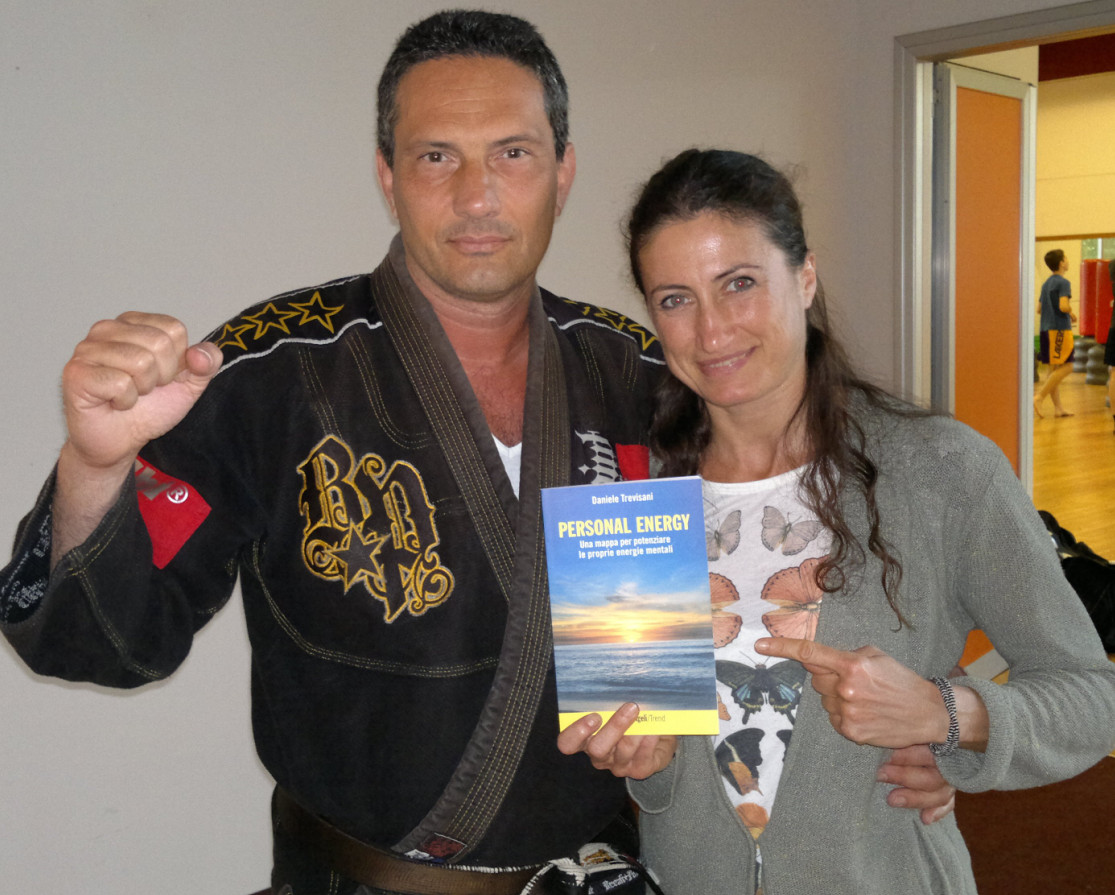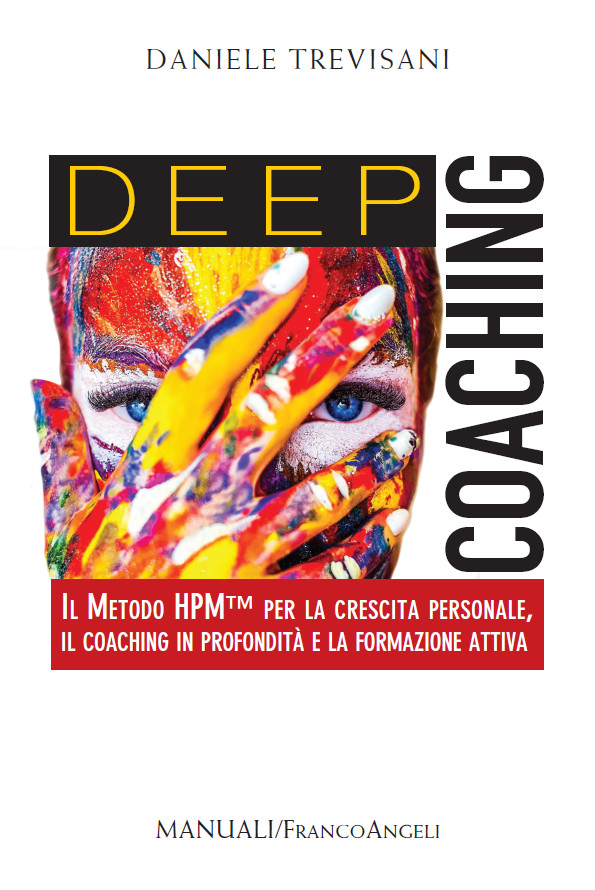Stress e resilienza
Comprendere la natura e le origini dello stress e le strategie per aumentare la resilienza
Articolo del Dott. Daniele Trevisani & Colleghi https://www.studiotrevisani.it – basato su Wikipedia in inglese, con ulteriori contributi di ricerca personale
Vedi la lista delle pubblicazioni complete o consulta il nostro Libro delle Referenze.
Se desideri un consulto preliminare con il dott. Daniele Trevisani compila questo form e sarà nostra cura ricontattarti
Indice
Analisi dello stress. 4
Biologia dello stress. 4
Psicologia dello stress. 4
Etimologia e uso storico. 5
Bisogno biologico di equilibrio. 5
Sfondo biologico. 6
Ulteriori aspetti della Biologia dello stress. 6
Effetti dello stress cronico. 7
immunologico. 7
infettivo. 8
Malattia cronica. 8
Sviluppo. 8
Psicopatologia. 8
Concetti di stress psicologico. 8
Eustress. 9
far fronte. 9
Valutazione cognitiva. 9
Sindrome di adattamento generale. 10
Fase 1. 10
Fase 2. 11
Fase 3. 11
Tipi di stress. 21
Stress acuto. 21
Stress cronico. 21
Topografia dello stress. 22
Resilienza psicologica. 32
Definizione. 32
Processi 33
Critica. 33
Storia. 34
Emozioni positive. 34
Supporto sociale. 35
Altri fattori 35
Modelli biologici 37
Costruire la resilienza. 37
Costruire la resilienza attraverso il linguaggio. 38
Altri programmi di sviluppo. 39
Bambini 40
Costruire in classe. 40
Ruolo della comunità. 40
Ruolo della famiglia. 40
Famiglie in povertà. 41
Bullismo. 41
Formazione scolastica. 41
Situazioni specifiche [. 42
Divorzio. 42
Disastri naturali 43
Morte di un familiare. 43
Impostazioni professionali 44
Resilienza interculturale. 44
Aree di differenza. 44
Resilienza nelle comunità individualiste e collettiviste. 44
Differenze nella risposta ai disastri naturali 45
Il concetto di resilienza nel linguaggio. 46
Analisi dello stress
Biologia dello stress
Lo stress , sia fisiologico , biologico o psicologico, è la risposta di un organismo a un fattore di stress come una condizione ambientale. [1] Lo stress è il metodo del corpo per reagire a una condizione come una minaccia, una sfida o una barriera fisica e psicologica . Gli stimoli che alterano l’ambiente di un organismo ricevono risposta da più sistemi nel corpo. [2] Nell’uomo e nella maggior parte dei mammiferi, il sistema nervoso autonomo e l’ asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) sono i due principali sistemi che rispondono allo stress.
L’asse midollare simpatico-surrenale (SAM) può attivare la risposta di lotta o fuga attraverso il sistema nervoso simpatico , che dedica energia ai sistemi corporei più rilevanti per l’ adattamento acuto allo stress, mentre il sistema nervoso parasimpatico riporta il corpo all’omeostasi. Il secondo grande centro fisiologico di risposta allo stress, l’asse HPA, regola il rilascio di cortisolo , che influenza molte funzioni corporee come le funzioni metaboliche, psicologiche e immunologiche . Gli assi SAM e HPA sono regolati da diverse regioni del cervello, tra cui il sistema limbico , la corteccia prefrontale , l’ amigdala , l’ ipotalamo e la stria terminale .
Attraverso questi meccanismi, lo stress può alterare le funzioni di memoria , ricompensa , funzione immunitaria , metabolismo e suscettibilità alle malattie. [4] Il rischio di malattia è particolarmente pertinente alle malattie mentali, per cui lo stress cronico o grave rimane un fattore di rischio comune per diverse malattie mentali . [5] Un sistema suggerisce che ci sono cinque tipi di stress etichettati come “fattori di stress acuti limitati nel tempo”, “fattori di stress naturalistici brevi”, “sequenze di eventi stressanti”, “fattori di stress cronici” e “fattori di stress a distanza”. Un fattore di stress acuto limitato nel tempo comporta una sfida a breve termine, mentre un breve fattore di stress naturale comporta un evento normale ma tuttavia impegnativo. Una sequenza di eventi stressanti è un fattore di stress che si verifica e poi continua a produrre stress nell’immediato futuro. Un fattore di stress cronico comporta l’esposizione a un fattore di stress a lungo termine e un fattore di stress a distanza è un fattore di stress che non è immediato.
Psicologia dello stress
Articolo principale: stress psicologico
Situazioni stressanti acute in cui lo stress sperimentato è grave è causa di cambiamento psicologico a scapito del benessere dell’individuo, per cui si sperimentano derealizzazione e depersonalizzazione sintomatica, ansia e ipereccitazione . [7] La classificazione internazionale delle malattie comprende un gruppo di disordini mentali e comportamentali che hanno la loro eziologia in reazione a grave stress e la conseguente risposta adattativa. [8] [9] Lo
Stress cronico e la mancanza di risorse di coping disponibili o utilizzate da un individuo possono spesso portare allo sviluppo di problemi psicologici come deliri , [10] depressione e ansia (vedi sotto per ulteriori informazioni). [11]
I fattori di stress cronici potrebbero non essere così intensi come i fattori di stress acuti come un disastro naturale o un grave incidente, ma persistono per periodi di tempo più lunghi, tendono ad avere un effetto più negativo sulla salute perché sono sostenuti e quindi richiedono che la risposta fisiologica del corpo si verifichi ogni giorno . [12]
Questo esaurisce l’energia del corpo più rapidamente e di solito si verifica per lunghi periodi di tempo, specialmente quando questi microstress non possono essere evitati (ad esempio, lo stress di vivere in un quartiere pericoloso). Vedere il concetto di carico allostatico per un’ulteriore discussione del processo biologico mediante il quale lo stress cronico può influenzare il corpo. Ad esempio, gli studi hanno scoperto che i caregiver, in particolare quelli dei pazienti affetti da demenza, hanno livelli più elevati di depressione e una salute fisica leggermente peggiore rispetto ai non caregiver. [12]
Quando gli esseri umani sono sotto stress cronico, possono verificarsi cambiamenti permanenti nelle loro risposte fisiologiche, emotive e comportamentali. [13] Lo Lo stress cronico può includere eventi come prendersi cura di un coniuge con demenza o può derivare da brevi eventi focali che hanno effetti a lungo termine, come subire un’aggressione sessuale. Gli studi hanno anche dimostrato che lo stress psicologico può contribuire direttamente ai tassi sproporzionatamente alti di morbilità e mortalità della malattia coronarica e dei suoi fattori di rischio eziologico . In particolare, è stato dimostrato che lo stress acuto e cronico aumenta i lipidi sierici ed è associato a eventi coronarici clinici. [14]
Tuttavia, è possibile che gli individui mostrino resistenza, un termine che si riferisce alla capacità di essere sia stressati cronicamente che sani. [15] Anche se lo stress psicologico è spesso collegato a malattie o malattie, la maggior parte degli individui sani può ancora rimanere libera dalla malattia dopo essere stata confrontata da eventi stressanti cronici.
Ciò suggerisce che esistono differenze individuali nella vulnerabilità ai potenziali effetti patogeni dello stress; le differenze individuali nella vulnerabilità sorgono a causa di fattori sia genetici che psicologici. Inoltre, l’età in cui si sperimenta lo stress può dettare il suo effetto sulla salute. La ricerca suggerisce che lo stress cronico in giovane età può avere effetti per tutta la vita sulle risposte biologiche, psicologiche e comportamentali allo stress più avanti nella vita. [16]
Etimologia e uso storico
Il termine “stress” non aveva nessuna delle sue connotazioni contemporanee prima degli anni ’20. È una forma dell’inglese medio destresse , derivato dal francese antico dal latino stringere , “tirare stretto”. [17] La parola era stata a lungo in uso in fisica per riferirsi alla distribuzione interna di una forza esercitata su un corpo materiale, con conseguente deformazione . Negli anni ’20 e ’30, i circoli biologici e psicologici usavano occasionalmente il termine per riferirsi a uno sforzo mentale o a un agente ambientale dannoso che poteva causare malattie.
Walter Cannon lo usò nel 1926 per riferirsi a fattori esterni che interrompevano quella che chiamava omeostasi . [18] Ma “… lo stress come spiegazione dell’esperienza vissuta è assente dalle narrazioni di vita sia laiche che esperte prima degli anni ’30”. [19] Lo Lo stress fisiologico rappresenta un’ampia gamma di risposte fisiche che si verificano come effetto diretto di un fattore di stress che causa un disturbo nell’omeostasi del corpo. All’interruzione immediata dell’equilibrio psicologico o fisico, il corpo risponde stimolando il sistema nervoso , endocrino e immunitario . La reazione di questi sistemi provoca una serie di cambiamenti fisici che hanno effetti sia a breve che a lungo termine sul corpo.
La scala dello stress di Holmes e Rahe è stata sviluppata come metodo per valutare il rischio di malattie dovute ai cambiamenti della vita. [20] La scala elenca sia i cambiamenti positivi che quelli negativi che provocano stress. Questi includono cose come una festa importante o un matrimonio, o la morte di un coniuge e il licenziamento da un lavoro.
Bisogno biologico di equilibrio
L’omeostasi è un concetto centrale per l’idea di stress. [21] In biologia , la maggior parte dei processi biochimici si sforzano di mantenere l’equilibrio (omeostasi), uno stato stazionario che esiste più come ideale e meno come condizione realizzabile.
I fattori ambientali, stimoli interni o esterni, interrompono continuamente l’omeostasi; la condizione attuale di un organismo è uno stato di flusso costante che si muove attorno a un punto omeostatico che è la condizione ottimale per vivere di quell’organismo. [22]
I fattori che fanno sì che le condizioni di un organismo si discostino troppo dall’omeostasi possono essere vissuti come stress. Una situazione pericolosa per la vita come un grave trauma fisico o una fame prolungata può disturbare notevolmente l’omeostasi. D’altra parte, anche il tentativo di un organismo di ripristinare le condizioni di ritorno o avvicinarsi all’omeostasi, consumando spesso energia e risorse naturali, può essere interpretato come stress. [23]
L’ambiguità nella definizione di questo fenomeno fu riconosciuta per la prima volta da Hans Selye (1907–1982) nel 1926. Nel 1951 un commentatore riassunse vagamente la visione di Selye dello stress come qualcosa che “…oltre ad essere se stesso, era anche la causa di se stesso, e il risultato di se stesso». [24] [25]
Primo ad usare il termine in un contesto biologico, Selye ha continuato a definire lo stress come “la risposta non specifica del corpo a qualsiasi richiesta posta su di esso”.
Neuroscienziati come Bruce McEwen e Jaap Koolhaas ritengono che lo stress, sulla base di anni di ricerca empirica, “dovrebbe essere limitato a condizioni in cui una richiesta ambientale supera la capacità di regolazione naturale di un organismo”. [26] In effetti, nel 1995 Toates aveva già definito lo stress come uno “stato cronico che si verifica solo quando i meccanismi di difesa sono cronicamente allungati o stanno effettivamente fallendo”, [27] mentre secondo Ursin (1988) lo stress deriva da un’incoerenza tra eventi (“valore impostato”) ed eventi percepiti (“valore effettivo”) che non possono essere risolti in modo soddisfacente, [28] che pone anche l’accento nel contesto più ampio della teoria della coerenza cognitiva . [29]
Sfondo biologico
Lo stress può avere molti effetti profondi sui sistemi biologici umani. [30] La
La biologia tenta principalmente di spiegare i principali concetti di stress utilizzando un paradigma stimolo-risposta, ampiamente paragonabile a come opera un sistema sensoriale psicobiologico . Il sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale) svolge un ruolo cruciale nei meccanismi legati allo stress del corpo. Se si debba interpretare questi meccanismi come la risposta del corpo a un fattore di stress o incarnare l’atto stesso dello stress fa parte dell’ambiguità nel definire cosa sia esattamente lo stress.
Il sistema nervoso centrale lavora a stretto contatto con il sistema endocrino del corpo per regolare questi meccanismi. Il sistema nervoso simpatico diventa attivo principalmente durante una risposta allo stress , regolando molte delle funzioni fisiologiche del corpo in modi che dovrebbero rendere un organismo più adattabile al suo ambiente. Di seguito segue un breve background biologico di neuroanatomia e neurochimica e di come si relazionano allo stress. [ citazione necessaria ]
Lo stress, sia grave, acuto o cronico di basso grado, può indurre anomalie in tre principali sistemi regolatori del corpo: i sistemi della serotonina , i sistemi delle catecolamine e l’ asse ipotalamo-ipofisi-surrenocorticale . Anche il comportamento aggressivo è stato associato ad anomalie in questi sistemi. [31]
Effetti dello stress cronico
Articolo principale: stress cronico
Lo stress cronico è un termine talvolta usato per differenziarlo dallo stress acuto. Le definizioni differiscono e possono essere sulla falsariga di una continua attivazione della risposta allo stress, [37] stress che provoca uno spostamento allostatico nelle funzioni corporee, [4] o semplicemente come “stress prolungato”. [38]
Ad esempio, i risultati di uno studio hanno dimostrato che gli individui che hanno riportato un conflitto di relazioni della durata di un mese o più hanno un rischio maggiore di sviluppare malattie e mostrano una guarigione delle ferite più lenta.
Allo stesso modo, gli effetti che i fattori di stress acuti hanno sul sistema immunitario possono essere aumentati quando si percepisce stress e/o ansia dovuti ad altri eventi. Ad esempio, gli studenti che stanno sostenendo gli esami mostrano risposte immunitarie più deboli se segnalano anche stress dovuto a problemi quotidiani. [39]
Mentre le risposte ai fattori di stress acuti in genere non impongono un onere sanitario a individui giovani e sani, lo stress cronico negli individui più anziani o non sani può avere effetti a lungo termine dannosi per la salute. [40]
immunologico
Fattori di stress acuti limitati nel tempo, o fattori di stress che sono durati meno di due ore, si traducono in una regolazione verso l’alto dell’immunità naturale e una regolazione verso il basso dell’immunità specifica . Questo tipo di stress ha visto un aumento di granulociti , cellule natural killer , IgA , interleuchina 6 e un aumento della citotossicità cellulare. Brevi fattori di stress naturalistici provocano uno spostamento dall’immunità Th1 (cellulare) a Th2 (umorale), mentre diminuiscono la proliferazione delle cellule T e la citotossicità delle cellule killer naturali. Le sequenze di eventi stressanti non hanno suscitato una risposta immunitaria coerente; tuttavia, alcune osservazioni come la diminuzione della proliferazione e della citotossicità delle cellule T, aumento o diminuzione della citotossicità delle cellule killer naturali e aumento del mitogeno PHA. Lo stress cronico ha provocato uno spostamento verso l’immunità Th2, così come una diminuzione dell’interleuchina 2, della proliferazione delle cellule T e della risposta anticorpale al vaccino antinfluenzale . I fattori di stress a distanza non hanno costantemente suscitato un cambiamento nella funzione immunitaria. [6]
infettivo
Alcuni studi hanno osservato un aumento del rischio di infezione del tratto respiratorio superiore durante lo stress cronico della vita. Nei pazienti con HIV, l’aumento dello stress vitale e del cortisolo è stato associato a una più scarsa progressione dell’HIV. [37]
Malattia cronica
È stato suggerito un collegamento tra stress cronico e malattie cardiovascolari. [37] Lo stress sembra svolgere un ruolo nell’ipertensione e può ulteriormente predisporre le persone ad altre condizioni associate all’ipertensione. [41] Lo stress può anche far precipitare una situazione più grave o ricadere nell’abuso di alcol. [4] Lo stress può anche contribuire all’invecchiamento e alle malattie croniche dell’invecchiamento, come la depressione e i disturbi metabolici. [42]
Il sistema immunitario svolge anche un ruolo nello stress e nelle prime fasi della guarigione delle ferite . È responsabile della preparazione del tessuto per la riparazione e della promozione del reclutamento di determinate cellule nell’area della ferita. [39] Coerentemente con il fatto che lo stress altera la produzione di citochine, Graham et al. hanno scoperto che lo stress cronico associato alle cure prestate a una persona con malattia di Alzheimer porta a un ritardo nella guarigione delle ferite. I risultati hanno indicato che le ferite da biopsia sono guarite del 25% più lentamente nel gruppo con stress cronico o in coloro che si prendono cura di una persona con malattia di Alzheimer. [43]
Sviluppo
È stato anche dimostrato che lo stress cronico compromette la crescita dello sviluppo nei bambini abbassando la produzione dell’ormone della crescita da parte della ghiandola pituitaria , come nei bambini associati a un ambiente domestico che comporta gravi discordie coniugali, alcolismo o abusi sui minori . [44]
Più in generale, la vita prenatale, l’infanzia, l’infanzia e l’adolescenza sono periodi critici in cui la vulnerabilità ai fattori di stress è particolarmente elevata. [45] [46]
Psicopatologia
Si ritiene che lo stress cronico influisca sulle parti del cervello in cui i ricordi vengono elaborati e archiviati. Quando le persone si sentono stressate, gli ormoni dello stress vengono secreti in modo eccessivo, il che colpisce il cervello. Questa secrezione è costituito da glucocorticoidi , tra cui il cortisolo, che sono ormoni steroidei che le ghiandola surrenale rilascia, anche se questo può aumentare stoccaggio di memorie flashbulb diminuisce potenziamento a lungo termine (LTP). [47] [48] L’ippocampo è importante nel cervello per la memorizzazione di alcuni tipi di ricordi e il danneggiamento dell’ippocampo può causare problemi nella memorizzazione di nuovi ricordi, ma i vecchi ricordi, i ricordi conservati prima del danno, non vengono persi. [49] Anche alti livelli di cortisolo possono essere legati al deterioramento dell’ippocampo e al declino della memoria che molti anziani iniziano a sperimentare con l’età. [48] Questi meccanismi e processi possono quindi contribuire alla malattia correlata all’età, o dare origine al rischio di disturbi ad esordio precoce. Ad esempio, lo stress estremo (es. trauma) è un fattore necessario per produrre disturbi legati allo stress come il disturbo da stress post-traumatico. [5]
Lo stress cronico sposta anche l’apprendimento, formando una preferenza per l’ apprendimento basato sull’abitudine , e riduce la flessibilità del compito e la memoria di lavoro spaziale , probabilmente attraverso alterazioni dei sistemi dopaminergici . [33] Lo stress può anche aumentare la ricompensa associata al cibo, portando ad un aumento di peso e ulteriori cambiamenti nelle abitudini alimentari. [50] Lo stress può contribuire a vari disturbi, come la fibromialgia , [51] la sindrome da stanchezza cronica , [52] la depressione , [53] e le sindromi somatiche funzionali . [54]
Concetti di stress psicologico
Articolo principale: Stress (psicologico)
Eustress
Selye ha pubblicato nell’anno 1975 un modello che divide lo stress in eustress e distress . [55] Laddove lo stress migliora la funzione (fisica o mentale, ad esempio attraverso l’ allenamento della forza o un lavoro impegnativo), può essere considerato eustress. Lo stress persistente che non viene risolto attraverso il coping o l’adattamento, ritenuto angoscia, può portare a comportamenti di ansia o ritiro (depressione).
La differenza tra le esperienze che portano all’eustress e quelle che provocano l’ angoscia è determinata dalla disparità tra un’esperienza (reale o immaginaria) e le aspettative personali e le risorse per far fronte allo stress. Esperienze allarmanti, reali o immaginarie, possono innescare una risposta allo stress. [56]
far fronte
Articolo principale: gestione dello stress
Le risposte allo stress includono l’adattamento, la gestione psicologica come la gestione dello stress , l’ansia e la depressione . A lungo termine, il disagio può portare a una salute ridotta e/oa una maggiore propensione alla malattia; per evitare ciò, lo stress deve essere gestito.
La gestione dello stress comprende tecniche intese a dotare una persona di meccanismi di coping efficaci per affrontare lo stress psicologico , definito come la risposta fisiologica di una persona a uno stimolo interno o esterno che innesca la risposta di lotta o fuga. La gestione dello stress è efficace quando una persona utilizza strategie per far fronte o modificare situazioni stressanti.
Esistono diversi modi per affrontare lo stress, [57] come controllare la fonte dello stress o imparare a stabilire dei limiti e a dire “no” ad alcune delle richieste che i capi o i membri della famiglia possono fare.
La capacità di una persona di tollerare la fonte dello stress può essere aumentata pensando a un altro argomento come un hobby, ascoltando musica o trascorrendo del tempo in una natura selvaggia .
Un modo per controllare lo stress è prima di tutto affrontare ciò che sta causando lo stress se è qualcosa su cui l’individuo ha il controllo. Altri metodi per controllare lo stress e ridurlo possono essere: non procrastinare e lasciare i compiti all’ultimo minuto, fare le cose che ti piacciono, fare esercizio fisico, fare routine di respirazione, uscire con gli amici e fare una pausa. Anche avere il sostegno di una persona cara aiuta molto a ridurre lo stress. [48]
Uno studio ha dimostrato che il potere di avere supporto da una persona cara, o semplicemente di avere supporto sociale, riduce lo stress nei singoli soggetti. Shock dolorosi sono stati applicati alle caviglie delle donne sposate. In alcune prove le donne erano in grado di tenere la mano del marito, in altre prove tenevano la mano di un estraneo, e poi non tenevano la mano di nessuno. Quando le donne tenevano la mano del marito, la risposta era ridotta in molte aree del cervello. Quando si teneva la mano dello sconosciuto la risposta si riduceva un po’, ma non tanto quanto quando tenevano la mano del marito. Il supporto sociale aiuta a ridurre lo stress e ancora di più se il supporto proviene da una persona cara. [48]
Valutazione cognitiva
Lazarus [58] ha sostenuto che, affinché una situazione psicosociale sia stressante, deve essere valutata come tale. Ha sostenuto che i processi cognitivi di valutazione sono centrali nel determinare se una situazione è potenzialmente minacciosa, costituisce un danno/perdita o una sfida, o è benigna.
Sia i fattori personali che quelli ambientali influenzano questa valutazione primaria, che poi innesca la selezione dei processi di coping. Il coping incentrato sul problema è diretto alla gestione del problema, mentre i processi di coping incentrati sulle emozioni sono diretti alla gestione delle emozioni negative. La valutazione secondaria si riferisce alla valutazione delle risorse disponibili per far fronte al problema e può alterare la valutazione primaria.
In altre parole, la valutazione primaria include la percezione di quanto stressante sia il problema e la valutazione secondaria di stimare se si hanno risorse più o meno adeguate per affrontare il problema che influenza la valutazione complessiva della stress. Inoltre, il coping è flessibile in quanto, in generale, l’individuo esamina l’efficacia del coping sulla situazione; se non sta avendo l’effetto desiderato, proverà, in generale, diverse strategie. [59]
Valutazione
Fattori di rischio per la salute
Sia i fattori di stress negativi che quelli positivi possono portare allo stress. L’intensità e la durata dello stress cambiano a seconda delle circostanze e delle condizioni emotive della persona che ne soffre (Arnold. E e Boggs. K. 2007). Alcune categorie comuni ed esempi di fattori di stress includono:
- Input sensoriali come dolore , luce intensa , rumore, temperatura o problemi ambientali come la mancanza di controllo sulle circostanze ambientali, come il cibo , la qualità dell’aria e/o dell’acqua, l’ alloggio , la salute , la libertà o la mobilità.
- Le questioni sociali possono anche causare stress, come lotte con individui conspecifici o difficili e sconfitte sociali , o conflitti nelle relazioni, inganni o rotture e eventi importanti come nascita e morte , matrimonio e divorzio .
- Esperienze di vita come povertà , disoccupazione , depressione clinica , disturbo ossessivo compulsivo , alcolismo , [60] o sonno insufficiente possono anche causare stress. Studenti e lavoratori possono affrontare lo stress della pressione delle prestazioni da esami e scadenze del progetto.
- Si pensa che le esperienze avverse durante lo sviluppo (es. esposizione prenatale allo stress materno, [61] [62] storie di attaccamento scadenti, [63] abuso sessuale ) [64] contribuiscano a deficit nella maturità dei sistemi di risposta allo stress di un individuo. Una valutazione dei diversi stress nella vita delle persone è la scala dello stress di Holmes e Rahe .
Sindrome di adattamento generale
I fisiologi definiscono lo stress come il modo in cui il corpo reagisce a un fattore di stress – uno stimolo, reale o immaginario, che causa stress. I fattori di stress acuti colpiscono un organismo a breve termine; fattori di stress cronici a lungo termine. La sindrome generale di adattamento (GAS), sviluppata da Hans Selye, è un profilo di come gli organismi rispondono allo stress; GAS è caratterizzato da tre fasi: una fase di mobilizzazione non specifica, che promuove l’attività del sistema nervoso simpatico; una fase di resistenza, durante la quale l’organismo si sforza di far fronte alla minaccia; e una fase di esaurimento, che si verifica se l’organismo non riesce a superare la minaccia ed esaurisce le sue risorse fisiologiche. [65]
Fase 1
L’allarme è la prima fase, che si divide in due fasi: la fase shock e la fase antishock . [66]
- Fase di shock : durante questa fase, il corpo può sopportare cambiamenti come ipovolemia , ipoosmolarità , iponatriemia , ipocloremia , ipoglicemia: l’effetto stressante. Questa fase ricorda il morbo di Addison . La resistenza dell’organismo al fattore di stress scende temporaneamente al di sotto del range di normalità e può verificarsi un certo livello di shock (es. shock circolatorio ).
- Fase antishock : quando la minaccia o il fattore di stress viene identificato o realizzato, il corpo inizia a rispondere ed è in uno stato di allarme. Durante questa fase, il locus coeruleus e il sistema nervoso simpatico attivano la produzione di catecolamine inclusa l’adrenalina, attivando la famosa risposta di lotta o fuga . L’adrenalina fornisce temporaneamente un aumento del tono muscolare , aumento della pressione sanguigna a causa di vasocostrizione periferica e tachicardia e aumento del glucosio nel sangue. C’è anche una certa attivazione dell’asse HPA , che produce glucocorticoidi (cortisolo, noto anche come ormone S o ormone dello stress).
Fase 2
La resistenza è il secondo stadio. Durante questa fase, l’aumento della secrezione di glucocorticoidi intensifica la risposta sistemica dell’organismo. I glucocorticoidi possono aumentare la concentrazione di glucosio, grassi e aminoacidi nel sangue. A dosi elevate, un glucocorticoide, il cortisolo , inizia ad agire in modo simile a un mineralcorticoide ( aldosterone ) e porta l’organismo a uno stato simile all’iperaldosteronismo . Se il fattore di stress persiste, diventa necessario tentare alcuni mezzi per far fronte allo stress. Il corpo tenta di rispondere a stimoli stressanti, ma dopo un’attivazione prolungata, le risorse chimiche del corpo si esauriranno gradualmente, portando allo stadio finale.
Fase 3
La terza fase potrebbe essere l’ esaurimento o il recupero :
- La fase di recupero segue quando i meccanismi di compensazione del sistema hanno superato con successo l’effetto stressante (o hanno completamente eliminato il fattore che ha causato lo stress). Gli alti livelli di glucosio, grassi e aminoacidi nel sangue si rivelano utili per le reazioni anaboliche, il ripristino dell’omeostasi e la rigenerazione delle cellule.
- L’esaurimento è il terzo stadio alternativo nel modello GAS. A questo punto, tutte le risorse del corpo sono esaurite e il corpo non è in grado di mantenere la normale funzione. I sintomi iniziali del sistema nervoso autonomo possono riapparire (sudorazione, aumento della frequenza cardiaca, ecc.). Se lo stadio tre viene esteso, possono verificarsi danni a lungo termine (la vasocostrizione prolungata provoca ischemia che a sua volta porta alla necrosi cellulare), poiché il sistema immunitario del corpo si esaurisce e le funzioni corporee vengono compromesse, con conseguente scompenso .
Il risultato può manifestarsi in malattie evidenti, come disturbi generali dell’apparato digerente (es. emorragie occulte , melena , stitichezza /stipsi), diabete o anche problemi cardiovascolari ( angina pectoris ), insieme a depressione clinica e altre malattie mentali. [ citazione necessaria ]
Storia nella ricerca
L’uso attuale della parola stress è nato dagli esperimenti degli anni ’30 di Hans Selye . Ha iniziato a usare il termine per riferirsi non solo all’agente, ma allo stato dell’organismo mentre rispondeva e si adattava all’ambiente. Le sue teorie su una risposta allo stress universale non specifica hanno suscitato grande interesse e contesa nella fisiologia accademica e ha intrapreso ampi programmi di ricerca e sforzi di pubblicazione. [67]
Mentre il lavoro ha attirato il continuo sostegno dei sostenitori della medicina psicosomatica , molti in fisiologia sperimentale hanno concluso che i suoi concetti erano troppo vaghi e non misurabili. Durante gli anni ’50, Selye si allontanò dal laboratorio per promuovere il suo concetto attraverso libri popolari e tour di conferenze. Ha scritto sia per medici non accademici che, in un bestseller internazionale intitolato Stress of Life , per il grande pubblico.
Un ampio concetto biopsicosociale di stress e adattamento offriva la promessa di aiutare tutti a raggiungere la salute e la felicità rispondendo con successo alle mutevoli sfide globali e ai problemi della civiltà moderna . Selye ha coniato il termine ” eustress ” per lo stress positivo, in contrasto con il disagio . Ha sostenuto che tutte le persone hanno un impulso naturale e hanno bisogno di lavorare per il proprio vantaggio, un messaggio che ha trovato il favore di industriali e governi. [67] Ha anche coniato il termine stressante per riferirsi all’evento causale o allo stimolo, in contrapposizione allo stato di stress risultante.
Selye era in contatto con l’ industria del tabacco dal 1958 ed erano alleati non dichiarati nei contenziosi e nella promozione del concetto di stress, offuscando il legame tra fumo e cancro e dipingendo il fumo come una “diversione”, o nel concetto di Selye una “deviazione”. “, dallo stress ambientale. [68]
Dalla fine degli anni ’60, gli psicologi accademici iniziarono ad adottare il concetto di Selye; hanno cercato di quantificare lo “stress della vita” segnando ” eventi significativi della vita “, ed è stata intrapresa una grande quantità di ricerche per esaminare i collegamenti tra stress e malattie di ogni tipo. Alla fine degli anni ’70, lo stress era diventato l’area medica di maggiore preoccupazione per la popolazione generale ed era necessaria una ricerca di base per affrontare meglio il problema. Sono state inoltre rinnovate le ricerche di laboratorio sulle basi neuroendocrine , molecolari e immunologiche dello stress, concepite come un’utile euristica non necessariamente legata alle ipotesi originarie di Selye. L’ esercito degli Stati Uniti è diventato un centro chiave di ricerca sullo stress, nel tentativo di comprendere e ridurre la nevrosi da combattimento e le vittime psichiatriche. [67]
La diagnosi psichiatrica del disturbo da stress post-traumatico ( PTSD ) è stata coniata a metà degli anni ’70, in parte grazie agli sforzi degli attivisti contro la guerra del Vietnam e dei veterani del Vietnam contro la guerra , e Chaim F. Shatan . La condizione è stata aggiunta al Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali come disturbo da stress post-traumatico nel 1980. [69] Il PTSD era considerato una reazione emotiva grave e continua a un trauma psicologico estremo, e come tale spesso associato a soldati, agenti di polizia e altro personale di emergenza. Il fattore di stress può comportare la minaccia alla vita (o la visualizzazione della morte effettiva di qualcun altro), gravi lesioni fisiche o minaccia all’integrità fisica o psicologica. In alcuni casi, può anche derivare da un profondo trauma psicologico ed emotivo, oltre a qualsiasi danno fisico o minaccia reale. Spesso, tuttavia, i due sono combinati.
Negli anni ’90, lo “stress” era diventato parte integrante della moderna comprensione scientifica in tutte le aree della fisiologia e del funzionamento umano e una delle grandi metafore della vita occidentale. L’attenzione è cresciuta sullo stress in determinati contesti, come lo stress sul posto di lavoro , e sono state sviluppate tecniche di gestione dello stress . Il termine divenne anche un eufemismo , un modo per riferirsi ai problemi e suscitare simpatia senza essere esplicitamente confessionale, semplicemente “stressato”. È arrivato a coprire una vasta gamma di fenomeni, dalla lieve irritazione al tipo di problemi gravi che potrebbero provocare un vero e proprio crollo della salute . Nell’uso comune, quasi ogni evento o situazione tra questi estremi potrebbe essere descritto come stressante. [17] [67]
Lo Stress In America Study del 2015 dell’American Psychological Association [70] ha rilevato che lo stress a livello nazionale è in aumento e che le tre principali fonti di stress erano “denaro”, “responsabilità familiare” e “lavoro”.
Guarda anche
Riferimenti
- ^ Nachiappan, Vasanthi; Muthukumar, Kannan (dicembre 2010). “Lo stress ossidativo indotto dal cadmio in Saccharomyces cerevisiae” . Giornale indiano di biochimica e biofisica. 47 (6): 383-387. ISSN 0975-0959 . PMID 21355423 . Archiviato dall’originale il 25 luglio 2019. Estratto il 1 agosto 2019.
- ^ Muthukumar, Kannan; Nachiappan, Vasanthi (1 dicembre 2013). “La fosfatidiletanolamina da fosfatidilserina decarbossilasi2 è essenziale per l’autofagia sotto stress da cadmio in Saccharomyces cerevisiae”. Biochimica e biofisica cellulare. 67 (3): 1353–1363. doi : 1007/s12013-013-9667-8 . ISSN 1559-0283 . PMID 23743710 . S2CID 16393480 .
- ^ Salta a: a b Ulrich-Lai, Yvonne M.; Herman, James P. (7 febbraio 2017). “Regolazione neurale delle risposte allo stress endocrino e autonomo” . Recensioni sulla natura Neuroscienze. 10 (6): 397–409. doi : 1038/nrn2647 . ISSN 1471-003X . PMC 4240627 . PMID 19469025 .
- ^ Salta a: a b c Stephens, Mary Ann C.; Bacchetta, Gary (1 gennaio 2012). “Stress e l’asse HPA” . Ricerca sull’alcol: recensioni attuali. 34 (4): 468–483. ISSN 2168-3492 . PMC 3860380 . PMID 23584113 .
- ^ Salta a: a b Notaras, Michael; van den Buuse, Maarten (3 gennaio 2020). “Neurobiologia del BDNF nella memoria della paura, nella sensibilità allo stress e nei disturbi legati allo stress” . Psichiatria Molecolare. 25 (10): 2251–2274. doi : 1038/s41380-019-0639-2 . ISSN 1476-5578 . PMID 31900428 . S2CID 209540967 .
- ^ Salta a: a b c Segerstrom, Suzanne C.; Miller, Gregory E. (7 febbraio 2017). “Lo stress psicologico e il sistema immunitario umano: uno studio meta-analitico di 30 anni di indagine” . Bollettino psicologico. 130 (4): 601-630. doi : 1037/0033-2909.130.4.601 . ISSN 0033-2909 . PMC 1361287 . PMID 15250815 .
- ^ Ehlers, Anke; Harvey, Allison G.; Bryant, Richard A. (ottobre 2012) [febbraio 2012]. “Reazioni acute da stress” . In Gelder, Michael; Andreasen, Nancy; Lopez-Ibor, Juan; Geddes, John (a cura di). New Oxford Textbook of Psychiatry (2a ed.). oxfordmedicine.com: Pressa dell’università di Oxford . doi : 1093/med/9780199696758.001.0001 . ISBN 9780199696758 . Estratto il 3 luglio 2021 – tramite Google .
- ^ dottori; Sartorio, Normanno ; Henderson, AS; Strotzka, H.; Lipowski, Z.; Yu-cun, Shen; Tu-xin, Xu; Strömgren, E.; Glatzel, J.; Kühne, G.-E.; Mises, R.; Soldati, CR; Tirare, CB; Giel, R.; Jegede, R.; Malto, Stati Uniti; Nadzharov, RA; Smulevic, AB; Hagberg, B.; Perris, C.; Scharfetter, C.; Chiara, A.; Cooper, JE; Corbett, JA; Griffith Edwards, J.; Gelder, M.; Goldberg, D.; Gossop, M.; Graham, P.; Kendell, RE; Marchi, I.; Russel, G.; Rutter, M.; pastore, M.; Ovest, DJ; Ala, J.; Ala, L.; Neki, JS; Benson, F.; Cantwell, D.; Guze, S.; Helzer, J.; Holzman, P.; Kleinman, A.; Kupfer, DJ; Mezzich, J.; Spitzer, R.; Lokar, J. “La classificazione ICD-10 dei disturbi mentali e comportamentali Descrizioni cliniche e linee guida diagnostiche” (PDF) . www.who.int Organizzazione Mondiale della Sanità . Microsoft Word . bluebook.doc. P. 110. Estratto il 23 giugno 2021 – tramite Microsoft Bing .
- ^ “Significato dell’eziologia in inglese” . dizionario.cambridge.org ( Cambridge University Press ). Estratto il 3 luglio 2021.
- ^ Kingston, Cara; Schuurmans-Stekhoven, James (2016). “Hai problemi di vita e ideazione delirante: Scoping il ruolo potenziale dei mediatori cognitivi e affettivi”. Psicologia e psicoterapia: teoria, ricerca e pratica. 89 (4): 445–463. doi : 1111/papt.12089 . PMID 26846698 .
- ^ Schlotz W, Yim IS, Zoccola PM, Jansen L, Schulz P (2011). La scala di reattività allo stress percepita: invarianza, stabilità e validità della misurazione in tre paesi. Valutazione psicologica. (pagg. 80-94).
- ^ Salta a: a b Pinquart M.; Sorensen S. (2003). “Differenze tra caregiver e non caregiver in salute psicologica e salute fisica: una meta-analisi”. Psicologia e invecchiamento. 18 (2): 250-267. doi : 1037/0882-7974.18.2.250 . PMID 12825775 .
- ^ Cohen, S; Janicki-Deverts, D; Miller, GE. (2007). “Stress psicologico e malattia” (PDF) . JAMA. 298 (14): 1685–1687. doi : 1001/jama.298.14.1685 . PMID 17925521 . Archiviato dall’originale (PDF) il 24 settembre 2015. Estratto il 5 luglio 2015.
- ^ Calderon, R.; Schneider, RH; Alessandro, CN; Myers, HF; Nidich, SI; Haney, C. (1999). “Stress, riduzione dello stress e ipercolesterolemia negli afroamericani: una recensione”. Etnia e malattia. 9 (3): 451–462. ISSN 1049-510X . PMID 10600068 .
- ^ Kobasa, SC (1982). La personalità Hardy: verso una psicologia sociale dello stress e della salute. In GS Sanders & J. Suls (a cura di), Psicologia sociale della salute e della malattia (pp. 1–25). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Assoc.
- ^ Miller, G.; Chen, E.; Cole, SW (2009). “Psicologia della salute: sviluppo di modelli biologicamente plausibili che collegano il mondo sociale e la salute fisica” . Rassegna annuale di psicologia. 60 : 501-524. doi : 1146/annurev.psych.60.110707.163551 . PMID 19035829 .
- ^ Salta a: a b Keil RMK (2004). “Coing e stress: un’analisi concettuale”. Giornale di infermieristica avanzata. 45 (6): 659–665. doi : 1046/j.1365-2648.2003.02955.x . PMID 15012643 .
- ^ Cannone WB; Regolazione fisiologica degli stati normali: alcuni postulati provvisori riguardanti l’omeostatica biologica ; IN: A. Pettit (a cura di); A Charles Richet: ses amis, ses collègues, ses élèves; P. 91; Parigi; Edizioni mediche; 1926.
- ^ Viner, Russell (giugno 1999). “Mettere lo stress nella vita: Hans Selye e la teoria dello stress”. Studi sociali della scienza. 29 (3): 391–410. doi : 1177/03063129902903003 . ISSN 1460-3659 . JSTOR 285410 . S2CID 145291588 .
- ^ Capitano Richard H. Rahe MC USNR; Dr Ransom J. Arthur, medico (1 marzo 1978). “Studi sul cambiamento di vita e sulla malattia: storia passata e direzioni future”. Giornale dello stress umano. 4 (1): 3-15. doi : 1080/0097840X.1978.9934972 . ISSN 0097-840X . PMID 346993 .
- ^ Goldstein, David S.; Kopin, Irwin J. (gennaio 2007). “Evoluzione dei concetti di stress”. Fatica. 10 (2): 109-120. doi : 1080/10253890701288935 . PMID 17514579 . S2CID 25072963 .
- ^ Dattatreya, Shruthi (2014). “Lo stress può prendere il costo della vita”. doi : 2139/ssrn.2456211 . SSRN 2456211 .
- ^ Worthington, James (9 novembre 2014). “Sei modi per individuare la manipolazione emotiva prima che ti distrugga” . Il modello di fusione Archiviato dall’originale il 19 aprile 2015. Estratto il 19 aprile 2015.
- ^ Humphrey, James H. (2005). Antologia dello stress rivisitato: opere selezionate di James H. Humphrey . Prefazione di Paul J. Rosch. Nova Science Editori. P. viii. ISBN 9781594546402 . Archiviato dall’originale il 24 ottobre 2015. Estratto il 2 maggio 2013. Anche Selve [sic] ha avuto difficoltà e nell’aiutarlo a preparare il suo primo rapporto annuale sullo stress 1951, ho incluso i commenti di un medico pubblicati sul British Medical Journal, il quale, utilizzando citazioni dagli articoli di Selye, ha concluso che “lo stress, oltre ad essere se stesso, era anche la causa di se stesso e il risultato di se stesso”.
- ^ Selye, Hans (1978). Lo stress della vita (Rev. ed.). New York: McGraw-Hill. ISBN 9780070562127 .
- ^ Koolhaas J, et al. (2011). “Stress rivisitato: una valutazione critica del concetto di stress”. Neuroscienze e recensioni biocomportamentali. 35 (5): 1291-1301. doi : 1016/j.neubiorev.2011.02.003 . PMID 21316391 . S2CID 15584486 .
- ^ Toates, FM (1995). Stress: aspetti concettuali e biologici. Chichester, Inghilterra: Wiley.
- ^ Ursin, H. (1988). “Aspettativa e attivazione: un tentativo di sistematizzare la teoria dello stress”. In Hellhammer, DH; Florino, I.; Weiner, H. (a cura di). Controllo neuronale della funzione corporea: aspetti di base e clinici, vol. 2: Approcci neurobiologici alle malattie umane. Kirkland, WA: Huber. pp. 313-334.
- ^ van Kampen, HS (2019). “Il principio di coerenza e la causa e la funzione del comportamento”. Processi comportamentali. 159 : 42–54. doi : 1016/j.beproc.2018.12.013 . PMID 30562561 . S2CID 56478466 .
- ^ Schacter, Daniel L. ; Gilbert, Daniel T.; Wegner, Daniel M. (2011). Psicologia (2a ed.). New York: Worth Publishers. P. 7 . ISBN 978-1429237192 .
- ^ Walton, Kenneth G.; Levitsky, Debra K. (2003). “Effetti del programma di Meditazione Trascendentale sulle anomalie neuroendocrine associate all’aggressività e alla criminalità”. Journal of Offender Rehabilitation. 36 (1–4): 67–87. doi : 1300/J076v36n01_04 . S2CID 144374302 .
- ^ Salta a: a b McCorry, Laurie Kelly (15 agosto 2007). “Fisiologia del sistema nervoso autonomo” . Giornale americano di educazione farmaceutica. 71 (4): 78. doi : 5688/aj710478 . ISSN 0002-9459 . PMC 1959222 . PMID 17786266 .
- ^ Salta a: a b McKlveen, Jessica M.; Myers, Brent; Herman, James P. (7 febbraio 2017). “La corteccia prefrontale mediale: coordinatore delle risposte autonomiche, neuroendocrine e comportamentali allo stress” . Giornale di Neuroendocrinologia. 27 (6): 446–456. doi : 1111/jne.12272 . ISSN 0953-8194 . PMC 4580281 . PMID 25737097 .
- ^ El-Sheikh, Mona; Erath, Stephen A. (7 febbraio 2017). “Conflitto familiare, funzionamento del sistema nervoso autonomo e adattamento del bambino: stato della scienza e direzioni future” . Sviluppo e Psicopatologia. 23 (2): 703-721. doi : 1017/S0954579411000034 . ISSN 0954-5794 . PMC 3695441 . PMID 23786705 .
- ^ Hering, Dagmara; Lachowska, Kamila; Schlaich, Markus (1 ottobre 2015). “Ruolo del sistema nervoso simpatico nelle malattie cardiovascolari mediate dallo stress”. Rapporti attuali di ipertensione. 17 (10): 80. doi : 1007/s11906-015-0594-5 . ISSN 1534-3111 . PMID 26318888 . S2CID 30136233 .
- ^ Salta a: a b c Smith, Sean M.; Vale, Wylie W. (7 febbraio 2017). “Il ruolo dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene nelle risposte neuroendocrine allo stress” . Dialoghi nelle neuroscienze cliniche. 8 (4): 383-395. ISSN 1294-8322 . PMC 3181830 . PMID 17290797 .
- ^ Salta a: a b c Schneiderman, Neil; Ironson, Gail; Siegel, Scott D. (1 gennaio 2005). “STRESS E SALUTE: determinanti psicologici, comportamentali e biologici” . Revisione annuale di psicologia clinica. 1 : 607–628. doi : 1146/annurev.clinpsy.1.102803.144141 . ISSN 1548-5943 . PMC 2.568.977 . PMID 17716101 .
- ^ Herman, James P. (8 agosto 2013). “Controllo neurale dell’adattamento allo stress cronico” . Frontiere delle neuroscienze comportamentali. 7 : 61. doi : 3389/fnbeh.2013.00061 . ISSN 1662-5153 . PMC 3737713 . PMID 23964212 .
- ^ Salta a: a b Graham J.; Cristiano L.; Kiecolt-Glaser J. (2006). “Stress, età e funzione immunitaria: verso un approccio per la durata della vita” . Giornale di medicina comportamentale. 29 (4): 389–400. doi : 1007/s10865-006-9057-4 . PMC 2805089 . PMID 16715331 .
- ^ Schneidermann N.; Ironson G.; Siegel SD (2005). “Stress e salute: determinanti psicologici, comportamentali e biologici” . Revisione annuale di psicologia clinica. 1 (1): 607–628. doi : 1146/annurev.clinpsy.1.102803.144141 . PMC 2.568.977 . PMID 17716101 .
- ^ Spruill, Tanya M. (7 febbraio 2017). “Stress psicosociale cronico e ipertensione” . Rapporti attuali di ipertensione. 12 (1): 10-16. doi : 1007/s11906-009-0084-8 . ISSN 1522-6417 . PMC 3694268 . PMID 20425153 .
- ^ Aguilera, Greti (1 gennaio 2011). “Reattività dell’asse HPA allo stress: implicazioni per un invecchiamento sano” . Gerontologia Sperimentale. 46 (2–3): 90–95. doi : 1016/j.exger.2010.08.023 . ISSN 0531-5565 . PMC 3026863 . PMID 20833240 .
- ^ Khansari D.; Murgo A.; Fede R. (maggio 1990). “Effetti dello stress sul sistema immunitario”. Immunologia oggi. 11 (5): 170–175. doi : 1016/0167-5699(90)90069-l . PMID 2186751 .
- ^ Powell, Brasel e Blizzard, 1967.
- ^ Charmandari E, Achermann JC, Carel JC, Soder O, Chrousos GP (2012). “Risposta allo stress e salute dei bambini”. Segnalazione scientifica (recensione). 5 (248): mr1. doi : 1126/scisignal.2003595 . PMID 23112343 . S2CID 13920757 .
- ^ Charmandari E, Kino T, Souvatzoglou E, Chrousos GP (2003). “Lo stress pediatrico: mediatori ormonali e sviluppo umano” . Ricerca sugli ormoni (recensione). 59 (4): 161–79. doi : 1159/000069325 . PMID 12649570 . S2CID 9744754 .
- ^ “Rinnovare lo stress sul cervello” . L’Istituto Franklin . Archiviato dall’originale l’11 maggio 2012.
- ^ Salta a: a b c d Kalat, JW (2013). Psicologia Biologica. P. 383
- ^ Kalat, JW (2013). Psicologia Biologica. P. 97
- ^ Yau, Yvonne HC; Potenza, Marc N. (7 febbraio 2017). “Stress e comportamenti alimentari” . Minerva Endocrinologica. 38 (3): 255-267. ISSN 0391-1977 . PMC 4214609 . PMID 24126546 .
- ^ Clauw, Daniel J. (2014). “Fibromialgia”. JAMA. 311 (15): 1547-55. doi : 1001/jama.2014.3266 . PMID 24737367 .
- ^ Wyller, Vegard Bruun (1 gennaio 2007). “La sindrome da stanchezza cronica, un aggiornamento”. Acta Neurologica Scandinavica Supplementum. 187 : 7-14. doi : 1111/j.1600-0404.2007.00840.x . ISSN 0065-1427 . PMID 17419822 . S2CID 11247547 .
- ^ Saveanu, Radu V.; Nemeroff, Charles B. (marzo 2012). “Eziologia della depressione: fattori genetici e ambientali”. Cliniche psichiatriche del Nord America. 35 (1): 51-71. doi : 1016/j.psc.2011.12.001 . PMID 22370490 .
- ^ Afari, Niloofar; Ahumada, Sandra M.; Wright, Lisa Johnson; Mostoufi, Sheeva; Golnari, Golnaz; Reis, Veronica; Cuneo, Jessica Gundy (7 febbraio 2017). “Trauma psicologico e sindromi somatiche funzionali: una revisione sistematica e una meta-analisi” . Medicina Psicosomatica. 76 (1): 2-11. doi : 1097/PSY.000000000000000010 . ISSN 0033-3174 . PMC 3894419 . PMID 24336429 .
- ^ Sely (1975). “Confusione e polemiche nel campo dello stress”. Giornale dello stress umano. 1 (2): 37–44. doi : 1080/0097840X.1975.9940406 . PMID 1235113 .
- ^ de Kloet, E. Ron; Joels, Marian; Holsboer, Florian (giugno 2005). “Stress e cervello: dall’adattamento alla malattia”. Recensioni sulla natura Neuroscienze. 6 (6): 463–475. doi : 1038/nrn1683 . PMID 15891777 . S2CID 1320302 .
- ^ “La silenziosa negazione dello stress in un mondo competitivo” . 17 marzo 2012. Archiviato dall’originale in data 19 aprile 2012. Estratto 17 marzo del 2012.
- ^ Lazzaro, RS (1966). Stress psicologico e processo di coping. New York: McGraw-Hill.
- ^ Aldwin, Carolyn (2007). Stress, coping e sviluppo, seconda edizione. New York: Guilford Press. ISBN 978-1-57230-840-4 .
- ^ Glavas, MM; Weinberg, J. (2006). “Stress, consumo di alcol e l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene”. In Yehuda, S.; Mostofsky, DI (a cura di). Nutrienti, stress e disturbi medici . Totowa, NJ: Humana Press. pp. 165 –183. ISBN 978-1-58829-432-6 .
- ^ Davis et al. (giugno 2007). L’esposizione prenatale alla depressione materna e al cortisolo influenza il temperamento del bambino. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry , v46 n6 p737.
- ^ O’Connor; Airone; oro; bevanda; Guantoni (2002). “Ansia materna prenatale e problemi comportamentali/emotivi del bambino a 4 anni” . Br J Psichiatria. 180 (6): 478-9. doi : 1192/bjp.180.6.502 . PMID 12042228 .
- ^ Schore, Allan (2003). Regolazione affettiva e riparazione del sé. New York: WW Norton. ISBN 978-0-393-70407-5 .
- ^ DeBellis, Michael D.; Chrousos, George P.; D. Dorn, Lorah; Burke, Lillian; Helmers, Karin; Kling, Mitchel A.; K. Trickett, Penelope; Putnam, Frank W. (1994). “Disregolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene nelle ragazze abusate sessualmente”. Il Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 78 (2): 249-255. doi : 1210/jcem.78.2.8106608 . PMID 8106608 .
- ^ Taylor, Shelley; Sirois, Fuschia (2012). Psicologia della salute (2a edizione canadese ). McGraw Hill Ryerson. ISBN 978-0070319790 .
- ^ Gozhenko, AI; Gurkalova, IP; Zukow, W; Kwasnik, Z; Mroczkowska, B (2009). Gozhenko, AI; Zukow, W; Kwasnik, Z (a cura di). Patologia: Biblioteca degli studenti di medicina. Università di Radom. P. 272 . ISBN 978-83-61047-18-6 . OCLC 750538315 .
- ^ Salta a: a b c d Viner R (1999). “Mettere lo stress nella vita: Hans Selye e la teoria dello stress”. Studi sociali della scienza. 29 (3): 391–410. doi : 1177/03063129902903003 . JSTOR 285410 . S2CID 145291588 .
- ^ Petticrew, Mark P.; Lee, Kelley (marzo 2011). “Il “padre dello stress” incontra il “grande tabacco”: Hans Selye e l’industria del tabacco” . Giornale americano di sanità pubblica. 101 (3): 411–418. doi : 2105/AJPH.2009.177634 . ISSN 0090-0036 . PMC 3036703 . PMID 20466961 .
- ^ Shalev, Arieh Y.; Yehuda, Rachele; Alexander C. McFarlane (2000). Manuale internazionale di risposta umana al trauma. New York: Kluwer Academic/Plenum Press. ISBN 978-0-306-46095-1 . ; on-line Archiviato il 17 giugno 2007 in Internet Archive ..
- ^ “Istantanea dello stress in America del 2015” . www.apa.org. Archiviato dall’originale il 16 marzo 2017. Estratto il 6 aprile 2017.
link esterno
Gestione dello stress
La gestione dello stress è un ampio spettro di tecniche e psicoterapie volte a controllare il livello di stress di una persona , in particolare lo stress cronico , solitamente allo scopo e per il motivo di migliorare il funzionamento quotidiano. Lo stress produce numerosi sintomi fisici e mentali che variano a seconda dei fattori situazionali di ciascun individuo. Questi possono includere un declino della salute fisica così come la depressione . Il processo di gestione dello stress è considerato una delle chiavi per una vita felice e di successo nella società moderna. La vita spesso offre numerose richieste che possono essere difficili da gestire, ma la gestione dello stress fornisce una serie di modi per gestire l’ansia e mantenere il benessere generale.
Nonostante lo stress sia spesso considerato un’esperienza soggettiva, i livelli di stress sono facilmente misurabili; utilizzando vari test fisiologici, simili a quelli utilizzati nei poligrafi .
Esistono diversi modelli di gestione dello stress, ciascuno con spiegazioni distintive dei meccanismi per il controllo dello stress. Sono necessarie molte più ricerche per fornire una migliore comprensione di quali meccanismi operano effettivamente e sono efficaci nella pratica.
Fondamenti storici
Walter Cannon e Hans Selye hanno utilizzato studi sugli animali per stabilire le prime basi scientifiche per lo studio dello stress. Hanno misurato le risposte fisiologiche degli animali alle pressioni esterne, come il caldo e il freddo, la contenzione prolungata e le procedure chirurgiche, quindi estrapolate da questi studi agli esseri umani. [1] [2]
Successivi studi sullo stress negli esseri umani di Richard Rahe e altri hanno stabilito l’opinione che lo stress è causato da fattori di stress della vita distinti e misurabili e, inoltre, che questi fattori di stress della vita possono essere classificati in base al grado mediano di stress che producono (che porta alla Holmes e Rahe scala dello stress ). Pertanto, lo stress è stato tradizionalmente concettualizzato come il risultato di insulti esterni al di fuori del controllo di coloro che sperimentano lo stress. Più recentemente, tuttavia, è stato affermato che le circostanze esterne non hanno alcuna capacità intrinseca di produrre stress, ma che il loro effetto è mediato dalle percezioni, dalle capacità e dalla comprensione dell’individuo.
Modelli
I modelli generalizzati sono:
Modello transazionale
Modello transazionale di stress e coping di Richard Lazarus
Richard Lazarus e Susan Folkman hanno suggerito nel 1981 che lo stress può essere pensato come il risultato di uno “squilibrio tra richieste e risorse” o che si verifica quando “la pressione supera la capacità percepita di farvi fronte”. La gestione dello stress è stata sviluppata e si basava sull’idea che lo stress non è una risposta diretta a un fattore di stress, ma piuttosto le proprie risorse e la capacità di farvi fronte mediano la risposta allo stress e sono suscettibili di cambiamento, consentendo così di controllare lo stress. [3]
Tra i tanti fattori di stress citati dai dipendenti, questi sono i più comuni:
- Conflitti in azienda
- Il modo in cui i dipendenti sono trattati dai loro capi/supervisori o dall’azienda
- Mancanza di sicurezza sul lavoro
- Politiche aziendali
- Colleghi che non fanno la loro giusta parte
- Aspettative poco chiare
- Povera comunicazione
- Controllo insufficiente sui compiti
- Retribuzione o benefici inadeguati
- Scadenze urgenti
- Troppo lavoro
- Lunghe ore
- Consumo di tempo
- Condizioni fisiche scomode
- Conflitti di relazione
- Colleghi che commettono errori di distrazione
- Trattare con clienti maleducati
- Mancanza di collaborazione
- Come l’azienda tratta i colleghi [4]
Al fine di sviluppare un efficace programma di gestione dello stress, è innanzitutto necessario identificare i fattori che sono centrali per una persona che controlla il proprio stress e identificare i metodi di intervento che mirano efficacemente a questi fattori. L’interpretazione dello stress di Lazarus e Folkman si concentra sulla transazione tra le persone e il loro ambiente esterno (noto come Modello Transazionale). Il modello sostiene che lo stress potrebbe non essere un fattore di stress se la persona non percepisce i fattori di stress come una minaccia, ma piuttosto come un fattore positivo o addirittura una sfida. Inoltre, se la persona possiede o può utilizzare adeguate capacità di coping , lo stress potrebbe non essere effettivamente un risultato o svilupparsi a causa dei fattori di stress. Il modello propone che si possa insegnare alle persone a gestire il proprio stress ea far fronte ai propri fattori di stress. Possono imparare a cambiare la loro prospettiva sui fattori di stress e fornire loro la capacità e la fiducia per migliorare la propria vita e gestire tutti i tipi di fattori di stress.
Realizzazione della salute/modello di salute innato
La realizzazione della salute/modello di salute innata dello stress si fonda anche sull’idea che lo stress non segue necessariamente la presenza di un potenziale fattore di stress. Invece di concentrarsi sulla valutazione dell’individuo dei cosiddetti fattori di stress in relazione alle proprie capacità di coping (come fa il modello transazionale), il modello di realizzazione della salute si concentra sulla natura del pensiero, affermando che in definitiva sono i processi di pensiero di una persona che determinare la risposta a circostanze esterne potenzialmente stressanti. In questo modello, lo stress deriva dal valutare se stessi e le proprie circostanze attraverso un filtro mentale di insicurezza e negatività, mentre una sensazione di benessere deriva dall’avvicinarsi al mondo con una “mente tranquilla”. [5] [6]
Questo modello propone che aiutare gli individui stressati a comprendere la natura del pensiero, in particolare fornendo loro la capacità di riconoscere quando sono in preda a un pensiero insicuro, liberarsene e accedere a sentimenti positivi naturali, ridurrà il loro stress.
tecniche
Livelli elevati di domanda caricano la persona con uno sforzo e un lavoro extra. Viene elaborato un nuovo programma orario e, fino a quando non è trascorso il periodo di domanda personale anormalmente elevata, la frequenza e la durata normali dei programmi precedenti sono limitate.
Molte di queste tecniche affrontano gli stress che si possono trovare a trattenere. Alcuni dei seguenti modi riducono temporaneamente un livello di stress più basso del normale per compensare i problemi biologici coinvolti; altri affrontano i fattori di stress a un livello di astrazione più elevato:
Le tecniche di gestione dello stress varieranno secondo il paradigma filosofico . [9] [10]
Prevenzione dello stress e resilienza
Sebbene siano state tradizionalmente sviluppate molte tecniche per affrontare le conseguenze dello stress, sono state condotte numerose ricerche anche sulla prevenzione dello stress, un argomento strettamente correlato alla costruzione della resilienza psicologica . Sono stati sviluppati numerosi approcci di auto-aiuto alla prevenzione dello stress e alla costruzione della resilienza, attingendo principalmente alla teoria e alla pratica della terapia cognitivo-comportamentale. [11]
Misurare lo stress
I livelli di stress possono essere misurati. Un modo è attraverso l’uso di test psicologici: la Holmes e Rahe Stress Scale [due scale di misurazione dello stress] viene utilizzata per valutare gli eventi della vita stressanti, mentre la DASS [Depression Anxiety Stress Scale] contiene una scala per lo stress basata sull’autovalutazione Oggetti. I cambiamenti nella pressione sanguigna e nella risposta galvanica della pelle possono anche essere misurati per testare i livelli di stress e i cambiamenti nei livelli di stress. Un termometro digitale può essere utilizzato per valutare i cambiamenti nella temperatura della pelle, che possono indicare l’attivazione della risposta di lotta o fuga che allontana il sangue dalle estremità. I modelli di rete neurale profonda che utilizzano dati di imaging fotopletismografico (PPGI) da fotocamere mobili possono misurare con precisione i livelli di stress. [12] Il cortisolo è il principale ormone rilasciato durante una risposta allo stress e la misurazione del cortisolo dai capelli fornirà un livello di stress di base di 60-90 giorni di un individuo. Questo metodo di misurazione dello stress è attualmente il metodo più diffuso in clinica.
Efficacia
La gestione dello stress ha benefici fisiologici e immunitari. [13]
Si osservano risultati positivi utilizzando una combinazione di interventi non farmacologici: [14]
Tipi di stress
Stress acuto
Lo stress acuto è la forma di stress più comune tra gli esseri umani in tutto il mondo.
Lo stress acuto ha a che fare con le pressioni del prossimo futuro o con il passato molto recente. Questo tipo di stress è spesso interpretato erroneamente come una connotazione negativa. Anche se questo è il caso in alcune circostanze, è anche una buona cosa avere uno stress acuto nella vita. La corsa o qualsiasi altra forma di esercizio è considerata un fattore di stress acuto. Alcune esperienze eccitanti o esilaranti come andare sulle montagne russe sono uno stress acuto ma di solito sono molto divertenti. Lo stress acuto è uno stress a breve termine e, di conseguenza, non ha abbastanza tempo per fare i danni causati dallo stress a lungo termine. [15]
Stress cronico
Lo stress cronico è diverso dallo stress acuto. Ha un effetto usurante sulle persone che può diventare un grave rischio per la salute se continua per un lungo periodo di tempo. Lo stress cronico può portare alla perdita di memoria , danneggiare il riconoscimento spaziale e produrre una diminuzione della spinta a mangiare. La gravità varia da persona a persona e anche la differenza di genere può essere un fattore sottostante. Le donne sono in grado di sopportare periodi di stress più lunghi rispetto agli uomini senza mostrare gli stessi cambiamenti disadattivi. Gli uomini possono affrontare una durata dello stress più breve meglio delle donne, ma una volta che i maschi raggiungono una certa soglia, le possibilità che sviluppino problemi mentali aumentano drasticamente. [16]
Topografia dello stress
Lo stress può essere generato da uno o più dei livelli identificati nel Modello “HPM” (Human Potential Modeling), adottato in UN Training of Blue Helmets [17] e diversi altri compiti relativi alle prestazioni. Questo Modello identifica sei tipi specifici di stress:
- stress bioenergetico o stress corporeo: richieste di attivazione corporea che vanno oltre i livelli personali di energia corporea a disposizione dell’individuo;
- stress psicoenergetico o “stress mentale”: situazioni in cui l’attività richiesta richiede un livello di motivazione che la persona non è in grado di raggiungere. Questi includono attività di resistenza e anche attività di “massimo rendimento”;
- Mancanza di “Micro-abilità”: abilità che possono fare la differenza nell’esito di una prestazione scadente vs. eccellente, come comprendere o non comprendere il linguaggio del corpo locale in una specifica cultura in cui si opererà
- Mancanza di “Macro-Skills”: scarsi livelli di conoscenza in ambiti in cui la performance richiederebbe un insieme aperto di conoscenze;
- Mancanza di capacità di Project-Management: difficoltà nel fissare obiettivi misurabili, tempistiche e delega delle responsabilità;
- Mancanza di valori o spiritualità, o in azienda, mancanza nel senso di missione e assenza di “visione”. [18]
Posto di lavoro
Tutti noi abbiamo una posizione nella società, sul posto di lavoro , all’interno della famiglia, nella situazione economica e così via. Sfortunatamente, la maggior parte di noi non è disposta ad accettare dove siamo. Invece, vorremmo essere da qualche altra parte, di solito in una posizione più alta. Gestire lo stress diventa vitale per mantenere alte le prestazioni lavorative e il rapporto con colleghi e datori di lavoro. [17] Per alcuni lavoratori, cambiare l’ambiente di lavoro allevia lo stress lavorativo. Rendere l’ambiente meno competitivo tra i dipendenti riduce alcune quantità di stress. Detto questo, lo stress sul posto di lavoro non deve essere sempre visto negativamente. Se gestito bene, lo stress può aumentare la concentrazione e la produttività dei dipendenti. Secondo la legge Yerkes Dodson, lo stress è benefico per il funzionamento umano, ma solo fino a un certo punto. Le persone che sperimentano livelli di stress troppo bassi potrebbero sentirsi sottostimolate e passive; le persone che soffrono di stress a livelli eccessivamente alti si sentirebbero sopraffatte, ansiose e irritabili. Pertanto, è fondamentale stabilire un livello ottimale di stress. [18]
I livelli di stress organizzativo che un individuo affronta dipendono non solo da fattori esterni come le caratteristiche del lavoro o l’ambiente, ma anche da fattori intrapersonali come la personalità, il temperamento e gli stili di pensiero e di coping individuali. Entrambi gli aspetti devono essere gestiti bene.
Alcuni esempi di fattori di stress sul posto di lavoro possono essere la loro percezione dell’impegno dell’organizzazione, che è il modo in cui un dipendente concettualizza le sue ragioni per rimanere nelle organizzazioni per motivi affettivi, di continuità o normativi. [19] L’ impegno affettivo nei confronti dell’organizzazione è l’ideale, poiché è la situazione in cui un dipendente si identifica fortemente con i valori e la cultura dell’organizzazione. Anche se questo non indica direttamente i livelli di stress di un dipendente, l’interesse e il piacere genuini per il lavoro e le relazioni di lavoro del dipendente lo collocano in una buona posizione per gestire bene lo stress. I dipendenti che rimangono in un’organizzazione per motivi di continuità rimangono in seguito alla valutazione dei pro e dei contro e quindi decidono che il costo opportunità di lasciare l’organizzazione è troppo alto. I dipendenti di questa categoria potrebbero sperimentare livelli moderati di stress, poiché le loro ragioni per restare sono guidate più da motivazioni esterne che interne. I dipendenti che rimangono per motivi normativi, tuttavia, hanno maggiori probabilità di sperimentare i livelli di stress più elevati, poiché questi sono i dipendenti che rimangono fuori dagli obblighi e dal dovere. [20]
Lo stipendio può anche essere una preoccupazione importante dei dipendenti. Lo stipendio può influenzare il modo in cui le persone lavorano perché possono mirare alla promozione e, di conseguenza, a uno stipendio più alto. Questo può portare a stress cronico. Le differenze culturali hanno anche dimostrato di avere alcuni effetti importanti sui problemi di gestione dello stress. I dipendenti dell’Asia orientale possono affrontare determinate situazioni di lavoro in modo diverso da come farebbe un dipendente del Nord America occidentale. [ citazione necessaria ]
Per gestire lo stress sul posto di lavoro, i datori di lavoro possono fornire programmi di gestione dello stress [21] come terapia , programmi di comunicazione e un programma di lavoro più flessibile. [22] Sono stati condotti molti studi che dimostrano i benefici delle pratiche di consapevolezza sul benessere soggettivo e sui risultati lavorativi. [23] La produttività, l’organizzazione e le prestazioni aumentano, mentre i tassi di esaurimento diminuiscono.
Ambiente medico
Nel 1999 è stato condotto uno studio sui livelli di stress nei medici di base e nei consulenti ospedalieri. Oltre 500 dipendenti medici hanno partecipato a questo studio condotto da RP Caplan. Questi risultati hanno mostrato che il 47% dei lavoratori ha ottenuto un punteggio elevato nel questionario per gli alti livelli di stress. Il 27% dei medici di base ha anche ottenuto un punteggio molto depresso. Questi numeri sono stati una sorpresa per il Dr. Caplan e hanno mostrato quanto sia allarmante il gran numero di operatori sanitari stressati a causa del loro lavoro. I livelli di stress dei manager non erano alti quanto i praticanti stessi. Una statistica che ha aperto gli occhi ha mostrato che quasi il 54% dei lavoratori soffriva di ansia mentre era in ospedale. Sebbene questa fosse una piccola dimensione del campione per gli ospedali di tutto il mondo, Caplan ritiene che questa tendenza sia probabilmente abbastanza accurata nella maggior parte degli ospedali. [24]
Programmi di gestione dello stress
Molte aziende oggi hanno iniziato a utilizzare programmi di gestione dello stress per i dipendenti che hanno difficoltà ad adattarsi allo stress sul posto di lavoro oa casa. Alcune aziende forniscono ai propri dipendenti attrezzature speciali che si adattano allo stress sul posto di lavoro, come diari da colorare [25] e gadget antistress. [26] Molte persone hanno riversato lo stress da casa nel loro ambiente di lavoro. Ci sono un paio di modi in cui le aziende oggi cercano di ridurre i livelli di stress dei propri dipendenti. Un modo è attraverso l’intervento individuale. Questo inizia monitorando i fattori di stress nell’individuo. Dopo aver monitorato le cause dello stress, il prossimo passo è attaccare quel fattore di stress e cercare di capire come alleviarli in qualsiasi modo. Lo sviluppo del supporto sociale è vitale nell’intervento individuale, stare con gli altri per aiutarti a far fronte si è dimostrato un modo molto efficace per evitare lo stress. Evitare del tutto i fattori di stress è il modo migliore per sbarazzarsi dello stress, ma è molto difficile da fare sul posto di lavoro. Il cambiamento dei modelli comportamentali può a sua volta aiutare a ridurre parte dello stress che viene messo anche sul lavoro.
I programmi di assistenza ai dipendenti possono includere programmi di consulenza interni sulla gestione dello stress. È stata condotta una ricerca valutativa sugli EAP che insegnano agli individui il controllo dello stress e le tecniche di inoculazione come il rilassamento, il biofeedback e la ristrutturazione cognitiva. Gli studi dimostrano che questi programmi possono ridurre il livello di eccitazione fisiologica associato allo stress elevato. I partecipanti che padroneggiano le tecniche comportamentali e cognitive per alleviare lo stress riportano meno tensione, meno disturbi del sonno e una migliore capacità di far fronte ai fattori di stress sul posto di lavoro. [27]
Un altro modo per ridurre lo stress sul lavoro è semplicemente modificare il carico di lavoro di un dipendente. Alcuni potrebbero essere troppo sopraffatti dal fatto che hanno così tanto lavoro da fare, o alcuni potrebbero anche avere così poco lavoro da non essere sicuri di cosa fare con se stessi al lavoro. Anche migliorare le comunicazioni tra i dipendenti sembra un approccio semplice, ma è molto efficace per aiutare a ridurre lo stress. A volte far sentire il dipendente come se fosse una parte più importante dell’azienda, ad esempio dandogli voce in situazioni più grandi dimostra che ti fidi di lui e apprezzi la sua opinione. Avere tutti i dipendenti che lavorano bene insieme è un fattore molto sottostante che può togliere gran parte dello stress sul posto di lavoro. Se i dipendenti si adattano bene insieme e si alimentano a vicenda, le possibilità di molto stress sono minime. Infine, cambiare le qualità fisiche del posto di lavoro può ridurre lo stress. Cambiare cose come l’illuminazione, la temperatura dell’aria, l’odore e la tecnologia aggiornata.
L’intervento si articola in tre fasi: primaria, secondaria, terziaria. Il primario si occupa di eliminare del tutto i fattori di stress. Il secondario si occupa di rilevare lo stress e capire come affrontarlo e migliorare le capacità di gestione dello stress. Infine, il terziario si occupa del recupero e della riabilitazione dello stress. Questi tre passaggi sono solitamente il modo più efficace per affrontare lo stress non solo sul posto di lavoro, ma nel complesso. [28]
Industria aeronautica
L’aviazione è un’industria ad alto stress , dato che richiede un alto livello di precisione in ogni momento. Livelli di stress cronicamente elevati possono in definitiva ridurre le prestazioni e compromettere la sicurezza. [29] Per essere efficaci, gli strumenti di misurazione dello stress devono essere specifici per l’industria aeronautica, dato il suo ambiente di lavoro unico e altri fattori di stress . [30] la misurazione dello stress nel settore dell’aviazione cerca di quantificare lo stress psicologico vissuto da aviatori , con l’obiettivo di rendere i miglioramenti necessari per aviatori di coping e capacità di gestione dello stress. [30]
Per misurare più precisamente lo stress, le molte responsabilità degli aviatori sono suddivise in “carichi di lavoro”. Questo aiuta a classificare l’ampio concetto di “stress” in base a fattori di stress specifici. [31] Inoltre, poiché carichi di lavoro diversi possono comportare fattori di stress unici, questo metodo può essere più efficace della misurazione dei livelli di stress nel loro insieme. Gli strumenti di misurazione dello stress possono quindi aiutare gli aviatori a identificare quali fattori di stress sono più problematici per loro e aiutarli a migliorare la gestione dei carichi di lavoro, la pianificazione delle attività e la gestione dello stress in modo più efficace.
Per valutare il carico di lavoro, è possibile utilizzare una serie di strumenti. I principali tipi di strumenti di misurazione sono:
- Misure basate sulle prestazioni;
- Misure soggettive , come i questionari a cui gli aviatori si rispondono; e
- Misure fisiologiche , come la misurazione della frequenza cardiaca. [30]
L’implementazione di strumenti di valutazione richiede tempo, strumenti di misurazione e software per la raccolta dei dati. [30]
Sistemi di misura
I sistemi di misurazione dello stress più comunemente utilizzati sono principalmente basati su scale di valutazione . Questi sistemi tendono ad essere complessi, contenenti più livelli con una varietà di sezioni, per tentare di catturare i numerosi fattori di stress presenti nell’industria aeronautica. Sistemi diversi possono essere utilizzati in diverse specialità operative.
- La scala di stress percepita (PSS) – La PSS è uno strumento soggettivo ampiamente utilizzato per misurare i livelli di stress. [32] Si compone di 10 domande e chiede ai partecipanti di valutare, su una scala a cinque punti, quanto si sono sentiti stressati dopo un determinato evento. Tutte e 10 le domande vengono sommate per ottenere un punteggio totale da 0 a 40. [33] Nell’industria aeronautica, ad esempio, è stato utilizzato con gli studenti di addestramento al volo per misurare lo stress che provavano dopo gli esercizi di addestramento al volo. [33]
- L’inventario delle abilità di coping – Questo inventario misura le abilità degli aviatori per far fronte allo stress. Questa è un’altra misura soggettiva, che chiede ai partecipanti di valutare, su una scala a cinque punti, la misura in cui usano otto abilità di coping comuni: [33] Abuso di sostanze , Supporto emotivo, Supporto strumentale (aiuto con cose tangibili, come la cura dei bambini, finanze o condivisione dei compiti), Riformulazione positiva (cambiare il proprio modo di pensare a un evento negativo e pensarlo invece come positivo), Autocolpa, Pianificazione, Umorismo e Religione. Il punteggio totale di un individuo indica la misura in cui utilizza abilità di coping efficaci e positive (come l’umorismo e il supporto emotivo); capacità di coping inefficaci e negative (come l’abuso di sostanze e il senso di colpa); e dove l’individuo potrebbe migliorare.
- La tecnica di valutazione del carico di lavoro soggettivo (SWAT) – SWAT è un sistema di valutazione utilizzato per misurare il carico di lavoro mentale percepito degli individui durante l’esecuzione di un’attività, come lo sviluppo di strumenti in un laboratorio, compiti aerei multitasking o la difesa aerea. [34] SWAT combina misurazioni e tecniche di scala per sviluppare una scala di valutazione globale.
Sistemi di segnalazione dello stress pilota
I primi sistemi di segnalazione dello stress pilota sono stati adattati e modificati da questionari e sondaggi psicologici esistenti. [35] I dati di queste indagini pilota-specifiche vengono quindi elaborati e analizzati attraverso un sistema o una scala incentrati sull’aviazione. I questionari pilota sono generalmente progettati per studiare lo stress lavorativo o lo stress domestico. [35] L’autovalutazione può essere utilizzata anche per misurare una combinazione di stress domestico, stress lavorativo e prestazioni percepite. Uno studio condotto da Fiedler, Della Rocco, Schroeder e Nguyen (2000) ha utilizzato la modifica di Sloan e Cooper del questionario Alkov per esplorare le percezioni degli aviatori della relazione tra i diversi tipi di stress. I risultati hanno indicato che i piloti ritenevano che le prestazioni fossero compromesse quando lo stress domestico si trasferiva sull’ambiente di lavoro. Il grado di stress domestico che si è trasferito sull’ambiente di lavoro era correlato in modo significativo e negativo agli elementi delle prestazioni di volo, come la pianificazione, il controllo e la precisione degli atterraggi. Il questionario è stato in grado di riflettere le percezioni retroattive dei piloti e l’accuratezza di queste percezioni. [36]
Nel 1982 Alkov, Borowsky e Gaynor iniziarono un questionario di 22 voci per gli aviatori della marina statunitense per verificare l’ ipotesi che strategie inadeguate di gestione dello stress contribuissero a incidenti di volo. [35] Il questionario è costituito da elementi relativi ai cambiamenti dello stile di vita e alle caratteristiche della personalità. Dopo aver completato il questionario, il gruppo di test viene diviso in due gruppi: “in colpa” con contrattempo e “non in colpa” in caso di contrattempo. Quindi, i questionari di questi due gruppi sono stati analizzati per esaminare le differenze. [37] Uno studio sui piloti di linee aeree commerciali britanniche, condotto da Sloan e Cooper (1986), ha intervistato 1.000 membri pilota della British Airline Pilots’ Association (BALPA). Hanno usato una versione modificata del questionario di Alkov, Borowsky e Gaynor per raccogliere dati sulle percezioni dei piloti della relazione tra stress e prestazioni. Essendo una misura soggettiva, i dati di questo studio si basavano sulle percezioni dei piloti e quindi si basano su quanto accuratamente ricordano le esperienze passate delle loro relazioni con lo stress. Nonostante si basi su percezioni e ricordi soggettivi, lo studio ha mostrato che i rapporti pilota sono degni di nota. [35]
Beck Depression Inventory (BDI) è un’altra scala utilizzata in molti settori, comprese le professioni della salute mentale, per lo screening dei sintomi depressivi . [38]
Parsa e Kapadia (1997) hanno utilizzato il BDI per esaminare un gruppo di 57 piloti di caccia dell’aeronautica statunitense che avevano effettuato operazioni di combattimento. [35] L’adattamento del BDI al settore dell’aviazione è stato problematico. Tuttavia, lo studio ha rivelato alcuni risultati inaspettati. I risultati hanno indicato che l’89% dei piloti ha riferito di insonnia; l’86% ha riferito irritabilità; 63%, insoddisfazione; 38%, colpa; e il 35%, perdita della libido . Il 50% di due squadroni e il 33% di un altro squadrone ha ottenuto un punteggio superiore a 9 sul BDI, suggerendo almeno bassi livelli di depressione. Tale misurazione può essere difficile da interpretare con precisione. [ perché? ]
Università
Il college può essere un periodo stressante per molti studenti, poiché si adattano a un ambiente nuovo e sconosciuto durante la transizione dall’adolescenza all’età adulta. Quasi l’80% degli studenti universitari riferisce di dover affrontare spesso lo stress quotidiano. [39] Le fonti di stress che influenzano i livelli di stress degli studenti universitari includono la famiglia e gli amici che sono spesso fisicamente più lontani, così come i cambiamenti nei modelli di comunicazione con questi individui. Anche le credenze di vecchia data (ad es. le credenze religiose) e le nuove opportunità per vari comportamenti (ad es. l’uso di alcol e droghe) sono importanti fattori influenti. Oltre a queste potenziali fonti di stress, gli studenti universitari devono anche affrontare richieste accademiche spesso rigorose. [40] Per gestire questo stress, gli studenti si affidano a molte strategie, tra cui il coping incentrato sui problemi e sulle emozioni. [41]
Le strategie incentrate sui problemi impiegano attività comportamentali orientate all’azione come la pianificazione, ad esempio. Le strategie incentrate sulle emozioni implicano l’espressione delle emozioni e spesso includono l’alterazione delle aspettative. Sebbene le strategie incentrate sui problemi si siano spesso trovate più efficaci delle strategie incentrate sulle emozioni, entrambe le categorie includono meccanismi di coping che riducono efficacemente gli impatti negativi dello stress. [42] [43]
Esistono diversi esempi pratici di strategie di coping incentrate sul problema o basate sull’approccio. In particolare, lo sviluppo delle capacità di gestione del tempo, l’evitare la procrastinazione e la definizione degli obiettivi sono associati alla riduzione dello stress. Queste abilità consentono agli studenti di dare priorità alle nuove responsabilità, lasciando loro più tempo per il sonno e le attività ricreative, che hanno dimostrato di ridurre lo stress. Inoltre, lavorare o mantenere abitudini di sonno sane aiuta le persone ad affrontare meglio gli alti livelli di stress. [44] [45]
Anche diverse strategie incentrate sulle emozioni si sono rivelate efficaci nel combattere lo stress. Le strategie di accomodamento che non cambiano direttamente il fattore di stress, ma piuttosto cambiano le proprie emozioni che circondano i fattori di stress, come il reframing positivo, sono ampiamente associate alla riduzione dello stress. [46] Anche strategie come trovare l’umorismo e scrivere un diario, in particolare il diario della gratitudine, sono efficaci. [47] [45]
Senza capacità di coping efficaci, gli studenti tendono a impegnarsi in comportamenti non sicuri come mezzo per cercare di ridurre lo stress che sentono. Strategie di coping inefficaci popolari tra gli studenti universitari includono bere eccessivamente, uso di droghe, consumo eccessivo di caffeina, ritiro dalle attività sociali, autolesionismo e disturbi alimentari. [39] Queste strategie inefficaci possono essere pericolose perché spesso diventano abituali, creano dipendenza e talvolta sono fatali. Ad esempio, quando gli studenti universitari si rivolgono al bere come un modo per affrontare lo stress, iniziano a bere quantità maggiori e più frequentemente, invece che solo occasionalmente con gli amici. [48] Questo può portare ad avvelenamento da alcol, dipendenza e altri comportamenti pericolosi. I problemi che creano questi metodi di coping possono causare più danni che benefici e spesso portano a più stress per lo studente. [49]
I ricercatori non hanno trovato differenze di genere significative riguardo al modo in cui uomini e donne usano strategie di coping incentrate sui problemi. Tuttavia, esiste una variazione di genere per quanto riguarda il coping incentrato sulle emozioni. Le donne tendono a utilizzare strategie di coping incentrate sulle emozioni più spesso degli uomini in media. Tuttavia, gli uomini riferiscono di utilizzare una strategia di coping incentrata sulle emozioni più spesso delle donne: il disimpegno mentale sotto forma di consumo di alcol. [43] Nel complesso, le donne riferiscono livelli di stress più elevati rispetto agli uomini, in particolare per le relazioni sociali, i problemi quotidiani, le finanze, lo stress autoimposto, la frustrazione e gli studi. [43] Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che le donne sono spesso più in sintonia con le proprie emozioni e sono più a loro agio nell’esprimere i propri sentimenti. [50]
Sebbene lo stress per gli studenti universitari sia parte dell’esperienza di transizione, ci sono molte strategie che gli studenti possono utilizzare per ridurre lo stress nelle loro vite e gestire gli impatti dello stress. Le abilità di gestione del tempo che comprendono la definizione degli obiettivi, la programmazione e il ritmo sono approcci efficaci per ridurre lo stress. Inoltre, gli studenti dovrebbero mantenere la loro salute fisica e mentale con un regolare esercizio fisico, un’alimentazione sana, buone abitudini di sonno e pratiche di consapevolezza. [51] Ci sono diversi servizi, come la consulenza e la terapia, a disposizione degli studenti a cui è possibile accedere sia all’interno che all’esterno del campus per supportare la gestione dello stress e il benessere generale degli studenti.
Guarda anche
Riferimenti
- ^ Cannone, W. (1939). La saggezza del corpo, 2a ed., NY: Norton Pubs.
- ^ Selye, H (1950). “Stress e la sindrome generale di adattamento” . fr. Med. J. 1 (4667): 1383-92. doi : 1136/bmj.1.4667.1383 . PMC 2038162 . PMID 15426759 .
- ^ Lazzaro, RS, & Folkman, S. (1984). Stress, valutazione e coping. New York: Springer.
- ^ Somaz, Wenk Heidi & Tulgan, Bruce (2003). Prestazioni sotto pressione: gestione dello stress sul posto di lavoro.Canada. HRD Press Inc. p 7-8. ISBN 0-87425-741-7
- ^ Mills, RC (1995). Realizzare la salute mentale: verso una nuova psicologia della resilienza. Sulzberger & Graham Publishing, Ltd. ISBN 0-945819-78-1
- ^ Sedgeman, JA (2005). “Realizzazione della salute/Salute innata: una mente tranquilla e uno stato emotivo positivo possono essere accessibili nel corso della vita senza tecniche di sollievo dallo stress?” . Med. Sci. Monit. 11 (12): HY47-52. PMID 16319796 .
- ^ Lehrer, Paul M.; David H. (FRW) Barlow, Robert L. Woolfolk, Wesley E. Sime (2007). Principi e pratica della gestione dello stress, terza edizione . pp. 46 -47. ISBN 978-1-59385-000-5 .
- ^ Leubner, D; Hinterberger, T (2017). “Revisione dell’efficacia degli interventi musicali nel trattamento della depressione” . Psicologo anteriore. 8 : 1109. doi : 3389/fpsyg.2017.01109 . PMC 5500733 . PMID 28736539 .
- ^ Soprannominato “Destressitizers” dal Journal of the Canadian Medical Association
- ^ Spence, JD; Barnet, Pennsylvania; tiglio, W; Ramsden, V; Taenzer, P (1999). “Modifiche dello stile di vita per prevenire e controllare l’ipertensione. 7. Raccomandazioni sulla gestione dello stress. Canadian Hypertension Society, Canadian Coalition for High Blood Pressure Prevention and Control, Laboratory Center for Disease Control at Health Canada, Heart and Stroke Foundation of Canada” . Giornale dell’Associazione Medica Canadese. 160 (9 Suppl): S46–50. PMC 1230339 . PMID 10333853 .
- ^ Robertson, D (2012). Costruisci la tua resilienza . Londra: Hodder. ISBN 978-1444168716 .
- ^ Al-Jebrni, Abdulrhman H.; Chwyl, Brendan; Wang, Xiao Yu; Wong, Alessandro; Saab, Bechara J. (maggio 2020). “Quantificazione obiettiva e remota dello stress su scala abilitata dall’intelligenza artificiale” . Elaborazione e controllo del segnale biomedico. 59 : 101929. doi : 1016/j.bspc.2020.101929 .
- ^ Bower, JE & Segerstrom, SC (2004). “Gestione dello stress, ricerca di benefici e funzione immunitaria: meccanismi positivi per effetti di intervento sulla fisiologia”. Giornale di ricerca psicosomatica. 56 (1): 9-11. doi : 1016/S0022-3999(03)00120-X . PMID 14987958 .
- ^ Wolfgang Linden; Joseph W. Lenz; Andrea H. Con (2001). “Gestione individualizzata dello stress per l’ipertensione primaria: uno studio randomizzato” . Arch Stagista Med. 161 (8): 1071–1080. doi : 1001/archinte.161.8.1071 . PMID 11322841 .
- ^ McGonagle, Katherine; Ronald Kessler (ottobre 1990). “Stress cronico, stress acuto, sintomi depressivi” (PDF) . Giornale americano di psicologia di comunità. 18 (5): 681-706. doi : 1007/BF00931237 . hdl : 2027.42/117092 . PMID 2075897 . S2CID 38713589 .
- ^ Bowman, Rachele; Beck, Kevin D; Luine, Victoria N (gennaio 2003). “Effetti dello stress cronico sulla memoria: differenze tra i sessi nelle prestazioni”. Ormoni e comportamento. 43 (1): 48-59. doi : 1016/S0018-506X(02)00022-3 . PMID 12614634 . S2CID 23133767 .
- ^ “Copia archiviata” . Archiviato dall’originale il 10/03/2016. Estratto 09/03/2016.
- ^ Yerkes, Robert M.; Dodson, John D. (novembre 1908). “La relazione tra forza dello stimolo e rapidità di formazione dell’abitudine” . Giornale di neurologia comparata e psicologia. 18 (5): 459–482. doi : 1002/cne.920180503 . ISSN 0092-7015 .
- ^ Michele, L. (1998). “Impegno sul posto di lavoro: teoria, ricerca e applicazione, di john p. meyer e natalie j. allen. (1997). mille querce, ca: salvia. 150 pp., 34,00 dollari di stoffa, 15,95 dollari di carta” . Sviluppo delle risorse umane trimestrale. 9 (3): 309-312. doi : 1002/hrdq.3920090309 . ISSN 1044-8004 .
- ^ [1]
- ^ “Risorsa di gestione dello stress sul posto di lavoro – OFAI” . www.ofai.co.uk. Archiviato dall’originale il 27/03/2016.
- ^ “Evitare lo stress indotto dal cambiamento sul posto di lavoro – Nordic Labor Journal” . www.nordiclabourjournal.org. Archiviato dall’originale il 24/08/2013.
- ^ Bhojani, Zahra; Kurucz, Elizabeth C. (2020), “Felicità sostenibile, benessere e consapevolezza sul posto di lavoro”, The Palgrave Handbook of Workplace Well-Being, Springer International Publishing, pp. 1–25, doi : 1007/978-3 -030-02470-3_52-1 , ISBN 978-3-030-02470-3
- ^ Caplan, RP (novembre 1994). “Stress, ansia e depressione in consulenti ospedalieri, medici di base e dirigenti sanitari senior” . BMJ. 309 (6964): 1261–1269. doi : 1136/bmj.309.6964.1261 . PMC 2541798 . PMID 7888846 .
- ^ “Diario antistress con pagine da colorare per adulti” . Archiviato dall’originale il 15/05/2017.
- ^ “20 gadget per aiutarti a combattere lo stress – Hongkiat Magazine” . 2016-07-14. Archiviato dall’originale il 17/02/2017.
- ^ Schultz&Schultz, D (2010). Psicologia e lavoro oggi. New York: Prentice Hall. P. 374.
- ^ Hardy, Sally (1998). Stress professionale: approcci personali e professionali. Regno Unito: Stanley Thornes ltd. pp. 18-43.
- ^ Woldring, Michael (1996-03-15). “Modulo Fattori Umani: Stress” (PDF) . Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea. 1 : 3-16. Archiviato (PDF) dall’originale il 22/12/2015.
- ^ Salta fino a: a b c d Lehrer, P; Karavidas, M; Lu, SE; Vaschillo, E; Vaschillo, B; Cheng, A (maggio 2010). “I dati cardiaci aumentano l’associazione tra l’autovalutazione e le valutazioni degli esperti del carico del compito e delle prestazioni del compito nelle attività del simulatore di volo: uno studio esplorativo”. Rivista internazionale di psicofisiologia. 76 (2): 80-7. doi : 1016/j.ijpsycho.2010.02.06 . PMID 20172000 .
- ^ Biondi, M; Picardi, A (1999). “Lo stress psicologico e la funzione neuroendocrina negli esseri umani: gli ultimi due decenni di ricerca”. Psicoterapia e Psicosomatica. 68 (3): 114-50. doi : 1159/000012323 . PMID 10224513 . S2CID 41340845 .
- ^ Langan-Fox, J; Sankey, M; Canty, JM (ottobre 2009). “Misurazione dei fattori umani per i futuri sistemi di controllo del traffico aereo”. Fattori umani. 51 (5): 595–637. doi : 1177/0018720809355278 . PMID 20196289 . S2CID 206409588 .
- ^ Salta a: a b c Kirschner, J; giovane, J; Fanjoy, R (2014). “Stress e coping in funzione del livello di esperienza negli studenti di volo collegiali” . Journal of Aviation Technology and Engineering. 3 (2): 14-19. doi : 7771/2159-6670.1092 .
- ^ Corwin, WH (1992-04-01). “Valutazione in volo e dopo il volo del carico di lavoro del pilota in velivoli da trasporto commerciale utilizzando la tecnica di valutazione del carico di lavoro soggettivo”. Il giornale internazionale di psicologia dell’aviazione. 2 (2): 77-93. doi : 1207/s15327108ijap0202_1 .
- ^ Salta a: a b c d e Young, James (dicembre 2008). Gli effetti dello stress vitale sulle prestazioni dei piloti (PDF) (Relazione). Centro di ricerca Ames della NASA. pp. 1-7. Archiviato (PDF) dall’originale il 05/03/2016.
- ^ Muller, Ronald; Andreas Wittmer; Christopher Drax, ed. (2014). Gestione del rischio e della sicurezza dell’aviazione: metodi e applicazioni nelle organizzazioni aeronautiche. Springer Internazionale. ISBN 978-3-319-02779-1 .
- ^ O’Connor, Paul E.; Cohn, Joseph V., ed. (2010). Miglioramento delle prestazioni umane in ambienti ad alto rischio: approfondimenti, sviluppi e direzioni future dalla ricerca militare. ABC-CLIO. ISBN 978-0-313-35983-5 .
- ^ Barralabc, C; Rodríguez-Cintasb, L; Martínez-Lunaabc, Nieves; Bachillerabc, D; et al. (2014-11-13). “Affidabilità del Beck Depression Inventory in pazienti dipendenti da oppiacei”. Journal of Substance Abuse: 1–6. doi : 3109/14659891.2014.980859 . S2CID 71642211 .
- ^ Salta a: a b Affronta lo stress dell’università a testa alta con questi suggerimenti per la gestione dello stress. (nd). Estratto da https://www.affordablecollegesonline.org/balancing-student-stress/
- ^ Zaleski, Ellen H.; Levey-Thors, Christina; Schiaffino, Kathleen M. (1998). “Meccanismi di coping, stress, supporto sociale e problemi di salute negli studenti universitari”. Scienza applicata dello sviluppo. 2 (3): 127-137. doi : 1207/s1532480xads0203_2 .
- ^ Dyson, R.; Renk, K. (2006). “Adattamento delle matricole alla vita universitaria: sintomi depressivi, stress e coping”. Giornale di psicologia clinica. 62 (10): 1231–1244. doi : 1002/jclp.20295 . PMID 16810671 .
- ^ Penley, JA; Tomaka, J.; Wiebe, JS (2002). “L’associazione del coping agli esiti di salute fisica e psicologica: una revisione meta-analitica”. Giornale di medicina comportamentale. 25 (6): 551–603. doi : 1023/a: 1020641400589 . PMID 12462958 . S2CID 27649585 .
- ^ Salta fino a: a b c Brougham, RR; Zail, CM; Mendoza, CM; Miller, JR (2009). “Stress, differenze di sesso e strategie di coping tra studenti universitari”. Psicologia attuale. 28 (2): 85-97. doi : 1007/s12144-009-9047-0 . S2CID 18784775 .
- ^ Welle, PD; Graf, HM (2011). “Abitudini di vita efficaci e strategie di coping per la tolleranza allo stress tra gli studenti universitari”. Giornale americano di educazione sanitaria. 42 (2): 96-105. doi : 1080/19325037.2011.10599177 . S2CID 17099952 .
- ^ Salta a: a b Gestire lo stress. (2018). Estratto da https://campusmindworks.org/help-yourself/self-care/managing-stress/
- ^ Carver, CS (2011). Il manuale della scienza dello stress: biologia, psicologia e salute. New York, NY: Springer Publishing Company. / Gestire lo stress. (2018). Estratto da https://campusmindworks.org/help-yourself/self-care/managing-stress/
- ^ Cheng, ST; Tsui, PK; Lam, JH (2015). “Migliorare la salute mentale negli operatori sanitari: studio controllato randomizzato di un intervento di gratitudine”. Giornale di consulenza e psicologia clinica. 83 (1): 177-86. doi : 1037/a0037895 . PMID 25222798 .
- ^ Nowak, L. (2018, 04 ottobre). Stress e consumo di alcol tra gli studenti universitari: quali sono i veri pericoli? Estratto da https://www.altamirarecovery.com/blog/stress-and-alcohol-use-among-college-students-what-are-the-real-dangers/
- ^ Università di Purdue globale. (2019, 05 marzo). La guida dello studente universitario alla gestione dello stress. Estratto da https://www.purdueglobal.edu/blog/student-life/college-students-guide-to-stress-management-infographic/
- ^ Corridoio, NC; Chipperfield, JG; Perry, RP; Ruthig, JC; Goetz, T. (2006). “Controllo primario e secondario nello sviluppo accademico: implicazioni di genere per lo stress e la salute negli studenti universitari”. Ansia, stress e coping. 19 (2): 189-210. doi : 1080/10615800600581168 . S2CID 13667123 .
- ^ Reggenti dell’Università del Michigan. (nd). Gestire lo stress. Estratto da https://campusmindworks.org/help-yourself/self-care/managing-stress/
Resilienza psicologica
La resilienza psicologica è la capacità di far fronte mentalmente o emotivamente a una crisi o di tornare rapidamente allo stato pre-crisi. [1] La resilienza esiste quando la persona utilizza “processi e comportamenti mentali per promuovere le risorse personali e proteggersi dai potenziali effetti negativi dei fattori di stress”. [2] In termini più semplici, la resilienza psicologica esiste nelle persone che sviluppano capacità psicologiche e comportamentali che consentono loro di rimanere calmi durante le crisi/caos e di superare l’incidente senza conseguenze negative a lungo termine.
Definizione
La resilienza è generalmente considerata un “adattamento positivo” dopo una situazione stressante o avversa. [3] Quando una persona è “bombardata dallo stress quotidiano , interrompe il suo senso di equilibrio interno ed esterno, presentando sfide e opportunità”. Tuttavia, i fattori di stress di routine della vita quotidiana possono avere impatti positivi che promuovono la resilienza. Non è ancora noto quale sia il corretto livello di stress per ogni individuo. Alcune persone possono gestire una maggiore quantità di stress rispetto ad altre. Secondo Germain e Gitterman (1996), lo stress è sperimentato nel corso della vita di un individuo in momenti di difficili transizioni della vita, che comportano cambiamenti evolutivi e sociali; eventi traumatici della vita, compreso il dolore e la perdita; e le pressioni ambientali, che comprendono la povertà e la violenza della comunità. [4] La resilienza è l’adattamento integrato degli aspetti fisici, mentali e spirituali in un insieme di circostanze “buone o cattive”, un senso coerente di sé che è in grado di mantenere compiti di sviluppo normativo che si verificano nelle varie fasi della vita. [5] Il Children’s Institute dell’Università di Rochester spiega che “la ricerca sulla resilienza è focalizzata sullo studio di coloro che si impegnano nella vita con speranza e umorismo nonostante perdite devastanti”. [6] È importante notare che la resilienza non riguarda solo il superamento di una situazione di profondo stress, ma anche l’uscita da tale situazione con un “funzionamento competente”. La resilienza consente a una persona di riprendersi dalle avversità come una persona rafforzata e più intraprendente. [5] Aaron Antonovsky nel 1979 ha affermato che quando un evento viene valutato come comprensibile (prevedibile), gestibile (controllabile) e in qualche modo significativo (spiegabile) è più probabile una risposta resiliente. [7] [8]
Processi
La resilienza psicologica è meglio intesa come un processo. Tuttavia, spesso si presume erroneamente che sia un tratto dell’individuo, un’idea più tipicamente definita “resilienza”. [9] La maggior parte delle ricerche ora mostra che la resilienza è il risultato della capacità degli individui di interagire con il loro ambiente e i processi che promuovono il benessere o li proteggono dall’influenza schiacciante dei fattori di rischio. [10]
È essenziale comprendere il processo o questo ciclo di resilienza. Quando le persone si trovano ad affrontare una condizione avversa, ci sono tre modi in cui possono affrontare le seguenti situazioni: [11]
- Eruttare di rabbia
- Implodi con emozioni negative travolgenti, diventi insensibile e diventi incapace di reagire
- Semplicemente arrabbiati per il cambiamento dirompente
Solo il terzo approccio promuove il benessere. È impiegato da persone resilienti, che si arrabbiano per lo stato di disturbo e quindi cambiano il loro modello attuale per far fronte al problema. Il primo e il secondo approccio portano le persone ad adottare il ruolo di vittima incolpando gli altri e rifiutando qualsiasi metodo di coping anche dopo la fine della crisi. Queste persone preferiscono reagire istintivamente, piuttosto che rispondere alla situazione. Coloro che rispondono alle condizioni avverse adattandosi tendono a far fronte, tornare indietro e fermare la crisi. Le emozioni negative comportano paura, rabbia, ansia, angoscia, impotenza e disperazione che riducono la capacità di una persona di risolvere i problemi che devono affrontare e indeboliscono la resilienza di una persona. Paure e preoccupazioni costanti indeboliscono il sistema immunitario delle persone e aumentano la loro vulnerabilità alle malattie. [12]
Questi processi includono strategie individuali di coping continuo o possono essere aiutati da un ambiente protettivo come buone famiglie , scuole, comunità e politiche sociali che rendono più probabile la resilienza. [13] In questo senso si parla di “resilienza” quando i “fattori protettivi” sono cumulativi. È probabile che questi fattori svolgano un ruolo più importante, maggiore è l’esposizione dell’individuo ai fattori di rischio cumulativo.
Critica
Come altri fenomeni psicologici, definendo stati psicologici e affettivi specifici in certi modi, ne conseguirà sempre una controversia sul significato. Il modo in cui viene definito il termine resilienza influisce sui focus della ricerca; definizioni diverse o insufficienti di resilienza porteranno a ricerche incoerenti sugli stessi concetti. La ricerca sulla resilienza è diventata più eterogenea nei suoi risultati e misure, convincendo alcuni ricercatori ad abbandonare del tutto il termine perché attribuito a tutti i risultati della ricerca in cui i risultati sono stati più positivi del previsto. [14]
C’è anche qualche disaccordo tra i ricercatori nel campo sul fatto che la resilienza psicologica sia un tratto del carattere o uno stato dell’essere. [15] La resilienza psicologica è stata anche definita concetto ecologico, che va dai livelli di interpretazione micro a macro. [16] Tuttavia, è generalmente accettato che la resilienza sia una risorsa costruibile. [16]
Recentemente ci sono state anche prove che la resilienza può indicare una capacità di resistere a un forte calo di altri danni anche se una persona sembra temporaneamente peggiorare. [17] [18]
Storia
La prima ricerca sulla resilienza è stata pubblicata nel 1973. Lo studio ha utilizzato l’ epidemiologia , che è lo studio della prevalenza della malattia, per scoprire i rischi ei fattori protettivi che ora aiutano a definire la resilienza. [19] Un anno dopo, lo stesso gruppo di ricercatori ha creato strumenti per esaminare i sistemi che supportano lo sviluppo della resilienza. [20]
Emmy Werner è stata una delle prime scienziate a usare il termine resilienza negli anni ’70. Ha studiato una coorte di bambini di Kauai , Hawaii . Kauai era piuttosto povero e molti dei bambini nello studio sono cresciuti con genitori alcolizzati o malati di mente. Molti dei genitori erano anche senza lavoro. [21] Werner ha notato che dei bambini cresciuti in queste situazioni dannose, due terzi hanno mostrato comportamenti distruttivi nella tarda adolescenza, come disoccupazione cronica, abuso di sostanze e nascite fuori dal matrimonio (nel caso di ragazze adolescenti ). Tuttavia, un terzo di questi giovani non ha mostrato comportamenti distruttivi. Werner chiamò quest’ultimo gruppo resiliente . [22] Pertanto, i bambini resilienti e le loro famiglie erano quelli che, per definizione, dimostravano tratti che consentivano loro di avere più successo rispetto ai bambini e alle famiglie non resilienti.
La resilienza è emersa anche come un importante argomento teorico e di ricerca dagli studi sui bambini con madri con diagnosi di schizofrenia negli anni ’80. [23] In uno studio del 1989, [24] i risultati hanno mostrato che i bambini con un genitore schizofrenico potrebbero non ottenere un livello appropriato di caregiving confortante, rispetto ai bambini con genitori sani, e che tali situazioni spesso hanno avuto un impatto dannoso sullo sviluppo dei bambini. D’altra parte, alcuni figli di genitori malati hanno prosperato bene ed erano competenti nel rendimento scolastico, e quindi hanno portato i ricercatori a compiere sforzi per comprendere tali risposte alle avversità.
Dall’inizio della ricerca sulla resilienza, i ricercatori si sono dedicati alla scoperta dei fattori protettivi che spiegano l’adattamento delle persone a condizioni avverse, come il maltrattamento, [25] eventi di vita catastrofici, [26] o la povertà urbana. [27] Il focus del lavoro empirico è stato quindi spostato per comprendere i processi protettivi sottostanti. I ricercatori si sforzano di scoprire come alcuni fattori (ad esempio il legame con la famiglia) possono contribuire a risultati positivi. [27]
Fattori correlati
Gli studi dimostrano che ci sono diversi fattori che sviluppano e sostengono la resilienza di una persona: [28]
- La capacità di fare piani realistici ed essere in grado di intraprendere i passi necessari per portarli a termine
- Fiducia nei propri punti di forza e capacità
- Capacità di comunicazione e problem solving
- La capacità di gestire impulsi e sentimenti forti
Tuttavia, questi fattori variano tra i diversi gruppi di età. Ad esempio, questi fattori tra gli anziani sono connessioni esterne, grinta, indipendenza, cura di sé, accettazione di sé, altruismo, esperienza di difficoltà, stato di salute e prospettiva positiva sulla vita. [29]
La resilienza è correlata negativamente con i tratti della personalità del nevroticismo e dell’emotività negativa, che rappresentano le tendenze a vedere e reagire al mondo come minaccioso, problematico e angosciante e a considerarsi vulnerabili. Le correlazioni positive stanno con i tratti della personalità di apertura ed emotività positiva, che rappresentano le tendenze a impegnarsi e affrontare il mondo con fiducia nel successo e un giusto valore per l’ autodeterminazione . [30]
Emozioni positive
Esistono ricerche significative nella letteratura scientifica sulla relazione tra emozioni positive e resilienza. Gli studi dimostrano che mantenere emozioni positive mentre si affrontano le avversità favorisce la flessibilità nel pensiero e nella risoluzione dei problemi. Le emozioni positive svolgono una funzione importante nella loro capacità di aiutare un individuo a riprendersi da esperienze e incontri stressanti. Detto questo, mantenere un’emotività positiva aiuta a contrastare gli effetti fisiologici delle emozioni negative . Inoltre facilita il coping adattivo, costruisce risorse sociali durature e aumenta il benessere personale. [31]
La formazione della percezione cosciente e il monitoraggio dei propri fattori socioemotivi è considerato un aspetto stabile delle emozioni positive. [32] Questo non vuol dire che le emozioni positive siano semplicemente un sottoprodotto della resilienza, ma piuttosto che provare emozioni positive durante esperienze stressanti può avere benefici adattivi nel processo di coping dell’individuo. [33] L’evidenza empirica di questa previsione deriva dalla ricerca su individui resilienti che hanno una propensione per strategie di coping che suscitano concretamente emozioni positive, come la ricerca di benefici e la rivalutazione cognitiva, l’umorismo, l’ottimismo e il coping focalizzato sugli obiettivi. Gli individui che tendono ad affrontare i problemi con questi metodi di coping possono rafforzare la loro resistenza allo stress allocando un maggiore accesso a queste risorse emotive positive. [34] Il sostegno sociale degli adulti premurosi ha incoraggiato la resilienza tra i partecipanti fornendo loro l’accesso alle attività convenzionali. [35]
Le emozioni positive non hanno solo esiti fisici ma anche fisiologici. Alcuni esiti fisiologici causati dall’umorismo includono miglioramenti nel funzionamento del sistema immunitario e aumenti dei livelli di immunoglobulina salivare A , un anticorpo del sistema vitale, che funge da prima linea di difesa del corpo nelle malattie respiratorie. [36] [37] Inoltre, altri risultati sulla salute includono un tasso di recupero degli infortuni più rapido e tassi di riammissione più bassi negli ospedali per anziani e riduzioni della degenza di un paziente in ospedale, tra molti altri benefici. È stato condotto uno studio sulle emozioni positive in individui resilienti ai tratti e sul tasso di recupero cardiovascolare a seguito di emozioni negative provate da quegli individui. I risultati dello studio hanno mostrato che gli individui resilienti ai tratti che provano emozioni positive hanno avuto un’accelerazione nella velocità di rimbalzo dall’attivazione cardiovascolare inizialmente generata da un’eccitazione emotiva negativa, ad esempio la frequenza cardiaca e simili. [33]
Si dice anche che il perdono svolga un ruolo nel predire la resilienza , tra i pazienti con dolore cronico (ma non la gravità del dolore). [38]
Supporto sociale
Molti studi mostrano che il fattore primario per lo sviluppo della resilienza è il supporto sociale. [39] [40] [41] Sebbene esistano molte definizioni contrastanti di supporto sociale, la maggior parte può essere pensata come il grado di accesso e l’uso di forti legami con altri individui che sono simili a se stessi. [42] Il sostegno sociale richiede non solo che tu abbia rapporti con gli altri, ma che questi rapporti comportino la presenza di solidarietà e fiducia , comunicazione intima e impegno reciproco [43] sia all’interno che all’esterno della famiglia . [40]
Negli studi militari è stato riscontrato che la resilienza dipende anche dal supporto del gruppo: la coesione e il morale dell’unità sono i migliori predittori della resilienza al combattimento all’interno di un’unità o di un’organizzazione. La resilienza è altamente correlata al supporto tra pari e alla coesione del gruppo. Le unità con un’elevata coesione tendono a sperimentare un minor tasso di crolli psicologici rispetto alle unità con bassa coesione e morale. L’elevata coesione e il morale migliorano le reazioni adattative allo stress. [44]
Altri fattori
È stato condotto uno studio tra professionisti di alto livello che cercano situazioni difficili che richiedono resilienza. La ricerca ha esaminato 13 persone di alto livello provenienti da varie professioni, tutte hanno sperimentato sfide sul posto di lavoro ed eventi negativi della vita nel corso della loro carriera, ma che sono state anche riconosciute per i loro grandi risultati nei rispettivi campi. I partecipanti sono stati intervistati sulla vita quotidiana sul posto di lavoro e sulle loro esperienze di resilienza e prosperità. Lo studio ha trovato sei principali predittori di resilienza: personalità positiva e proattiva, esperienza e apprendimento, senso di controllo, flessibilità e adattabilità, equilibrio e prospettiva e supporto sociale percepito. È stato anche riscontrato che i soggetti di alto livello si impegnano in molte attività non correlate al loro lavoro come dedicarsi agli hobby, esercitarsi e organizzare incontri con amici e persone care. [45]
Ulteriori fattori sono anche associati alla resilienza, come la capacità di fare piani realistici, avere fiducia in se stessi e un’immagine positiva di sé , [46] sviluppare abilità comunicative e la capacità di gestire sentimenti e impulsi forti . [47]
La disposizione temperamentale e costituzionale è considerata un fattore importante nella resilienza. È uno dei necessari precursori della resilienza insieme al calore nella coesione familiare e all’accessibilità dei sistemi di supporto prosociale. [48] Ci sono tre tipi di sistemi temperamentali che giocano un ruolo nella resilienza, sono il sistema appetitivo, il sistema difensivo e il sistema attentivo. [49]
Un altro fattore protettivo è legato alla moderazione degli effetti negativi dei rischi ambientali o di una situazione di stress al fine di indirizzare gli individui vulnerabili verso percorsi ottimistici, come il supporto sociale esterno. Più specificamente uno studio del 1995 ha distinto tre contesti per i fattori protettivi: [50]
- attributi personali, inclusi concetti di sé estroversi, brillanti e positivi;
- la famiglia, come avere stretti legami con almeno un membro della famiglia o un genitore emotivamente stabile; e
- la comunità, come ricevere supporto o consigli dai coetanei.
Inoltre, uno studio sugli anziani a Zurigo, in Svizzera, ha messo in luce il ruolo svolto dall’umorismo come meccanismo di coping per mantenere uno stato di felicità di fronte alle avversità legate all’età. [51]
Oltre alla suddetta distinzione sulla resilienza, la ricerca è stata dedicata anche alla scoperta delle differenze individuali nella resilienza. L’autostima , il controllo dell’ego e la resilienza dell’ego sono legati all’adattamento comportamentale. [52] Ad esempio, i bambini maltrattati che si sentono bene con se stessi possono elaborare situazioni di rischio in modo diverso attribuendo ragioni diverse agli ambienti che vivono e, quindi, evitare di produrre percezioni interiorizzate negative . Il controllo dell’Io è “la soglia o le caratteristiche operative di un individuo riguardo all’espressione o al contenimento” [53] dei suoi impulsi, sentimenti e desideri. La resilienza dell’ego si riferisce alla “capacità dinamica, di modificare il proprio livello modello di controllo dell’io, in entrambe le direzioni, in funzione delle caratteristiche della domanda del contesto ambientale” [54]
I bambini maltrattati che hanno sperimentato alcuni fattori di rischio (p. es., genitori single, istruzione materna limitata o disoccupazione familiare), hanno mostrato una minore resilienza dell’ego e intelligenza rispetto ai bambini non maltrattati. Inoltre, i bambini maltrattati hanno maggiori probabilità rispetto ai bambini non maltrattati di dimostrare problemi di comportamento distruttivo-aggressivo, ritirati e interiorizzati. Infine, l’ego-resilienza e l’autostima positiva erano predittori di un adattamento competente nei bambini maltrattati. [52]
Anche le informazioni demografiche (ad es. il genere) e le risorse (ad es. il supporto sociale) vengono utilizzate per prevedere la resilienza. L’esame dell’adattamento delle persone dopo il disastro ha mostrato che le donne erano associate a una minore probabilità di resilienza rispetto agli uomini. Inoltre, gli individui che erano meno coinvolti in gruppi e organizzazioni di affinità hanno mostrato meno resilienza. [55]
Alcuni aspetti delle religioni, della spiritualità o della consapevolezza possono, ipoteticamente, promuovere o ostacolare determinate virtù psicologiche che aumentano la resilienza. La ricerca non ha stabilito una connessione tra spiritualità e resilienza. Secondo la 4a edizione di Psicologia della religione di Hood, et al., “lo studio della psicologia positiva è uno sviluppo relativamente nuovo… virtù”. [56] In una revisione della letteratura sulla relazione tra religiosità/spiritualità e PTSD, tra i risultati significativi, circa la metà degli studi ha mostrato una relazione positiva e la metà ha mostrato una relazione negativa tra misure di religiosità/spiritualità e resilienza. [57] L’esercito degli Stati Uniti ha ricevuto critiche per aver promosso la spiritualità nel suo nuovo programma Comprehensive Soldier Fitness come un modo per prevenire il disturbo da stress post-traumatico, a causa della mancanza di dati di supporto conclusivi.
Modelli biologici
Tre importanti basi per la resilienza – fiducia in se stessi, autostima e concetto di sé – hanno tutte radici in tre diversi sistemi nervosi, rispettivamente, il sistema nervoso somatico , il sistema nervoso autonomo e il sistema nervoso centrale . [58]
La ricerca indica che, come il trauma, la resilienza è influenzata da modificazioni epigenetiche. L’aumento della metilazione del DNA del fattore di crescita Gdfn [ necessario chiarimento ] in alcune regioni del cervello promuove la resilienza allo stress, così come gli adattamenti molecolari della barriera ematoencefalica. [59]
I due principali neurotrasmettitori responsabili del buffering dello stress all’interno del cervello sono la dopamina e gli oppioidi endogeni, come evidenziato dalla ricerca attuale che mostra che gli antagonisti della dopamina e degli oppioidi aumentano la risposta allo stress sia nell’uomo che negli animali. [60] Le ricompense primarie e secondarie riducono la reattività negativa dello stress nel cervello sia nell’uomo che negli animali. [61] Si pensa che la relazione tra supporto sociale e resilienza allo stress sia mediata dall’impatto del sistema dell’ossitocina sull’asse ipotalamo-ipofisi-surrene . [62] “La resilienza, concettualizzata come un adattamento bio-psicologico positivo, ha dimostrato di essere un utile contesto teorico per comprendere le variabili per prevedere la salute e il benessere a lungo termine”. [63]
Costruire la resilienza
Nella terapia cognitivo comportamentale (CBT), costruire la resilienza è una questione di modificare consapevolmente comportamenti di base e schemi di pensiero. [64] Il primo passo è cambiare la natura del dialogo interiore. Il dialogo interiore è il monologo interno che le persone hanno che rafforzano le convinzioni sull’autoefficacia e l’autostima della persona. Per costruire la resilienza, la persona ha bisogno di eliminare il dialogo interiore negativo, come “Non ce la faccio” e “Non ce la faccio”, e di sostituirlo con un discorso interiore positivo, come “Posso farcela”. questo” e “Posso gestire questo”. Questo piccolo cambiamento nei modelli di pensiero aiuta a ridurre lo stress psicologico quando una persona deve affrontare una sfida difficile. Il secondo passo che una persona può compiere per costruire la resilienza è prepararsi alle sfide, alle crisi e alle emergenze. [65] Negli affari, la preparazione si crea creando piani di risposta alle emergenze, piani di continuità operativa e piani di emergenza. Per la preparazione personale, l’individuo può creare un cuscino finanziario per aiutare con le crisi economiche, può sviluppare reti sociali per aiutarlo durante le crisi personali e può sviluppare piani di risposta alle emergenze per la sua famiglia.
La resilienza viene anche rafforzata sviluppando capacità di coping efficaci per lo stress. [66] Le abilità di coping aiutano l’individuo a ridurre i livelli di stress, in modo che rimangano funzionali. Le abilità di coping includono l’uso della meditazione, dell’esercizio, della socializzazione e delle pratiche di cura di sé per mantenere un sano livello di stress, ma ci sono molti altri elenchi associati alla resilienza psicologica.
L’ American Psychological Association suggerisce “10 modi per costruire la resilienza”, [28] che sono:
- mantenere buoni rapporti con i familiari stretti, gli amici e gli altri;
- evitare di vedere crisi o eventi stressanti come problemi insopportabili;
- accettare circostanze che non possono essere modificate;
- sviluppare obiettivi realistici e muoversi verso di essi;
- intraprendere azioni decisive in situazioni avverse;
- cercare opportunità per la scoperta di sé dopo una lotta con la perdita;
- sviluppare la fiducia in se stessi;
- mantenere una prospettiva a lungo termine e considerare l’evento stressante in un contesto più ampio;
- mantenere una prospettiva di speranza, aspettandosi cose buone e visualizzando ciò che si desidera;
- prendersi cura della propria mente e del proprio corpo , esercitandosi regolarmente, prestando attenzione ai propri bisogni e sentimenti.
Il modello Besht di costruzione della resilienza naturale in una famiglia ideale con accesso positivo e supporto da parte di familiari e amici, attraverso la genitorialità, illustra quattro indicatori chiave. Sono:
- Educazione realistica
- Comunicazione efficace del rischio
- Positività e ristrutturazione di situazioni impegnative
- Costruire autoefficacia e robustezza
In questo modello, l’autoefficacia è la convinzione nella propria capacità di organizzare ed eseguire i corsi d’azione necessari per raggiungere gli obiettivi necessari e desiderati e la robustezza è un insieme di atteggiamenti correlati di impegno, controllo e sfida.
Sono stati sviluppati numerosi approcci di auto-aiuto alla costruzione della resilienza, attingendo principalmente alla teoria e alla pratica della CBT e della terapia razionale emotiva comportamentale (REBT). [67] Ad esempio, è stato dimostrato che un intervento cognitivo-comportamentale di gruppo, chiamato Penn Resiliency Program (PRP), favorisce vari aspetti della resilienza. Una meta-analisi di 17 studi PRP ha mostrato che l’intervento riduce significativamente i sintomi depressivi nel tempo. [68]
L’idea di “costruzione della resilienza” è discutibilmente in contrasto con il concetto di resilienza come processo, [69] poiché è usata per implicare che è una caratteristica sviluppabile di se stessi. [70] Coloro che vedono la resilienza come una descrizione del fare bene nonostante le avversità, vedono gli sforzi di “costruzione della resilienza” come un metodo per incoraggiare la resilienza. La biblioterapia , il monitoraggio positivo degli eventi e il miglioramento dei fattori di protezione psicosociale con risorse psicologiche positive sono altri metodi per la costruzione della resilienza. [71] In questo modo, l’aumento delle risorse di un individuo per far fronte o altrimenti affrontare gli aspetti negativi del rischio o delle avversità viene promosso, o costruisce, la resilienza. [72]
La ricerca contrastante rileva che le strategie per regolare e controllare le emozioni, al fine di migliorare la resilienza, consentono risultati migliori in caso di malattia mentale. [73] Mentre gli studi iniziali sulla resilienza sono nati con scienziati dello sviluppo che studiavano bambini in ambienti ad alto rischio, uno studio su 230 adulti con diagnosi di depressione e ansia che enfatizzavano la regolazione emotiva, ha dimostrato che ha contribuito alla resilienza nei pazienti. Queste strategie incentrate sulla pianificazione, sulla rivalutazione positiva degli eventi e sulla riduzione della ruminazione hanno contribuito a mantenere una sana continuità. [73] [ necessario chiarimento ] È stato riscontrato che i pazienti con una migliore resilienza producono risultati terapeutici migliori rispetto ai pazienti con piani di trattamento non focalizzati sulla resilienza, [73] fornendo potenziali informazioni per supportare interventi psicoterapeutici basati sull’evidenza che possono gestire meglio i disturbi mentali concentrandosi sul aspetto della resilienza psicologica.
Costruire la resilienza attraverso il linguaggio
Mentre il mondo si globalizza, l’ apprendimento delle lingue e la comunicazione hanno dimostrato di essere fattori utili per lo sviluppo della resilienza nelle persone che viaggiano, studiano all’estero, lavorano a livello internazionale o in coloro che si trovano come rifugiati in paesi in cui la loro lingua madre non è parlata.
La ricerca condotta dal British Council [74] lega una forte relazione tra lingua e resilienza nei rifugiati. La loro ricerca sul linguaggio per la resilienza condotta in collaborazione con istituzioni e comunità del Medio Oriente, dell’Africa, dell’Europa e delle Americhe afferma che fornire adeguati programmi di apprendimento dell’inglese e supporto per i rifugiati siriani costruisce la resilienza non solo nell’individuo, ma anche nella comunità ospitante . Le loro scoperte hanno riportato cinque modi principali attraverso i quali il linguaggio costruisce la resilienza: lingua madre e sviluppo dell’alfabetizzazione; accesso all’istruzione, alla formazione e all’occupazione; apprendimento insieme e coesione sociale; affrontare gli effetti del trauma sull’apprendimento; e costruire inclusività.
La ricerca sul linguaggio per la resilienza suggerisce che l’ulteriore sviluppo della lingua madre e dell’alfabetizzazione aiuta a creare le basi per un’identità condivisa. [74] Mantenendo la lingua madre, anche quando è sfollata, una persona non solo impara meglio a scuola, ma migliora la capacità di apprendere altre lingue. Ciò migliora la resilienza fornendo una cultura condivisa e un senso di identità che consente ai rifugiati di mantenere stretti rapporti con altri che condividono la loro identità e li prepara a tornare un giorno. Così l’identità non viene spogliata e persiste il senso di appartenenza.
L’accesso all’istruzione, alla formazione e alle opportunità di lavoro consente ai rifugiati di stabilirsi nel paese ospitante e offre maggiore facilità quando tentano di accedere alle informazioni, fare domanda per lavoro o scuola o ottenere documentazione professionale. [74] Garantire l’accesso all’istruzione o all’occupazione dipende in gran parte dalla competenza linguistica e sia l’istruzione che l’occupazione forniscono sicurezza e successo che migliorano la resilienza e la fiducia.
Imparare insieme incoraggia la resilienza attraverso la coesione sociale e le reti. Quando i rifugiati si impegnano in attività di apprendimento delle lingue con le comunità ospitanti, l’impegno e la comunicazione aumentano. [74] Sia il rifugiato che la comunità ospitante hanno maggiori probabilità di celebrare la diversità, condividere le proprie storie, costruire relazioni, impegnarsi nella comunità e sostenersi a vicenda. Questo crea un senso di appartenenza con le comunità ospitanti insieme al senso di appartenenza stabilito con altri membri della comunità di rifugiati attraverso la lingua madre.
Inoltre, i programmi linguistici e l’apprendimento delle lingue possono aiutare ad affrontare gli effetti del trauma fornendo un mezzo per discutere e comprendere. [74] I rifugiati sono più capaci di esprimere il loro trauma, compresi gli effetti della perdita, quando possono comunicare efficacemente con la loro comunità ospitante. Soprattutto nelle scuole, l’apprendimento delle lingue crea spazi sicuri attraverso la narrazione, che rafforza ulteriormente il comfort con una nuova lingua e può a sua volta portare a una maggiore resilienza.
Il quinto modo, costruire l’inclusività, è più focalizzato sulla fornitura di risorse. [74] Fornendo alle istituzioni o alle scuole più materiale didattico e culturale basato sulla lingua, la comunità ospitante può imparare meglio come rispondere al meglio ai bisogni della comunità di rifugiati. Questa risposta globale ai bisogni alimenta la maggiore resilienza dei rifugiati creando un senso di appartenenza e di comunità.
Inoltre, uno studio completato da Kate Nguyen, Nile Stanley, Laurel Stanley e Yonghui Wang mostra l’impatto della narrazione nella costruzione della resilienza. [75] Ciò si allinea con molti dei cinque fattori identificati dallo studio completato dal British Council, poiché sottolinea l’importanza di condividere esperienze traumatiche attraverso il linguaggio. Questo studio in particolare ha mostrato che coloro che sono stati esposti a più storie, da familiari o amici, avevano una visione più olistica delle difficoltà della vita ed erano quindi più resilienti, specialmente quando erano circondati da lingue straniere o tentavano di imparare una nuova lingua. [74] [75]
Altri programmi di sviluppo
Vedi anche: Istruzione compensativa
Il programma Head Start ha dimostrato di promuovere la resilienza. [76] Così è stato il programma Big Brothers Big Sisters , l’ Abecedarian Early Intervention Project , [77] [78] e programmi sociali per giovani con difficoltà emotive o comportamentali. [79]
Il programma di supporto e intervento per il comportamento positivo è un programma di successo basato sulla resilienza e informato sul trauma per studenti di età elementare con quattro componenti. [80] Questi quattro elementi includono rinforzi positivi come incoraggiare il feedback, comprendere che il comportamento è una risposta a bisogni insoddisfatti o una risposta di sopravvivenza, promuovere l’appartenenza, la padronanza e l’indipendenza e, infine, creare un ambiente per supportare lo studente attraverso strumenti sensoriali, mentali pause di salute e gioco. [81]
Tuesday’s Children , [82] un’organizzazione di servizi familiari che si è impegnata a lungo termine con le persone che hanno perso i propri cari a causa dell’11 settembre e del terrorismo in tutto il mondo, lavora per costruire la resilienza psicologica attraverso programmi come Mentoring e Project COMMON BOND, un’iniziativa di 8 giorni per la costruzione della pace e la leadership per adolescenti di età compresa tra 15 e 20 anni, provenienti da tutto il mondo, che sono stati direttamente colpiti dal terrorismo. [83]
Le organizzazioni militari testano il personale per verificare la capacità di funzionare in circostanze stressanti sottoponendolo deliberatamente a stress durante l’addestramento. Gli studenti che non mostrano la necessaria resilienza possono essere esclusi dalla formazione. Coloro che rimangono possono ricevere un corso di vaccinazione contro lo stress. Il processo si ripete man mano che il personale si candida per posizioni sempre più impegnative, come le forze speciali . [84]
Bambini
La resilienza nei bambini si riferisce a individui che stanno facendo meglio del previsto, data una storia che include rischi o esperienze avverse. Ancora una volta, non è un tratto o qualcosa che alcuni bambini semplicemente possiedono. Non esiste un “bambino invulnerabile” in grado di superare qualsiasi ostacolo o avversità che incontra nella vita e, in effetti, il tratto è abbastanza comune. [70] Tutti i bambini condividono l’unicità di un’educazione, esperienze che possono essere positive o negative. Le esperienze avverse dell’infanzia (ACE) sono eventi che si verificano nella vita di un bambino e che potrebbero portare a sintomi disadattivi come tensione, umore depresso, pensieri ripetitivi e ricorrenti ed evitamento. [85] [86] La resilienza psicologica per superare gli eventi avversi non è l’unica spiegazione del perché alcuni bambini sperimentano una crescita post-traumatica e altri no. [86] La resilienza è il prodotto di una serie di processi di sviluppo nel tempo, che hanno permesso ai bambini di sperimentare piccole esposizioni alle avversità o a una sorta di sfide appropriate all’età per sviluppare la padronanza e continuare a svilupparsi con competenza. [87] Questo dà ai bambini un senso di orgoglio personale e di autostima. [88]
La ricerca sui “fattori protettivi”, che sono caratteristiche dei bambini o situazioni che aiutano particolarmente i bambini nel contesto del rischio, ha aiutato gli scienziati dello sviluppo a capire cosa conta di più per i bambini resilienti. Due di questi che sono emersi ripetutamente negli studi sui bambini resilienti sono il buon funzionamento cognitivo (come l’autoregolazione cognitiva e il QI) e le relazioni positive (specialmente con adulti competenti, come i genitori). [89] I bambini che hanno fattori protettivi nella loro vita tendono a fare meglio in alcuni contesti rischiosi rispetto ai bambini senza fattori protettivi negli stessi contesti. Tuttavia, questa non è una giustificazione per esporre qualsiasi bambino al rischio. I bambini stanno meglio quando non sono esposti ad alti livelli di rischio o avversità.
Costruire in classe
I bambini resilienti all’interno degli ambienti di classe sono stati descritti come lavorare e giocare bene e mantenere alte aspettative, sono stati spesso caratterizzati utilizzando costrutti come locus of control , autostima, autoefficacia e autonomia . [90] Tutte queste cose lavorano insieme per prevenire i comportamenti debilitanti associati all’impotenza appresa .
Ruolo della comunità
Le comunità svolgono un ruolo enorme nel promuovere la resilienza. Il segno più chiaro di una comunità coesa e solidale è la presenza di organizzazioni sociali che garantiscono un sano sviluppo umano. [91] È improbabile che i servizi vengano utilizzati a meno che non vi sia una buona comunicazione al riguardo. I bambini che vengono ripetutamente ricollocati non beneficiano di queste risorse, poiché le loro opportunità di costruzione della resilienza e di partecipazione significativa alla comunità vengono rimosse ad ogni trasferimento. [92]
Ruolo della famiglia
Promuovere la resilienza nei bambini è favorito in ambienti familiari che siano premurosi e stabili, mantengano alte aspettative per il comportamento dei bambini e incoraggiano la partecipazione alla vita della famiglia. [93] La maggior parte dei bambini resilienti ha una forte relazione con almeno un adulto, non sempre un genitore, e questa relazione aiuta a diminuire il rischio associato alla discordia familiare. La definizione di resilienza genitoriale, come capacità dei genitori di fornire un livello di genitorialità competente e di qualità ai bambini, nonostante la presenza di fattori di rischio, ha dimostrato di essere un ruolo molto importante nella resilienza dei bambini. Comprendere le caratteristiche della genitorialità di qualità è fondamentale per l’idea di resilienza genitoriale. [63] Anche se il divorzio produce stress, la disponibilità di sostegno sociale da parte della famiglia e della comunità può ridurre questo stress e produrre risultati positivi. [94] Ogni famiglia che sottolinea il valore dei compiti assegnati, la cura dei fratelli o delle sorelle e il contributo del lavoro a tempo parziale nel sostegno alla famiglia aiuta a favorire la resilienza. [22] La ricerca sulla resilienza si è tradizionalmente concentrata sul benessere dei bambini, con un’attenzione accademica limitata ai fattori che possono contribuire alla resilienza dei genitori. [63]
Famiglie in povertà
Numerosi studi hanno dimostrato che alcune pratiche utilizzate dai genitori poveri aiutano a promuovere la resilienza all’interno delle famiglie. Questi includono frequenti manifestazioni di calore, affetto, supporto emotivo; aspettative ragionevoli per i bambini combinate con una disciplina diretta e non eccessivamente dura; routine e feste familiari; e il mantenimento di valori comuni in materia di denaro e tempo libero. [95] Secondo il sociologo Christopher B. Doob, “i bambini poveri che crescono in famiglie resilienti hanno ricevuto un sostegno significativo per fare bene quando entrano nel mondo sociale, a partire dai programmi di asilo nido e poi a scuola”. [96]
Bullismo
Articolo principale: Bullismo e intelligenza emotiva § Resilienza
Oltre a prevenire il bullismo , è anche importante considerare come gli interventi basati sull’intelligenza emotiva siano importanti nel caso in cui si verifichi il bullismo. Aumentare l’intelligenza emotiva può essere un passo importante nel tentativo di promuovere la resilienza tra le vittime. Quando una persona affronta stress e avversità, soprattutto di natura ripetitiva, la sua capacità di adattamento è un fattore importante per avere un esito più positivo o negativo. [97]
Uno studio del 2013 ha esaminato adolescenti che hanno illustrato la resilienza al bullismo e hanno riscontrato alcune interessanti differenze di genere, con una maggiore resilienza comportamentale riscontrata tra le ragazze e una maggiore resilienza emotiva riscontrata tra i ragazzi. Nonostante queste differenze, hanno ancora implicato risorse interne ed emotività negativa rispettivamente nell’incoraggiare o nell’essere negativamente associate alla resilienza al bullismo e hanno esortato a prendere di mira le abilità psicosociali come forma di intervento. [98] L’intelligenza emotiva è stata illustrata per promuovere la resilienza allo stress [99] e, come accennato in precedenza, la capacità di gestire lo stress e altre emozioni negative può prevenire che una vittima continui a perpetuare l’aggressività. [100] Un fattore importante nella resilienza è la regolazione delle proprie emozioni. [97] Schneider et al. (2013) hanno scoperto che la percezione emotiva era significativa nel facilitare una minore emotività negativa durante lo stress e la comprensione emotiva ha facilitato la resilienza e ha una correlazione positiva con l’affetto positivo. [99]
Formazione scolastica
Vedi anche: galleggiabilità accademica
Molti anni e fonti di ricerca indicano che ci sono alcuni fattori protettivi coerenti dei bambini piccoli nonostante le differenze di cultura e i fattori di stress (povertà, guerra, divorzio dei genitori, disastri naturali, ecc.):
- Genitori capaci
- Altre relazioni strette
- Intelligenza
- Autocontrollo
- Motivazione per avere successo
- Fiducia in se stessi e autoefficacia
- Fede, speranza, fede, la vita ha un significato
- Scuole efficaci
- Comunità efficaci
- Pratiche culturali efficaci [101]
Ann Masten conia questi fattori protettivi come “magia ordinaria”, i comuni sistemi adattativi umani che sono modellati dall’evoluzione biologica e culturale. Nel suo libro, Ordinary Magic: Resilience in Development , discute il ” paradosso degli immigrati “, il fenomeno secondo cui i giovani immigrati di prima generazione sono più resistenti dei loro figli. I ricercatori ipotizzano che “potrebbe esserci una resilienza basata sulla cultura che si perde con le generazioni successive man mano che si allontanano dalla loro cultura di origine”. Un’altra ipotesi è che coloro che scelgono di immigrare hanno maggiori probabilità di essere più resilienti. [102]
La ricerca di Rosemary Gonzalez e Amado M. Padilla sulla resilienza accademica degli studenti delle scuole superiori messicano-americane rivela che mentre il senso di appartenenza alla scuola è l’unico predittore significativo della resilienza accademica, un senso di appartenenza alla famiglia, un gruppo di pari e una cultura può anche indicare una maggiore resilienza accademica. “Sebbene la lealtà culturale in generale non fosse un predittore significativo di resilienza, alcune influenze culturali contribuiscono comunque a risultati resilienti, come il familismo e l’orgoglio e la consapevolezza culturale”. I risultati dello studio di Gonzalez e Padilla “indicano una relazione negativa tra l’orgoglio culturale e l’omogeneità etnica di una scuola”. Essi ipotizzano che “l’etnia diventa una caratteristica saliente e importante in contesti etnicamente più diversificati”. [103]
Considerando le implicazioni della ricerca di Masten, Gonzalez e Padilla, un forte legame con la propria identità culturale è un importante fattore protettivo contro lo stress ed è indice di una maggiore resilienza. Sebbene siano state create molte risorse aggiuntive in classe per promuovere la resilienza negli studenti in via di sviluppo, il modo più efficace per garantire la resilienza nei bambini è proteggere i loro sistemi di adattamento naturali dalla rottura o dal dirottamento. A casa, la resilienza può essere promossa attraverso un ambiente familiare positivo e pratiche e valori culturali enfatizzati. A scuola, questo può essere fatto assicurando che ogni studente sviluppi e mantenga un senso di appartenenza alla scuola attraverso relazioni positive con i compagni di classe e un insegnante premuroso. La ricerca sulla resilienza mostra costantemente che un senso di appartenenza, sia che si tratti di una cultura, di una famiglia o di un altro gruppo, predice molto la resilienza contro qualsiasi dato fattore di stress.
Situazioni specifiche [
Divorzio
Spesso il divorzio è visto come dannoso per la propria salute emotiva, ma gli studi hanno dimostrato che coltivare la resilienza può essere vantaggioso per tutte le parti coinvolte. Il livello di resilienza che un bambino sperimenterà dopo che i suoi genitori si sono separati dipende da variabili sia interne che esterne. Alcune di queste variabili includono il loro stato psicologico e fisico e il livello di supporto che ricevono dalle loro scuole, amici e amici di famiglia. [3] La capacità di affrontare queste situazioni deriva anche dall’età, dal sesso e dal temperamento del bambino. I bambini sperimenteranno il divorzio in modo diverso e quindi anche la loro capacità di far fronte al divorzio sarà diversa. Circa il 20-25% dei bambini “dimostrerà gravi problemi emotivi e comportamentali” durante il divorzio. [3] Questa percentuale è notevolmente superiore al 10% dei bambini che presentano problemi simili nelle famiglie sposate. [104] Nonostante ciò, circa il 75-80% di questi bambini “svilupperà in adulti ben adattati senza problemi psicologici o comportamentali duraturi”. Ciò dimostra che la maggior parte dei bambini dispone degli strumenti necessari per consentire loro di mostrare la capacità di recupero necessaria per superare il divorzio dei genitori.
Gli effetti del divorzio si estendono oltre la separazione di entrambi i genitori. Il conflitto residuo tra i genitori, i problemi finanziari e il ricongiungimento o il nuovo matrimonio dei genitori possono causare uno stress duraturo. [3] Gli studi condotti da Booth e Amato (2001) hanno dimostrato che non esiste alcuna correlazione tra il conflitto post-divorzio e la capacità del bambino di adattarsi alle proprie circostanze di vita. [104] D’altra parte, Hetherington (1999) ha completato la ricerca su questo stesso argomento e ha riscontrato effetti avversi nei bambini. [104] Per quanto riguarda la situazione finanziaria di una famiglia, il divorzio ha il potenziale per ridurre lo stile di vita dei figli. Il sostegno all’infanzia viene spesso fornito per aiutare a coprire i bisogni di base come l’istruzione. Se le finanze dei genitori sono già scarse, i loro figli potrebbero non essere in grado di partecipare ad attività extrascolastiche come sport e lezioni di musica, che possono essere dannose per la loro vita sociale.
Il ricongiungimento o il risposarsi possono portare ulteriori livelli di conflitto e rabbia nel loro ambiente domestico. Uno dei motivi per cui il ricongiungimento causa ulteriore stress è la mancanza di chiarezza nei ruoli e nelle relazioni; il bambino potrebbe non sapere come reagire e comportarsi con questa nuova figura di “genitore” nella sua vita. Nella maggior parte dei casi, portare un nuovo partner/coniuge sarà il più stressante se fatto poco dopo il divorzio. In passato, il divorzio era stato visto come un “evento singolo”, ma ora la ricerca mostra che il divorzio comprende molteplici cambiamenti e sfide. [104] Non sono solo i fattori interni a consentire la resilienza, ma i fattori esterni nell’ambiente sono fondamentali per rispondere alla situazione e adattarsi. Alcuni programmi come il Children’s Support Group di 14 settimane e il Children of Divorce Intervention Program possono aiutare un bambino a far fronte ai cambiamenti che si verificano in seguito a un divorzio. [105]
Disastri naturali
La resilienza dopo un disastro naturale può essere valutata in diversi modi. Può essere misurato a livello individuale, comunitario e fisico. Il primo livello, il livello individuale, può essere definito come ogni persona indipendente nella comunità. Il secondo livello, il livello comunitario, può essere definito come tutti coloro che abitano la località interessata. Infine, il livello fisico può essere definito come l’infrastruttura della località interessata. [106]
UNESCAP ha finanziato una ricerca su come le comunità mostrano resilienza a seguito di disastri naturali. [107] Hanno scoperto che, fisicamente, le comunità erano più resistenti se si univano e facevano della resilienza uno sforzo dell’intera comunità. [107] Il supporto sociale è fondamentale per un comportamento resiliente e, in particolare, per la capacità di mettere in comune le risorse. [107] Nel mettere in comune le risorse sociali, naturali ed economiche, hanno scoperto che le comunità erano più resilienti e in grado di superare i disastri molto più velocemente delle comunità con una mentalità individualista. [107]
Il World Economic Forum si è riunito nel 2014 per discutere della resilienza dopo i disastri naturali. Concludono che i paesi economicamente più solidi e con più individui con la capacità di diversificare i propri mezzi di sussistenza mostreranno livelli di resilienza più elevati. [108] Questo non è stato ancora studiato in modo approfondito, ma le idee portate avanti attraverso questo forum sembrano essere abbastanza coerenti con la ricerca già esistente. [108]
La ricerca indica che la resilienza a seguito di disastri naturali può essere prevista dal livello di emozione che un individuo ha sperimentato ed è stato in grado di elaborare all’interno e dopo il disastro. Coloro che impiegano stili emotivi di coping sono stati in grado di crescere dalle proprie esperienze e quindi aiutare gli altri. In questi casi, provare le emozioni era adattivo. Coloro che non si sono impegnati con le proprie emozioni e hanno impiegato stili di coping evitanti e soppressivi hanno avuto esiti di salute mentale peggiori dopo il disastro. [109]
Morte di un familiare
Sono state fatte poche ricerche sul tema della resilienza familiare a seguito della morte di un membro della famiglia. [110] Tradizionalmente, l’attenzione clinica al lutto si è concentrata sul processo di lutto individuale piuttosto che su quello del nucleo familiare nel suo insieme. La resilienza si distingue dal recupero come “capacità di mantenere un equilibrio stabile” [111] che è favorevole all’equilibrio, all’armonia e al recupero. Le famiglie devono imparare a gestire le distorsioni familiari causate dalla morte del membro della famiglia, cosa che può essere fatta riorganizzando le relazioni e modificando i modelli di funzionamento per adattarsi alla loro nuova situazione. [112] Esibire la resilienza sulla scia del trauma può attraversare con successo il processo di lutto senza conseguenze negative a lungo termine. [113]
Uno dei comportamenti più salutari mostrati dalle famiglie resilienti dopo un decesso è una comunicazione onesta e aperta. Questo facilita la comprensione della crisi. Condividere l’esperienza della morte può favorire un adattamento immediato ea lungo termine alla recente perdita di una persona cara. L’empatia è una componente cruciale della resilienza perché consente alle persone in lutto di comprendere altre posizioni, tollerare i conflitti ed essere pronti ad affrontare le differenze che possono sorgere. Un’altra componente cruciale della resilienza è il mantenimento di una routine che aiuta a legare insieme la famiglia attraverso contatti e ordine regolari. Il proseguimento dell’istruzione e il collegamento con i coetanei e gli insegnanti a scuola è un supporto importante per i bambini alle prese con la morte di un familiare. [114]
Impostazioni professionali
La resilienza è stata esaminata anche nel contesto del fallimento e delle battute d’arresto negli ambienti di lavoro. [115] [116] Rappresentando uno dei costrutti fondamentali del comportamento organizzativo positivo (Luthans, 2002), e dati ambienti di lavoro sempre più dirompenti ed esigenti, l’attenzione di studiosi e professionisti alla resilienza psicologica nelle organizzazioni è notevolmente aumentata. [117] [118] Questa ricerca ha evidenziato alcuni tratti della personalità, risorse personali (p. es., autoefficacia, equilibrio tra lavoro e vita privata, competenze sociali), atteggiamenti personali (p. es., senso dello scopo, impegno lavorativo), emozioni positive e lavoro risorse (ad es. supporto sociale, contesto organizzativo positivo) come potenziali facilitatori della resilienza sul posto di lavoro. [116]
Al di là degli studi sulla resilienza generale del luogo di lavoro, l’attenzione è stata rivolta al ruolo della resilienza in contesti innovativi . A causa degli elevati gradi di incertezza e complessità nel processo di innovazione, [119] [120] in questo contesto si verificano naturalmente spesso fallimenti e battute d’arresto. [121] Poiché tali fallimenti e battute d’arresto possono avere effetti forti e dannosi sulla motivazione e sulla volontà degli individui colpiti di assumersi dei rischi, la loro resilienza è essenziale per impegnarsi in modo produttivo in future attività innovative. Per tenere conto delle peculiarità del contesto dell’innovazione, era necessario un costrutto di resilienza specificamente allineato a questo contesto unico per affrontare la necessità di diagnosticare e sviluppare la resilienza degli innovatori per ridurre al minimo il costo umano del fallimento e delle battute d’arresto nell’innovazione. In quanto concettualizzazione specifica del contesto della resilienza, l’Innovator Resilience Potential (IRP) serve a questo scopo e cattura il potenziale per il funzionamento innovativo dopo l’esperienza del fallimento o delle battute d’arresto nel processo di innovazione e per la gestione delle battute d’arresto future. [122] Sulla base della teoria cognitiva sociale di Bandura , [123] si propone che l’IRP sia composto da sei componenti: autoefficacia, aspettativa di risultato, ottimismo, speranza, autostima e propensione al rischio. [122] Il concetto di IRP riflette quindi una prospettiva di processo sulla resilienza. Da un lato, in questo processo, l’IRP può essere visto come un antecedente di come una battuta d’arresto colpisce un innovatore. D’altra parte, l’IRP può essere visto come un esito del processo che, a sua volta, è influenzato dalla situazione di battuta d’arresto. [122] Recentemente è stata sviluppata e convalidata una scala di misurazione dell’IRP. [124]
Resilienza interculturale
Aree di differenza
C’è polemica sugli indicatori di un buon sviluppo psicologico e sociale quando la resilienza viene studiata attraverso culture e contesti diversi. [125] [126] [127] La Task Force dell’American Psychological Association sulla resilienza e la forza nei bambini neri e negli adolescenti, [128], ad esempio, osserva che potrebbero esserci abilità speciali che questi giovani e famiglie hanno che li aiutano a far fronte, compresa la capacità di resistere al pregiudizio razziale. [129] I ricercatori sulla salute indigena hanno mostrato l’impatto della cultura, della storia, dei valori comunitari e delle impostazioni geografiche sulla resilienza nelle comunità indigene. [130] Le persone che riescono a farcela possono anche mostrare “resilienza nascosta” [131] quando non si conformano alle aspettative della società su come qualcuno dovrebbe comportarsi (in alcuni contesti, può essere necessaria l’aggressività per far fronte, o può essere meno coinvolgimento emotivo protettivo in situazioni di abuso). [132]
Resilienza nelle comunità individualiste e collettiviste
Le culture individualiste , come quelle degli Stati Uniti, dell’Austria, della Spagna e del Canada, enfatizzano gli obiettivi, le iniziative e i risultati personali. L’indipendenza, l’autosufficienza e i diritti individuali sono molto apprezzati dai membri delle culture individualistiche. Le politiche economiche, politiche e sociali riflettono l’interesse della cultura per l’individualismo. La persona ideale nelle società individualiste è assertiva, forte e innovativa. Le persone in questa cultura tendono a descrivere se stesse in termini di tratti unici: “Sono analitico e curioso” (Ma et al. 2004). Comparativamente, in posti come Giappone, Svezia, Turchia e Guatemala, le culture collettiviste enfatizzano gli obiettivi di lavoro di gruppo e familiari. Le regole di queste società promuovono l’unità, la fratellanza e l’altruismo. Le famiglie e le comunità praticano la coesione e la cooperazione. La persona ideale nelle società collettiviste è affidabile, onesta, sensibile e generosa, che enfatizza le capacità intrapersonali. I collettivisti tendono a descrivere se stessi nei termini dei loro ruoli: “Sono un buon marito e un amico leale” (Ma et al. 2004) In uno studio sulle conseguenze del disastro sull’individualismo di una cultura, i ricercatori hanno reso operative queste culture identificando frasi indicative nella letteratura di una società. Le parole che hanno mostrato il tema dell’individualismo includono “capace, raggiungere, differire, possedere, personale, preferire e speciale”. Le parole che indicavano il collettivismo includono “appartenere, dovere, dare, armonia, obbedire, condividere, insieme”.
Differenze nella risposta ai disastri naturali
I disastri naturali minacciano di distruggere comunità, sfollare famiglie, degradare l’integrità culturale e diminuire il livello di funzionamento di un individuo. Il confronto delle reazioni della comunità individualista alle risposte della comunità collettivista dopo i disastri naturali illustra le loro differenze e i rispettivi punti di forza come strumenti di resilienza. Alcuni suggeriscono che i disastri riducano l’azione individuale e il senso di autonomia poiché rafforzano la necessità di fare affidamento su altre persone e strutture sociali. Pertanto, i paesi/regioni con una maggiore esposizione al disastro dovrebbero coltivare il collettivismo. Tuttavia, Withey (1962) e Wachtel (1968) hanno condotto interviste ed esperimenti sui sopravvissuti al disastro che hanno indicato che l’ansia e lo stress indotti dal disastro riducono l’attenzione sulle informazioni contestuali sociali – una componente chiave del collettivismo. In questo modo, i disastri possono portare a un aumento dell’individualismo.
Mauch e Pfister (2004) hanno messo in dubbio l’associazione tra indicatori socio-ecologici e cambiamento a livello culturale nell’individualismo. Nella loro ricerca, per ogni indicatore socio-ecologico, la frequenza dei disastri è stata associata a un maggiore (piuttosto che a un minore) individualismo. Analisi supplementari hanno indicato che la frequenza dei disastri era più strettamente correlata ai cambiamenti legati all’individualismo rispetto all’entità dei disastri o alla frequenza dei disastri qualificata dal numero di morti. Le pratiche di denominazione dei bambini sono un indicatore interessante del cambiamento. Secondo Mauch e Pfister (2004), l’urbanizzazione era collegata alla preferenza per l’unicità nelle pratiche di denominazione dei bambini con un ritardo di 1 anno, il secolarismo era collegato a cambiamenti individualisti nella struttura interpersonale in entrambi i ritardi e la prevalenza del disastro era collegata a una denominazione più unica. pratiche a entrambi i ritardi. Il secolarismo e la diffusione dei disastri hanno contribuito principalmente ai cambiamenti nelle pratiche di denominazione.
C’è una lacuna nella ricerca sul ripristino di emergenza che si concentra sulla psicologia e sui sistemi sociali, ma non affronta adeguatamente il networking interpersonale o la formazione e il mantenimento delle relazioni. Una teoria della risposta ai disastri sostiene che gli individui che utilizzano le reti di comunicazione esistenti se la passano meglio durante e dopo i disastri. Inoltre, possono svolgere ruoli importanti nel ripristino di emergenza prendendo iniziative per organizzare e aiutare gli altri a riconoscere e utilizzare le reti di comunicazione esistenti e coordinarsi con le istituzioni che di conseguenza dovrebbero rafforzare le relazioni con gli individui durante i periodi normali in modo che esistano sentimenti di fiducia durante quelli stressanti.
In senso collettivista, costruire comunità forti e autosufficienti, i cui membri si conoscono, conoscono i bisogni degli altri e sono consapevoli delle reti di comunicazione esistenti, sembra una difesa ottimale contro i disastri.
Nel confrontare queste culture, non c’è davvero modo di misurare la resilienza, ma si possono guardare le conseguenze collaterali di un disastro per un paese per misurarne la resilienza.
Resilienza collettivista
- tornare alla routine
- ricostruire le strutture familiari
- condivisione comune delle risorse
- espressione emotiva di dolore e perdita a un ascoltatore solidale
- trovare benefici dall’esperienza del disastro
Resilienza individualista:
- ridistribuzione di potere/risorse
- tornare alla routine
- espressione emotiva attraverso sistemi di supporto formali
- confronto del problema
- rimodellare la propria prospettiva dopo l’esperienza del disastro
Mentre le società individualistiche promuovono la responsabilità individuale per l’autosufficienza, la cultura collettivista definisce l’autosufficienza all’interno di un contesto comunitario interdipendente (Kayser et al. 2008). Anche dove l’individualismo è saliente, un gruppo prospera quando i suoi membri scelgono obiettivi sociali anziché personali e cercano di mantenere l’armonia e dove apprezzano il comportamento collettivista rispetto all’individualismo (McAuliffe et al. 2003).
Il concetto di resilienza nel linguaggio
Sebbene non tutte le lingue abbiano una traduzione diretta per la parola inglese “resilienza”, quasi ogni cultura e comunità a livello globale ha una parola che si riferisce a un concetto simile. Le differenze tra i significati letterali delle parole tradotte mostrano che esiste una comprensione comune di cosa sia la resilienza. Anche se una parola non si traduce direttamente in “resilienza” in inglese, trasmette un significato abbastanza simile al concetto e viene utilizzata come tale all’interno della lingua.
Se una parola specifica per resilienza non esiste in una lingua, i parlanti di quella lingua in genere assegnano una parola simile che insinua resilienza in base al contesto. Molte lingue usano parole che si traducono in “elasticità” o “rimbalzo”, che vengono utilizzate nel contesto per catturare il significato di resilienza. Ad esempio, una delle parole principali per “resilienza” in cinese si traduce letteralmente in “rimbalzo”, una delle parole principali per “resilienza” in greco si traduce in “rimbalzo” e una delle parole principali per “resilienza” in russo si traduce in “elasticità”, proprio come in tedesco . Tuttavia, questo non è il caso per tutte le lingue. Ad esempio, se un madrelingua spagnolo volesse dire “resilienza”, le sue due opzioni principali si traducono in “resistenza” e “difesa contro le avversità”. [133] Molte lingue hanno parole che si traducono meglio in “tenacia” o “grinta” meglio che in “resilienza”. Sebbene queste lingue potrebbero non avere una parola che si traduce esattamente in “resilienza”, nota che gli anglofoni usano spesso tenacia o grinta quando si riferiscono alla resilienza. Mentre una delle parole greche per “resilienza” si traduce in “rimbalzo”, un’altra opzione si traduce in “allegria”. Inoltre, l’ arabo ha una parola esclusivamente per resilienza, ma anche altre due espressioni comuni per trasmettere il concetto, che si traducono direttamente con “capacità di deflazione” o “reattività del corpo”, ma sono meglio tradotte come “forza d’impatto” e “resilienza”. del corpo” rispettivamente. D’altra parte, alcune lingue, come il finlandese , hanno creato parole per esprimere la resilienza in un modo che non può essere tradotto in inglese. In finlandese, la parola “sisu” potrebbe essere tradotta più da vicino con il significato di “grinta” in inglese, ma fonde i concetti di resilienza, tenacia, determinazione, perseveranza e coraggio in una parola che è persino diventata un aspetto della cultura finlandese e ha guadagnato il suo posto come nome per alcuni marchi finlandesi. [134]
Critica dell’applicazione
Brad Evans e Julian Reid criticano il discorso sulla resilienza e la sua crescente popolarità nel loro libro, Resilient Life . [135] Gli autori affermano che le politiche di resilienza possono porre l’onere della risposta ai disastri sugli individui piuttosto che sugli sforzi coordinati pubblicamente. Legato all’emergere del neoliberismo , del cambiamento climatico , dello sviluppo del terzo mondo e di altri discorsi, Evans e Reid sostengono che la promozione della resilienza distoglie l’attenzione dalla responsabilità del governo e verso l’auto-responsabilità e gli effetti psicologici salutari come la crescita post-traumatica.
Guarda anche
Riferimenti
- ^ de Terte, Ian; Stephens, Christine (2014). “Resilienza psicologica dei lavoratori nelle occupazioni ad alto rischio”. Stress e salute. 30 (5): 353-355. doi : 1002/smi.2627 . ISSN 1532-3005 . PMID 25476960 .
- ^ Robertson, Ivan T.; Cooper, Cary L.; Sarkar, Mustafa; Curran, Thomas (2015-04-25). “La formazione alla resilienza sul posto di lavoro dal 2003 al 2014: una revisione sistematica” (PDF) . Giornale di psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 88 (3): 533–562. doi : 1111/joop.12120 . ISSN 0963-1798 .
- ^ Salta a: a b c d Hopf SM (2010). “Rischio e resilienza nei bambini che affrontano il divorzio dei genitori” . Dartmouth Undergraduate Journal of Science.
- ^ Susan P. Kemp; James K. Whittaker; Elizabeth M. Tracy. Pratica persona-ambiente: l’ecologia sociale dell’aiuto interpersonale . Editori di transazioni. pagine 42+. ISBN 978-0-202-36784-2 .
- ^ Salta a: a b Richardson, Glenn E. (2002). “La metateoria della resilienza e della resilienza”. Giornale di psicologia clinica. 58 (3): 307-321. doi : 1002/jclp.10020 . ISSN 0021-9762 . PMID 11836712 .
- ^ Pedro-Carroll, Joanne (2005). “Promuovere la resilienza dei bambini all’indomani del divorzio: il ruolo dei programmi basati sull’evidenza per i bambini” (PDF) . Istituto per bambini, Università di Rochester . P. 4. Estratto il 30 marzo 2016.
- ^ Aaron Antonovsky (1979). Salute, stress e coping . Editori Jossey-Bass. ISBN 978-0-87589-412-6 .
- ^ Alan Carr (2004). Psicologia positiva: la scienza della felicità e le forze umane . Psicologia Press. pagine 213+. ISBN 978-1-58391-991-0 .
- ^ Masten, AS (1994). “Resilienza nello sviluppo individuale: adattamento di successo nonostante il rischio e le avversità”, pp. 3-25 in M. Wang & E. Gordon (a cura di), Rischio e resilienza nei centri urbani americani: sfide e prospettive . Hillsdale, NJ: Erlbaum, ISBN 080581325X .
- ^ Zautra, AJ, Hall, JS & Murray, KE (2010). “Resilienza: una nuova definizione di salute per le persone e le comunità”, pp. 3-34 in JW Reich, AJ Zautra e JS Hall (eds.), Manuale di resilienza degli adulti . New York: Guilford, ISBN 146250647X .
- ^ Sayedy, Sayed (31 luglio 2021). “Leadership resiliente: quali fattori supportano l’implementazione di strategie di comunicazione resiliente nelle istituzioni sociali?” . sayedy.com. Estratto 09/09/2021.
- ^ Siebert, Al (2005). Il vantaggio della resilienza , pp. 2-4. Editori Berrett-Koehler. ISBN 1576753298 .
- ^ Leadbeater, B., Dodgen, D. & Solarz, A. (2005). “La rivoluzione della resilienza: un cambio di paradigma per la ricerca e la politica”, pp. 47-63 in RD Peters, B. Leadbeater e RJ McMahon (a cura di), Resilienza nei bambini, nelle famiglie e nelle comunità: collegare il contesto alla pratica e alla politica . New York: Kluwer. ISBN 0306486555 .
- ^ Burt, KB; Paysnick, AA (2012). “Resilienza nella transizione verso l’età adulta”. Sviluppo e Psicopatologia. 24 (2): 493-505. doi : 1017/S0954579412000119 . PMID 22559126 . S2CID 13638544 .
- ^ Sì, Zeng Jie; Zhang, Zhang; Zhang, Xiao Ying; Tang, Ying; Chen, Peng; Liang, Mu Zi; Sole, Zhe; Yu, Yuan Liang (2020-02-06). “Stato o tratto? Misurare la resilienza mediante la teoria della generalizzabilità nel cancro al seno” . European Journal of Oncology Nursing. 46 : 101727. doi : 1016/j.ejon.2020.101727 . ISSN 1532-2122 . PMID 32339909 . S2CID 213249920 .
- ^ Salta a: a b Nuttman-Shwartz, Orit; Verde, Ohad (2021). “Verità sulla resilienza: punti di vista dei lavoratori della resilienza al trauma nei confronti della resilienza in situazioni traumatiche continue” . Giornale internazionale di gestione dello stress. 28 (1): 1–10. doi : 1037/str0000223 . ISSN 1573-3424 . S2CID 234034157 .
- ^ Ungar, M. (2004a). “Un discorso costruzionista sulla resilienza: molteplici contesti, molteplici realtà tra bambini e giovani a rischio”. Giovani e società. 35 (3): 341–365. doi : 1177/0044118X03257030 . S2CID 145514574 .
- ^ Werner, EE & Smith, RS (2001). Viaggi dall’infanzia alla mezza età: rischio, resilienza e recupero . Ithaca, NY: Cornell University Press, ISBN 0801487382 . [ pagina necessaria ]
- ^ Garmezy, N. (1973). “Competenza e adattamento nei pazienti schizofrenici adulti e nei bambini a rischio”, pp. 163-204 in Dean, SR (Ed.), Schizophrenia: The first ten Dean Award Lectures . NY: MSS Information Corp.
- ^ Garmezy, N.; Streitman, S. (1974). “Bambini a rischio: la ricerca degli antecedenti della schizofrenia. Parte 1. Modelli concettuali e metodi di ricerca” . Bollettino della schizofrenia. 1 (8): 14–90. doi : 1093/schbul/1.8.14 . PMID 4619494 .
- ^ Werner, EE (1971). I bambini di Kauai: uno studio longitudinale dal periodo prenatale all’età di dieci anni . Honolulu: University of Hawaii Press, ISBN 0870228609 .
- ^ Salta a: a b Werner, EE (1989). Vulnerabile ma invincibile: uno studio longitudinale su bambini e giovani resilienti . New York: McGraw-Hill, ISBN 0937431036 .
- ^ Masten, AS; Migliore, KM; Garmezy, N. (1990). “Resilienza e sviluppo: contributi dallo studio dei bambini che superano le avversità”. Sviluppo e Psicopatologia. 2 (4): 425-444. doi : 1017/S0954579400005812 .
- ^ Masten, AS (1989). “Resilienza nello sviluppo: implicazioni dello studio dell’adattamento di successo per la psicopatologia dello sviluppo”. In D. Cicchetti (Ed.), L’emergere di una disciplina: simposio di Rochester sulla psicopatologia dello sviluppo (Vol. 1, pp. 261-294). Hillsdale, NJ: Erlbaum, ISBN 0805805532 .
- ^ Cicchetti, D.; Rogosch, FA (1997). “Il ruolo dell’auto-organizzazione nella promozione della resilienza nei bambini maltrattati”. Sviluppo e Psicopatologia. 9 (4): 797-815. doi : 1017/S0954579497001442 . PMID 9449006 .
- ^ Fredrickson, BL; Tugade, MM; Waugh, CE; Larkin, GR (2003). “Uno studio prospettico sulla resilienza e le emozioni a seguito degli attacchi terroristici agli Stati Uniti dell’11 settembre 2002” . Giornale di personalità e psicologia sociale. 84 (2): 365-376. doi : 1037/0022-3514.84.2.365 . PMC 2755263 . PMID 12585810 .
- ^ Salta a: a b Luthar, SS (1999). Povertà e adattamento dei bambini. Newbury Park, CA: Sage, ISBN 0761905189 .
- ^ Salta a: a b American Psychological Association. (2014). La strada per la resilienza .
- ^ Kamalpour, Mostafa; Watson, Jason; Compra, Laurie (2020). “Come possono le comunità online supportare i fattori di resilienza tra gli anziani”. Rivista internazionale di interazione uomo-computer. 36 (14): 1342–1353. doi : 1080/10447318.2020.1749817 . S2CID 216158876 .
- ^ John W. Reich; Alex J. Zautra; John Stuart Hall (2012). Manuale di resilienza degli adulti . Guilford Press. P. 114. ISBN 978-1-4625-0647-7 .
- ^ Fredrickson, BL; Branigan, C. (2005). “Le emozioni positive ampliano la portata dei repertori di attenzione e pensiero-azione” . Cognizione ed emozione. 19 (3): 313-332. doi : 1080/02699930441000238 . PMC 3156609 . PMID 21852891 .
- ^ Fredrickson, Barbara L. (marzo 2001). “Il ruolo delle emozioni positive nella psicologia positiva” . Lo psicologo americano. 56 (3): 218-226. doi : 1037/0003-066x.56.3.218 . ISSN 0003-066X . PMC 3122271 . PMID 11315248 .
- ^ Salta a: a b Tugade, MM; Fredrickson, BL (2004). “Gli individui resilienti usano le emozioni positive per riprendersi da esperienze emotive negative” . Giornale di personalità e psicologia sociale. 86 (2): 320-333. doi : 1037/0022-3514.86.2.320 . PMC 3132556 . PMID 14769087 .
- ^ Ong, AD; Bergeman, CS; Bisconti, TL; Wallace, KA (2006). “Resilienza psicologica, emozioni positive e adattamento riuscito allo stress in età avanzata” . Giornale di personalità e psicologia sociale. 91 (4): 730-49. doi : 1037/0022-3514.91.4.730 . PMID 17014296 . S2CID 3080937 .
- ^ Lutero, Kate (2015). “Esame del supporto sociale tra i figli adulti di genitori incarcerati”. Relazioni familiari. 64 (4): 505-518. doi : 1111/fare.12134 .
- ^ Mahony, DL; Burroughs, WJ; Lippman, LG (2002). “Attributi percepiti della risata che promuovono la salute: un confronto intergenerazionale”. Il Giornale di Psicologia. 136 (2): 171-81. doi : 1080/00223980209604148 . PMID 12081092 . S2CID 41596525 .
- ^ Baker, KH; Minchoff, B.; Dillon, KM (1985). “Stati emotivi positivi e miglioramento del sistema immunitario”. L’International Journal of Psychiatry in Medicine. 15 (1): 13-18. doi : 2190/R7FD-URN9-PQ7F-A6J7 . PMID 4055243 . S2CID 1308205 .
- ^ “Il ruolo del perdono interpersonale nella resilienza e nella gravità del dolore nei pazienti con dolore cronico” . Sportello di ricerca. Estratto il 13/02/2020.
- ^ Terone, Linda; van Rensburg, Angelique (agosto 2018). “Resilienza nel tempo: imparare dagli adolescenti scolari che vivono in condizioni di disuguaglianza strutturale”. Giornale dell’adolescenza. 67 : 167-178. doi : 1016/j.adolescenza.2018.06.012 . ISSN 0140-1971 . PMID 29980070 . S2CID 49715217 .
- ^ Salta a: a b Abramo, Rut; Lien, Lars; Hanssen, Ingrid (2018-03-27). “Coping, resilienza e crescita post-traumatica tra le donne rifugiate eritree che vivono nei centri di accoglienza per asilo norvegesi: uno studio qualitativo”. Giornale internazionale di psichiatria sociale. 64 (4): 359-366. doi : 1177/0020764018765237 . ISSN 0020-7640 . PMID 29584520 . S2CID 4377728 .
- ^ Gagnon, Anita J.; Stewart, Donna E. (2013-11-13). “Resilienza nelle donne migranti internazionali a seguito della violenza associata alla gravidanza”. Archivi di salute mentale delle donne. 17 (4): 303-310. doi : 1007/s00737-013-0392-5 . ISSN 1434-1816 . PMID 24221406 . S2CID 22177086 .
- ^ Lin, Nan; Woelfel, Mary W.; Luce, Stephen C. (settembre 1985). “L’effetto tampone del supporto sociale dopo un importante evento della vita”. Giornale di salute e comportamento sociale. 26 (3): 247-63. doi : 2307/2136756 . ISSN 0022-1465 . JSTOR 2136756 . PMID 4067240 .
- ^ Perlin, L. (1981). “Il processo dello stress” . Giornale di salute e comportamento sociale. 22 (4): 337-356. doi : 2307/2136676 . JSTOR 2136676 . PMID 7320473 . S2CID 5162220 .
- ^ Dipartimento dell’Esercito (2009). Manuale da campo n. 6-22.5. Manuale di controllo dello stress operativo e di combattimento per leader e soldati. Dipartimento della sede dell’esercito, Washington, DC, 18 marzo 2009. p. 32.
- ^ Sarkar, M.; Fletcher, D. (2014). “Magia ordinaria, prestazioni straordinarie: resilienza psicologica e prosperità negli alti risultati” (PDF) . Psicologia dello sport, dell’esercizio e della performance. 3 : 46–60. doi : 1037/spy0000003 .
- ^ Olmo, Jessica (giugno 2016). ” ” Sono in questo mondo per una ragione”: resilienza e recupero tra le donne bi-spirito indiane d’America e native dell’Alaska” . Giornale di studi lesbici. 20 (3-4): 352-371. doi : 1080/10894160.2016.1152813 . PMC 6424359 . PMID 27254761 .
- ^ “APA – Fattori e strategie di resilienza” (PDF) . unc.edu. Estratto il 16/09/2010.
- ^ Masten, AS & Reed, MG (2002). “Resilienza nello sviluppo” . In CR Snyder & SJ Lopez (a cura di), Manuale di psicologia positiva (pp. 74-88). Londra: Oxford University Press.
- ^ Derryberry, Douglas; Reed, Marjorie A.; Pilkenton-Taylor, Carolyn (14 novembre 2003). “Temperamento e coping: vantaggi di una prospettiva delle differenze individuali” . Sviluppo e Psicopatologia. 15 (4): 1049–1066. doi : 1017/s0954579403000439 . ISSN 0954-5794 . PMID 14984137 . S2CID 18226488 .
- ^ Werner, EE (1995). “Resilienza nello sviluppo”. Direzioni attuali nelle scienze psicologiche. 4 (3): 81-85. doi : 1111/1467-8721.ep10772327 . S2CID 143879633 .
- ^ Ruch, W.; Proyer, RT; Weber, M. (2009). “L’umorismo come forza caratteriale tra gli anziani” (PDF) . Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie. 43 (1): 13-18. doi : 1007/s00391-009-0090-0 . PMID 20012063 . S2CID 25341461 .
- ^ Salta a: a b Cicchetti, D.; Rogosch, FA; Lynch, M.; Holt, KD (1993). “Resilienza nei bambini maltrattati: processi che portano a risultati adattivi”. Sviluppo e Psicopatologia. 5 (4): 629-647. doi : 1017/S0954579400006209 .
- ^ Blocco, JH & Blocco, J. (1980). “Il ruolo dell’ego-controllo e dell’ego-resilienza nell’organizzazione del comportamento”. In WA Collins (Ed.), Sviluppo della cognizione, dell’affetto e delle relazioni sociali: Minnesota Symposia on Child Psychology (Vol. 13, p. 43). Hillsdale, NJ: Erlbaum, ISBN 089859023X .
- ^ Blocco, JH & Blocco, J. (1980). “Il ruolo dell’ego-controllo e dell’ego-resilienza nell’organizzazione del comportamento”. In WA Collins (a cura di), Sviluppo della cognizione, dell’affetto e delle relazioni sociali: Minnesota Symposia on Child Psychology (Vol. 13, p. 48). Hillsdale, NJ: Erlbaum, ISBN 089859023X .
- ^ Bonanno, GA; Galea, S.; Bucciareli, A.; Vlahov, D. (2007). “Cosa prevede la resilienza psicologica dopo il disastro? Il ruolo della demografia, delle risorse e dello stress della vita”. Giornale di consulenza e psicologia clinica. 75 (5): 671–682. doi : 1037/0022-006X.75.5.671 . hdl : 2027.42/56241 . PMID 17907849 .
- ^ Hood, R., Hill, P., Spilka, B., (2009) La psicologia della religione, 4a edizione: un approccio empirico . New York: The Guilford Press, ISBN 1606233920 .
- ^ Peres, J.; Moreira-Almeida, A.; Nasello, A.; Koenig, H. (2007). “Spiritualità e resilienza nelle vittime di traumi”. Giornale di religione e salute. 46 (3): 343-350. doi : 1007/s10943-006-9103-0 . S2CID 10875524 .
- ^ Siebert, Al (2005). Il vantaggio della resilienza , pp. 74-78. Editori Berrett-Koehler. ISBN 1576753298 .
- ^ Dudek, Katarzyna Anna; Kaufmann, Fernanda Neutzling; Lavoie, Olivier; Menard, Carolina (2020-11-02). “Meccanismi epigenetici di resilienza indotti da stress centrali e periferici” . Opinione attuale in psichiatria. 34 (1): 1–9. doi : 1097/YCO.0000000000000664 . ISSN 1473-6578 . PMID 33141775 . S2CID 226249341 .
- ^ Cabib, Simona; Puglisi-Allegra, Stefano (gennaio 2012). “La dopamina mesoaccumbens nell’affrontare lo stress” . Recensioni di neuroscienze e biocomportamentali. 36 (1): 79-89. doi : 1016/j.neubiorev.2011.04.012 . ISSN 0149-7634 . PMID 21565217 . S2CID 1614115 .
- ^ Olandese, Janine M.; Creswell, J. David (dicembre 2018). “Il ruolo dei percorsi di ricompensa del cervello nella resilienza allo stress e nella salute” . Recensioni di neuroscienze e biocomportamentali. 95 : 559-567. doi : 1016/j.neubiorev.2018.10.014 . ISSN 0149-7634 . PMID 30477985 . S2CID 53719739 .
- ^ Ozbay, F; Fitterling, H; Charney, D; Southwick, S (2008). “Sostegno sociale e resilienza allo stress nel corso della vita : un quadro neurobiologico”. Rapporti psichiatrici attuali. 10 (4): 304-10. doi : 1007/s11920-008-0049-7 . PMID 18627668 . S2CID 34039857 .
- ^ Salta a: a b c Gavidia-Payne, S.; Denny, B.; Davis, K.; Francesco, A.; Jackson, M. (2015). “Resilienza dei genitori: un costrutto trascurato nella ricerca sulla resilienza”. Psicologo clinico. 19 (3): 111-121. doi : 1111/cp.12053 .
- ^ Padesky, Christine A.; Mooney, Kathleen A. (2012-06-01). “Terapia cognitivo-comportamentale basata sui punti di forza: un modello in quattro fasi per costruire la resilienza” . Psicologia clinica e psicoterapia. 19 (4): 283-290. doi : 1002/cpp.1795 . ISSN 1063-3995 . PMID 22653834 .
- ^ Bergman, Megan Mayhew (24 gennaio 2019). “Perché le persone nel sud degli Stati Uniti restano di fronte al cambiamento climatico” . Il guardiano. Estratto il 3 febbraio 2019.
- ^ Chua, Li Wen; Milfon, Taciano L.; Jose, Paul E. (2014-11-27). “Le abilità di coping aiutano a spiegare come gli adolescenti orientati al futuro acquisiscono maggiore benessere nel tempo”. Giornale della gioventù e dell’adolescenza. 44 (11): 2028-2041. doi : 1007/s10964-014-0230-8 . ISSN 0047-2891 . PMID 25427783 . S2CID 28229478 .
- ^ Robertson, D (2012). Costruisci la tua resilienza . Londra: Hodder. ISBN 978-1444168716 .
- ^ Brunwasser SM, Gillham JE, Kim ES (2009). “Una revisione meta-analitica dell’effetto del Penn Resiliency Program sui sintomi depressivi” . Giornale di consulenza e psicologia clinica. 77 (6): 1042–1054. doi : 1037/a0017671 . PMC 4667774 . PMID 19968381 .
- ^ Rutter, M. (2008). “Concetti in via di sviluppo in psicopatologia dello sviluppo”, pp. 3-22 in JJ Hudziak (ed.), Psicopatologia dello sviluppo e benessere: influenze genetiche e ambientali . Washington, DC: American Psychiatric Publishing, ISBN 1585622796 .
- ^ Salta a: a b Masten, AS (2001). “Magia ordinaria: processi di resilienza in sviluppo” . Psicologa americana. 56 (3): 227-238. doi : 1037/0003-066X.56.3.227 . PMID 11315249 . S2CID 19940228 .
- ^ Yates, TM, Egeland, B., & Sroufe, LA (2003). “Ripensare la resilienza: una prospettiva del processo di sviluppo”, pp. 234-256 in SS Luthar (a cura di), Resilienza e vulnerabilità: adattamento nel contesto delle avversità dell’infanzia . New York: Cambridge University Press, ISBN 0521001617
- ^ Shastri, PC (2013). “Resilienza: costruire l’immunità in psichiatria” . Psichiatria J indiana. 55 (3): 224-234. doi : 4103/0019-5545.117134 . PMC 3777343 . PMID 24082242 .
- ^ Salta fino a: a b c Min, JA; Yu, JJ; Lee, CU; Chae, JH (2013). “Strategie di regolazione cognitiva delle emozioni che contribuiscono alla resilienza nei pazienti con depressione e/o disturbi d’ansia”. Psichiatria globale. 54 (8): 1190-7. doi : 1016/j.comppsych.2013.05.008 . PMID 23806709 .
- ^ Salta a: a b c d e f g Capstick, T (2016). “Lingua per la resilienza: il ruolo della lingua nel potenziare la resilienza dei rifugiati siriani e delle comunità ospitanti, con una prefazione dell’UNHCR” (PDF) . Consiglio Britannico.
- ^ Salta a: a b Kate Nguyen; Nilo Stanley; Laurel Stanley; Yonghui Wang (2015). “Resilienza negli studenti di lingue e il rapporto con lo storytelling” . Educazione convincente. 2 : 991160. doi : 1080/2331186X.2014.991160 .
- ^ Werner, EE (1997). “Il valore della ricerca applicata per Head Start: prospettiva interculturale e longitudinale”. Trimestrale di ricerca NHSA. 1 : 15-24. doi : 1207/s19309325nhsa0101_2 .
- ^ “Progetto Abecedarian (assistenza all’infanzia/scuola materna di alta qualità per bambini provenienti da ambienti svantaggiati)” . evidencebasedprograms.org. Archiviato dall’originale il 12 marzo 2005.
- ^ “Il progetto Carolina Abecedarian” . Fpg.unc.edu. 2007-05-22. Archiviato dall’originale il 28/08/2010. Estratto il 16/09/2010.
- ^ Sinclair, Mary F.; Christenson, Sandra L.; Thurow, Martha L. (2005). “Promuovere il completamento scolastico dei giovani urbani secondari con disabilità emotive o comportamentali” (PDF) . Bambini eccezionali. 71 (4): 465–482. doi : 1177/001440290507100405 . S2CID 143147646 .
- ^ “PBIS nelle scuole focalizzate sulla resilienza informate sui traumi” . Starr Commonwealth. 2020-06-18. Estratto 07/12/2020.
- ^ “Positive Behavioral Interventions and Supports (PBIS)” , SpringerReference, Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, 2011, doi : 1007/springerreference_70073 , recuperato 07/12/2020
- ^ “I bambini di martedì” . www.tuesdayschildren.org. Estratto il 21 giugno 2012.
- ^ Gibson, Caitlin (1 agosto 2011). “Adolescenti colpiti dal terrorismo uniti per promuovere la pace” . Il Washington Post. Estratto il 21 giugno 2012.
- ^ Robson, Sean; Manacapilli, Thomas (2014), Miglioramento delle prestazioni in condizioni di stress: addestramento all’inoculazione dello stress per avieri sul campo di battaglia (PDF) , Santa Monica, California: RAND Corporation , p. 61, ISBN 9780833078445
- ^ Kilpatrick, Decano G.; Resnick, Heidi S.; Milanak, Melissa E.; Miller, Mark W.; Keyes, Katherine M.; Friedman, Matthew J. (ottobre 2013). “Stime nazionali di esposizione a eventi traumatici e prevalenza di PTSD utilizzando i criteri DSM-IV e DSM-5” . Giornale dello stress traumatico. 26 (5): 537-547. doi : 1002/jts.21848 . ISSN 0894-9867 . PMC 4096796 . PMID 24151000 .
- ^ Salta a: a b Tranter, Heidi; Brooks, Matteo; Khan, Rossana (2020-09-03). “La resilienza emotiva e la centralità degli eventi mediano la crescita post-traumatica a seguito di esperienze infantili avverse” . Trauma psicologico: teoria, ricerca, pratica e politica. 13 (2): 165–173. doi : 1037/tra0000953 . ISSN 1942-969X . PMID 32881570 . S2CID 221497147 .
- ^ Yates, TM, Egeland, B., & Sroufe, LA (2003). “Ripensare la resilienza: una prospettiva del processo di sviluppo”, pp. 234-256 in SS Luthar (a cura di), Resilienza e vulnerabilità: adattamento nel contesto delle avversità dell’infanzia . New York: Cambridge University Press, ISBN 0521001617 .
- ^ Steven J. Wolin, medico; Sybil Wolin, Ph.D. (2010). Il sé resiliente: come i sopravvissuti alle famiglie in difficoltà si elevano al di sopra delle avversità . Random House Publishing Group. ISBN 978-0-307-75687-9 .
- ^ Luthar, SS (2006). “Resilienza nello sviluppo: una sintesi della ricerca attraverso cinque decenni”, pp. 739-795 in D. Cicchetti e DJ Cohen (a cura di), Psicopatologia dello sviluppo (2a ed.): Vol. 3 Rischio, disturbo e adattamento . Hoboken, NJ: Wiley e figli.
- ^ Garmezy, N. (1974, agosto) Lo studio dei bambini a rischio: nuove prospettive per la psicopatologia dello sviluppo.
- ^ Garmezy, N. (1991). “Resilienza e vulnerabilità agli esiti negativi dello sviluppo associati alla povertà”. Scienziato comportamentale americano. 34 (4): 416–430. doi : 1177/0002764291034004003 . S2CID 143628559 .
- ^ Howard, Alyssa. “Adeguamento emotivo del trasloco per i bambini piccoli” . Moveboxer.com.
- ^ Wang, Haertel e Walberg, MC, GD e HJ (ed.). (1994). Resilienza educativa nelle città interne. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- ^ Benard, B. (1991) Promuovere la resilienza nei bambini: fattori protettivi in famiglia, scuola e comunità. Portland, OR: Laboratorio didattico regionale nordoccidentale.
- ^ Cauce, Ana Mari; Stewart, Angela; Rodriguez, Melanie D.; Cochran, Bryan; Ginzler, Joshua. (2003) “Superare le probabilità? Sviluppo adolescenziale nel contesto della povertà urbana”, pp. 343-391 in Suniya S. Luthar (a cura di), Resilienza e vulnerabilità: adattamento nel contesto delle avversità dell’infanzia . Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 0521001617 .
- ^ Doob, Christopher B. (2013). Disuguaglianza sociale e stratificazione sociale nella società statunitense. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education Inc.
- ^ Salta a: a b Monroy Cortés, BG & Palacios Cruz, L. (2011) Resiliencia: ¿Es posible medirla e influir en ella? Salud mentale , 34 (3) 237-246. Messico: Instituto Nacional de Psiquiátrica Ramón de la Fuente Muñiz. ISSN 0185-3325 [spagnolo]
- ^ Sapouna, M.; Wolke, D. (2013). “Resilienza alla vittimizzazione del bullismo: il ruolo delle caratteristiche individuali, familiari e dei pari”. Abuso e negligenza sui minori. 37 (11): 997–1006. doi : 1016/j.chiabu.2013.05.09 . PMID 23809169 .
- ^ Salta a: a b Schneider, TR; Lione, JB; Khazon, S. (2013). “Intelligenza emotiva e resilienza”. Personalità e differenze individuali. 55 (8): 909-914. doi : 1016/j.pagato.2013.07.460 .
- ^ Polano, J.; setacciatura, R.; Pettingell, S.; Bearinger, L.; McMorris, B. (2012). “142. Relazioni tra l’intelligenza socio-emotiva delle ragazze adolescenti e il loro coinvolgimento nell’aggressività relazionale e nella lotta fisica”. Giornale della salute degli adolescenti. 50 (2): S81. doi : 1016/j.jadohealth.2011.10.216 .
- ^ “Ann Masten: Dentro i bambini resilienti” . Youtube. Archiviato dall’originale il 21/12/2021. Estratto il 18 aprile 2019.
- ^ Buhs, Eric; Rudasill, Kathleen (2016). “Rassegna di magia ordinaria: resilienza in sviluppo di Ann S. Masten” . Articoli e pubblicazioni di psicologia dell’educazione. 46 : 84-85. doi : 1016/j.appdev.2016.05.001 . Estratto il 18 aprile 2019.
- ^ González, Rosmarino; Padilla, Amado (1 agosto 1997). “La resilienza accademica degli studenti delle scuole superiori messicano-americane”. Giornale ispanico di scienze comportamentali. 19 (3): 301-317. doi : 1177/07399863970193004 . S2CID 143642546 .
- ^ Salta fino a: a b c d Kelly, JB; Emery, RE (2003). “Adeguamento dei bambini dopo il divorzio: prospettive di rischio e resilienza”. Relazioni familiari. 52 (4): 352-362. doi : 1111/j.1741-3729.2003.00352.x .
- ^ Pedro-Carroll, JA (2005). “Promuovere la resilienza dei bambini all’indomani del divorzio: il racconto di programmi basati sull’evidenza per bambini” (PDF) . Revisione del tribunale della famiglia. 43 : 52-64. doi : 1111/j.1744-1617.2005.00007.x .
- ^ Frankenberg, Elisabetta; Sikoki, Bondan; Sumantri, Cecep; Suriastini, Wayan; Thomas, Duncan (2013). “Educazione, vulnerabilità e resilienza dopo un disastro naturale” . Ecologia e società. 18 (2): 16. doi : 5751/ES-05377-180216 . PMC 4144011 . PMID 25170339 .
- ^ Salta a: a b c d “Studio tematico sulla costruzione della resilienza ai disastri naturali e alle principali crisi economiche” (PDF) . Benvenuti a UN ESCAP.
- ^ Salta a: a b “Costruire la resilienza ai disastri naturali” . Il Forum Economico Mondiale.
- ^ Kieft, Jasmine e Bendell, Jem (2021) La responsabilità di comunicare verità difficili sul clima ha influenzato la distruzione e il collasso della società: un’introduzione alla ricerca psicologica. Institute for Leadership and Sustainability (IFLAS) Occasional Papers Volume 7. University of Cumbria, Ambleside, UK..(Non pubblicato)
- ^ Rynearson, Edward K. (2006). Morte violenta: resilienza e intervento oltre la crisi . Routledge. ISBN 978-1-135-92633-5 .
- ^ Bonanno, George A. (2004). “Perdita, trauma e resilienza umana” . Psicologa americana. 59 (1): 20-8. doi : 1037/0003-066X.59.1.20 . PMID 14736317 .
- ^ Greeff, Abraham P.; Umano, Berquin (2004). “Resilienza nelle famiglie in cui è morto un genitore” (PDF) . L’American Journal of Family Therapy. 32 : 27-42. doi : 1080/01926180490255765 . hdl : 10019,1/52434 . S2CID 145540587 .
- ^ Cooley, E.; Toray, T.; Roscoe, L. (2010). “Reazioni alla scala di perdita: valutazione del dolore negli studenti universitari”. OMEGA: Diario della morte e del morire. 61 (1): 25–51. doi : 2190/OM.61.1.b . PMID 20533647 . S2CID 31782621 .
- ^ Heath, MA; Donald, DR; Terone, LC; Lione, RC (2014). “Interventi terapeutici per rafforzare la resilienza nei bambini vulnerabili”. Scuola Internazionale di Psicologia. 35 (3): 309-337. doi : 1177/0143034314529912 . S2CID 57392624 .
- ^ Linnenluecke, Martina K. (2017). “Resilienza nella ricerca aziendale e manageriale: una rassegna di pubblicazioni influenti e un’agenda di ricerca: resilienza nella ricerca aziendale e manageriale” (PDF) . Rivista internazionale di recensioni di management. 19 (1): 4-30. doi : 1111/ijmr.12076 . S2CID 145078741 .
- ^ Salta a: a b Hartmann, Silja; Weiss, Mattia; Newman, Alessandro; Hoegl, Martin (2019-02-27). “Resilienza sul posto di lavoro: una revisione e una sintesi multilivello”. Psicologia applicata. 69 (3): 913-959. doi : 1111/apps.12191 . S2CID 151262829 .
- ^ van der Vegt, Gerben S.; Esseni, Pietro; Wahlström, Margareta; Giorgio, Gerardo (2015). “Gestione del rischio e della resilienza” . Rivista dell’Accademia di Management. 58 (4): 971–980. doi : 5465/amj.2015.4004 . ISSN 0001-4273 .
- ^ Re, Danielle D.; Newman, Alessandro; Luthans, Fred (2016). “Non se, ma quando abbiamo bisogno di resilienza sul posto di lavoro: Workplace Resilience”. Giornale del comportamento organizzativo. 37 (5): 782-786. doi : 1002/job.2063 .
- ^ Van de Ven, Andrew H.; Polley, Douglas (1992). “Imparare innovando”. Scienza dell’organizzazione. 3 (1): 92-116. doi : 1287/orsc.3.1.92 . ISSN 1047-7039 .
- ^ Pastore, Decano A.; Cardon, Melissa S. (2009). “Reazioni emotive negative al fallimento del progetto e auto-compassione per imparare dall’esperienza”. Journal of Management Studies. 46 (6): 923–949. doi : 1111/j.1467-6486.2009.00821.x . S2CID 9341007 .
- ^ Hu, Yansong; McNamara, Peter; Piaskowska, Dorota (2017). “Sospensioni del progetto e fallimenti nello sviluppo di nuovi prodotti: ritorni per le imprese imprenditoriali nelle alleanze di co-sviluppo” (PDF) . Journal of Product Innovation Management. 34 (1): 35-59. doi : 1111/jpim.12322 .
- ^ Salta a: a b c Moenkemeyer, Gisa; Hoegl, Martin; Weiss, Mattia (2012). “Potenziale di resilienza dell’innovatore: una prospettiva di processo della resilienza individuale influenzata dalla conclusione del progetto di innovazione” (PDF) . Relazioni umane. 65 (5): 627-655. doi : 1177/0018726711431350 . ISSN 0018-7267 . S2CID 145054433 .
- ^ Bandura, Albert (1986). Fondamenti sociali del pensiero e dell’azione: una teoria cognitiva sociale. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- ^ Todt, Gisa; Weiss, Mattia; Hoegl, Martin (2018). “Mitigazione degli effetti collaterali negativi delle interruzioni del progetto di innovazione: il ruolo della resilienza e del supporto sociale”. Journal of Product Innovation Management. 35 (4): 518-542. doi : 1111/jpim.12426 .
- ^ Boyden, J. & Mann, G. (2005). “Rischio, resilienza e coping dei bambini in situazioni estreme”, pp. 3-26 in M. Ungar (a cura di), Manuale per lavorare con bambini e giovani: percorsi di resilienza tra culture e contesti . Thousand Oaks, CA: Sage, ISBN 1412904056 .
- ^ Castro, FG & Murray, KE (2010). “Adattamento culturale e resilienza: controversie, problemi e modelli emergenti”, pp. 375-403 in JW Reich, AJ Zautra e JS Hall (a cura di), Manuale di resilienza degli adulti . New York: Guilford Press , ISBN 146250647X .
- ^ Dawes, A. & Donald, D. (2000). “Migliorare le possibilità dei bambini: teoria dello sviluppo e interventi efficaci in contesti comunitari”, pp. 1–25 in D. Donald, A. Dawes e J. Louw (a cura di), Affrontare le avversità dell’infanzia , Cape Town, SA: David Philip, ISBN 0864864493 .
- ^ American Psychological Association, Task Force su resilienza e forza nei bambini neri e negli adolescenti (2008). Resilienza nei bambini e negli adolescenti afroamericani: una visione per uno sviluppo ottimale . Washington, DC: autore. [ pagina necessaria ]
- ^ “Cos’è la resilienza e perché è importante riprendersi?” . positivepsychologyprogram.com. 3 gennaio 2019. Estratto il 3 febbraio 2019.
- ^ ” Costruire la resilienza nelle comunità aborigene “. Anisnabe Kekendazone Network Environment per la ricerca sulla salute aborigena.
- ^ Ungar, M. (2004). Coltivare la resilienza nascosta nei giovani in difficoltà . Toronto: University of Toronto Press, ISBN 0802085652 . [ pagina necessaria ]
- ^ Obradovic, J.; Bush, NR; Stamperdahl, J.; Adler, NE; Boyce, WT (2010). “Sensibilità biologica al contesto: gli effetti interattivi della reattività allo stress e delle avversità familiari sul comportamento socioemotivo e sulla preparazione scolastica” . Sviluppo del bambino. 81 (1): 270-289. doi : 1111/j.1467-8624.2009.01394.x . PMC 2846098 . PMID 20331667 .
- ^ Grotberg, Edith (1997). Un’accusa contro la società: il diritto del bambino alla protezione. Londra e Bristol. P. 26.
- ^ Corrispondenti, Guardian (2018-07-27). “10 delle migliori parole del mondo (che non si traducono in inglese)” . Il guardiano. ISSN 0261-3077 . Estratto il 18/04/2019.
- ^ Evans, Brad; Reid, Julian (2014). Vita resiliente: l’arte di vivere pericolosamente. Malden, MA: Polity Press. ISBN 978-0-7456-7152-9 . [ pagina necessaria ]
Ulteriori letture
- Benard, B. (2004). Resilienza: cosa abbiamo imparato. San Francisco: West Ed.
- Bronfenbrenner, U. (1979). Ecologia dello sviluppo umano . Cambridge MA: Harvard University Press.
- Comoretto, A., Crichton, N., & Albery, IP (2011). La resilienza negli operatori umanitari: comprendere i processi di sviluppo . LAP: Lambert Academic Publishing.* Gonzales, Laurence (2012). Sopravvivere alla sopravvivenza: l’arte e la scienza della resilienza. New York: WW Norton & Company.
- Marcellino, Guglielmo M.; Tortorello, Frank (2014). “Non credo che mi sarei ripreso”. Forze armate e società. 41 (3): 496-518. doi : 1177/0095327X14536709 . S2CID 146845944 . * Masten, AS (2007). “Resilienza nei sistemi in via di sviluppo: progressi e promesse mentre sale la quarta ondata”. Sviluppo e Psicopatologia. 19 (3): 921–930. doi : 10.1017/S0954579407000442 . PMID 17705908 . S2CID 31526466 .
- Masten, AS (1999). “La resilienza diventa maggiorenne: riflessioni sul passato e prospettive per la prossima generazione di ricerca”. In MD Glantz e JL Johnson (a cura di), Resilienza e sviluppo: adattamenti di vita positivi (pp. 281-296). New York: Kluwer Academic/Plenum Press.
- Reivich, Karen e Shatte, Andrew (2002). Il fattore di resilienza: 7 chiavi per trovare la tua forza interiore e superare gli ostacoli della vita. New York: Broadway.
- Rutter, M. (2000). “Resilienza riconsiderata: considerazioni concettuali, risultati empirici e implicazioni politiche”. In JP Shonkoff e SJ Meisels (a cura di), Manuale di intervento nella prima infanzia (2a ed., pp. 651–682). New York: Cambridge University Press.
- Rutter, M. (1987). “Resilienza psicosociale e meccanismi di protezione”. Giornale americano di ortopsichiatria . 57 (3): 316–331. doi : 1111/j.1939-0025.1987.tb03541.x . PMID 3303954 .
- Southwick, Steven M. e Charnie, Dennis S. (2018). Resilienza: la scienza di padroneggiare le più grandi sfide della vita (seconda edizione). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9781108441667 .
- Ungar, M. (2007). “Aspetti contestuali e culturali della resilienza nei contesti di assistenza all’infanzia”. In I. Brown, F. Chaze, D. Fuchs, J. lafrance, S. McKay e S. Thomas-Prokop (a cura di), Mettere un volto umano sul benessere dei bambini (pp. 1–24). Toronto: Centro di eccellenza per il benessere dei bambini.
link esterno





 Ricerca di Sé:
Ricerca di Sé:

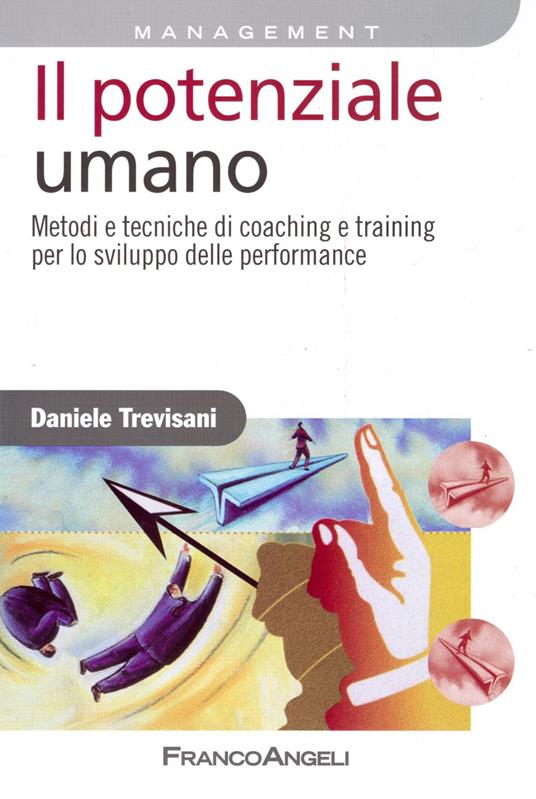 Chi è il migliore Coach in Veneto – Concetti fondamentali: la visione della persona come sistema energetico
Chi è il migliore Coach in Veneto – Concetti fondamentali: la visione della persona come sistema energetico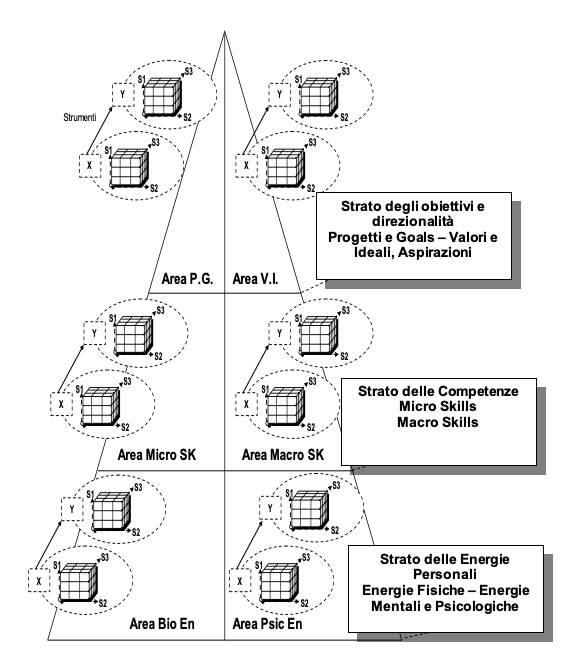 Potenziale umano e prestazioni umane sono due aree di studio diverse ma strettamente collegate, così come lo sono le fondamenta di un edificio e i suoi piani superiori.
Potenziale umano e prestazioni umane sono due aree di studio diverse ma strettamente collegate, così come lo sono le fondamenta di un edificio e i suoi piani superiori.