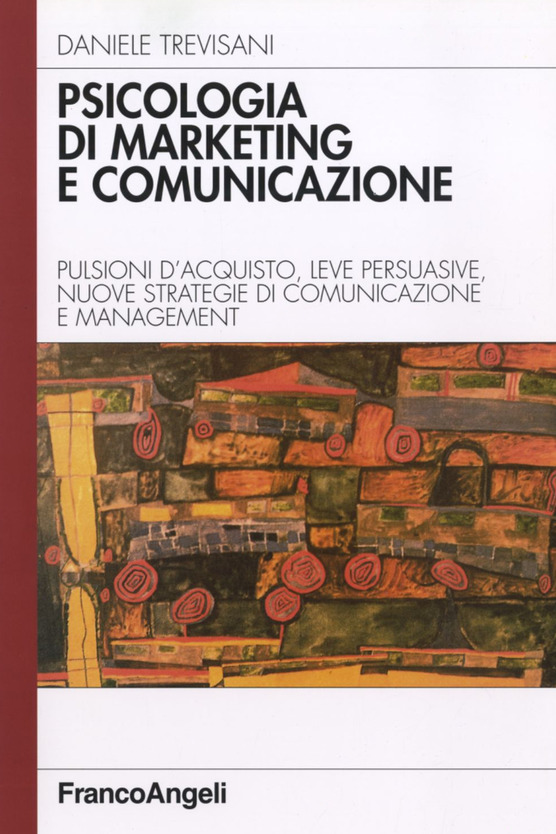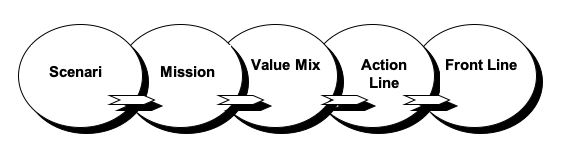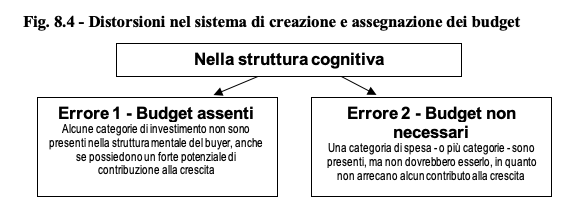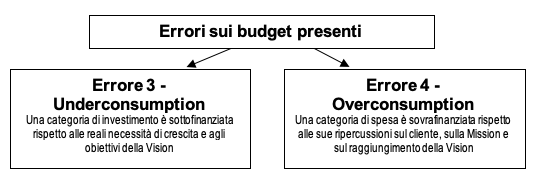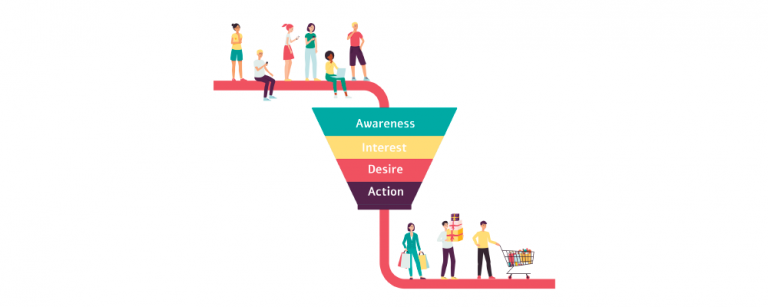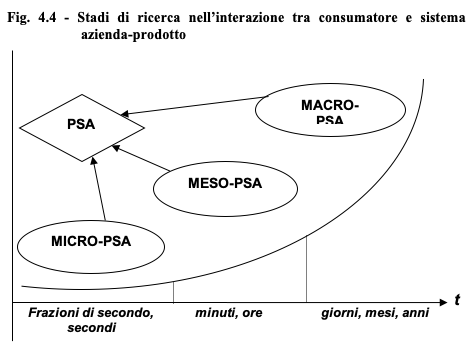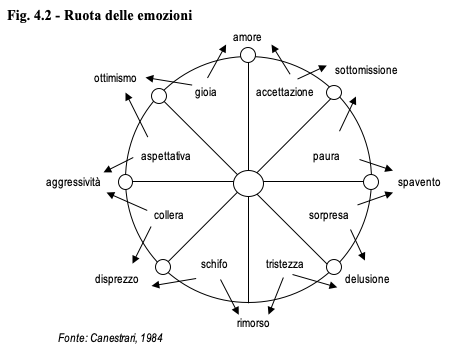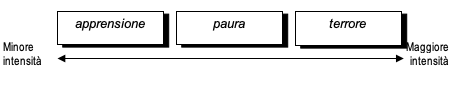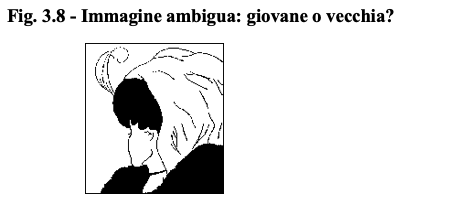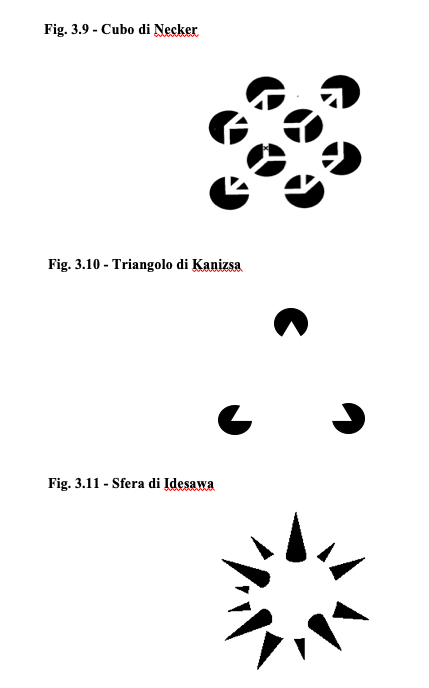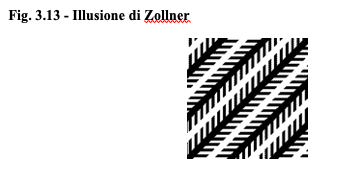Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione: Master privato erogato dagli allievi diretti del Fondatore della Psicologia del Marketing e Comunicazione in Italia, dott. Daniele Trevisani, autore di 33 libri tra cui il pionieristico “Psicologia di marketing e comunicazione. Pulsioni d’acquisto, leve persuasive, nuove strategie di comunicazione e management” (uscito nel 2001 con Franco Angeli Editore) e “Comportamento d’acquisto e Comunicazione Strategica: Dall’analisi del Consumer Behavior alla progettazione comunicativa.” (2003).
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contatta subito il nostro team tramite questo form e ti daremo tutte le informazioni che desideri, ti risponderemo al più presto.
I contenuti del Master rispecchiano l’indice dei libri da studiare. Per Psicologia di Marketing e Comunicazione abbiamo: (a lato la pagina del libro ove si trova il contenuto specifico)
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Introduzione alla psicologia del comportamento di acquisto e strategie per la competitività » 8
1.1. Pulsioni d’acquisto: ragioni di un’analisi » 8
1.2. Conscio, subconscio e inconscio » 9
1.3. La ricerca dei moventi nascosti: oltre il velo del pudore e della consapevolezza » 15
1.4. Impressions management e proiezione dell’identità » 16
1.5. Scelte del cliente e dissonanza » 17
1.6. Il bilanciamento mentale nell’acquisto: una nuova teoria centrata sul cliente » 18
1.6.1. Il costo psicologico latente » 19
1.6.2. Il rientro psicologico latente » 21
1.7. Razionalità interna nelle scelte di acquisto » 23
1.8. Acquisto e motivazione all’azione » 24
1.9. Teoria e realtà negli acquisti attuati dalle imprese (psicologia del business-to-business marketing) » 26
1.10. Moventi apparenti e moventi reali dei consumi » 27
1.11. Implicazioni dei moventi nascosti per le strategie di marketing, verso la ridefinizione della mission » 28
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Leve psicologiche temporali nel consumatore » 33
2.1. Dove si colloca l’utilità dei prodotti: risoluzione, omeostasi, anticipazione » 33
2.2. PPR: Prodotti a potere risolutivo, leve risolutive » 34
2.3. PPA: Prodotti a potere anticipatorio, leve anticipatorie » 35
2.4. PPO: Prodotti a potere omeostatico, leve omeostatiche » 37
2.5. Proprietà multiple di prodotto » 38
2.6. Prima legge del valore di prodotto » 39
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Psicofisiologia della percezione del prodotto » 42
3.1. Performance evaluation source » 42
3.2. Filtratura della realtà e percezione del prodotto » 44
3.3. Funzione di risposta del mercato, soglie percettive e limiti del miglioramento: implicazioni per lo sviluppo del prodotto » 48
3.4. Percorsi di scansione dell’immagine (scan path) » 50
3.4.1. La scansione visiva e i segnali di attenzione » 50
3.4.2. La visione dei prodotti, dei punti di vendita e dei punti di comunicazione aziendale » 53
3.4.3. Trust Signals » 54
3.4.4. La ricostruzione della realtà visiva e il costo di fruizione di un prodotto » 55
3.5. La perceptivity line analysis: percezione totale di prodotto » 56
3.6. Set percettivo, filtri percettivi e valutazione dei prodotti » 58
3.7. La Gestalt del prodotto e l’immagine dell’impresa » 60
3.8. La Gestalt di prodotto e le illusioni percettive » 61
3.9. Influenza degli schemi precedenti sulla valutazione del prodotto » 64
3.10. Benchmarking percettivo e vendita dell’innovazione » 66
3.10.1. La Gestalt e la comprensione del valore del prodotto/servizio » 68
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Strategie di marketing percettivo » 70
4.1. Visione: marketing visivo » 72
4.1.1. La comunicazione visiva nel contesto reale di ricezione del messaggio » 73
4.2. Tatto: marketing tattile » 74
4.3. Olfatto: marketing olfattivo » 75
4.4. Gusto: marketing gustativo » 77
4.5. Udito: marketing uditivo » 78
4.6. Cinestesi: marketing cinestesico (marketing del movimento) » 80
4.7. Ergogenesi: marketing ergogenico (marketing delle emozioni) » 81
4.7.1. Le emozioni fornite dai prodotti » 83
4.7.2. Prodotti ergogenici » 84
4.8. Le condizioni reali di fruizione al centro della progettazione » 85
4.9. Psicopatologie degli oggetti quotidiani e interfacce del prodotto » 86
4.10. La tecnica PSA (perceptual steps product-interaction analysis) » 89
4.11. Planning ambientale e trust-signals » 92
4.12. Drammaturgia dell’ambiente d’acquisto » 93
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Misurazione dell’immagine e psicologia degli atteggiamenti di marketing » 94
5.1. La psicologia degli atteggiamenti verso il prodotto » 96
5.1.1. Il prodotto nel continuum positività-negatività » 100
5.2. Implicazioni per il marketing business-to-business » 101
5.2.1. Segmentazione attitudinale del cliente » 101
5.2.2. Distribuzione delle risorse sui diversi target » 103
5.2.3. Credenze sul prodotto e belief system del consumatore » 105
5.2.4. Persuasione e organizzazione degli atteggiamenti » 108
5.3. L’equilibrio cognitivo del cliente nelle situazioni d’acquisto » 110
5.4. Le otto triadi essenziali di Heider: implicazioni per il marketing cognitivo e le strategia di vendita » 114
5.5. Misurazione degli atteggiamenti e immagine del marchio » 117
5.5.1. Errori di misurazione degli atteggiamenti » 119
5.5.2. Psicolinguistica: impatto delle parole sulla percezione del consumatore » 120
5.5.3. Il differenziale semantico originario » 121
5.5.4. Il differenziale semantico nel marketing » 123
5.6. Terza legge di valore del prodotto » 127
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Pulsioni simboliche ed esplorazione qualitativa del vissuto psicologico del prodotto » 128
6.1. Valenza culturale del prodotto » 131
6.2. Le associazioni valoriali e l’influenza dei valori sul consumo » 132
6.2.1. Influenze dirette e indirette dei valori sulle scelte di consumo » 133
6.3. Le connotazioni culturali del prodotto » 135
6.4. Interpretazione semiotica e valenza simbolica del prodotto » 139
6.4.1. Codici comunicativi » 141
6.4.2. Simboli aziendali ed anticipazione delle reazioni di mercato » 141
6.4.3. Livelli di lettura del segno » 142
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Bisogni umani e leve di vendita » 145
7.1. Piramide di Maslow e implicazioni sulle pulsioni di acquisto » 146
7.2. Bisogni di sopravvivenza » 147
7.3. Bisogni di sicurezza » 147
7.4. Bisogni ambientali » 147
7.5. Bisogni sociali » 148
7.6. Bisogni di autorealizzazione o del “Self”. » 148
7.7. Priorità nella soddisfazione dei bisogni » 149
7.8. Tipologia di bisogno e sensibilità al prezzo » 150
7.9. Aggregazione di proprietà valoriali » 150
7.10. Seconda legge del valore di prodotto » 152
7.11. Creare il valore dove conta » 153
7.12. Le leve persuasive e di vendita combinatorie » 156
7.12.1. LR1: leva risolutiva di sopravvivenza » 160
7.12.2. LO1: leva omeostatica di sopravvivenza » 160
7.12.3. LA1: leva anticipatoria di sopravvivenza » 160
7.12.4. LR2: leva risolutiva di sicurezza » 160
7.12.5. LO2: leva omeostatica di sicurezza » 161
7.12.6. LA2: leva anticipatoria di sicurezza » 161
7.12.7. LR3: leva risolutiva ambientale » 161
7.12.8. LO3: leva omeostatica ambientale » 161
7.12.9. LA3: leva anticipatoria ambientale » 162
7.12.10. LR4: leva risolutiva sociale » 162
7.12.11. LO4: leva omeostatica sociale » 162
7.12.12. LA4: leva anticipatoria sociale » 162
7.12.13. LR5: leva risolutiva del self » 163
7.12.14. LO5: leva omeostatica del self » 164
7.12.15. LA5: leva anticipatoria del self » 164
7.13. La natura multipla delle funzioni di prodotto » 164
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Budget mentali e psicologia economica » 166
8.1. Meccanismi di ricarica dei budget » 167
8.2. Attingere alle risorse e trasferire risorse tra account » 168
8.3. La piramide degli accounts mentali » 169
8.4. Distribuzione delle risorse limitate: il time management cognitivo » 172
8.4.1. Educational marketing: nuova tecnica e filosofia di vendita basata sui budget mentali » 173
8.5. Budget setting » 174
8.6. Income source effects » 176
8.7. Budget mentali, acquisti aziendali e cultura d’impresa » 177
8.8. Sistemi di tracking » 178
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – L’arena di acquisto e la concorrenza psicologica » 180
9.1. Loss aversion: il terrore di perdere e la propensione al rischio » 180
9.2. Variabili e patologie nel comportamento di ricerca informativa » 181
9.3. Diagnosticità dell’informazione » 184
9.4. Processo di acquisto » 185
9.5. Il modello comportamentale stimolo-risposta » 186
9.6. Segmentazione del mercato » 188
9.7. Cultura e reazione ai prodotti » 189
9.8. La distanza culturale come variabile di marketing » 190
9.9. La concorrenza psicologica tra prodotti » 191
9.10. Mental mapping e positioning » 191
9.11. Scelte di concorrenza allargata » 193
9.12. Il consideration-set » 195
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Dal marketing mix al value mix: nuovi strumenti per la customer satisfaction e la ricerca del prodotto ideale » 200
10.1. Strumenti di base per ottenere customer satisfaction » 201
10.1.1. Wish-list: un viaggio verso la chiarezza » 201
10.1.2. Modello XY del cambiamento atteso » 201
10.1.3. Diagnosi e chiarificazione degli obiettivi (Goals Analysis) » 202
10.1.4. Diagnosi dello stato attuale (Situation Analysis) » 203
10.1.5. Gap management » 204
10.1.6. Triplice componente della wish-list » 205
10.1.7. Esplicitare la wish-list di risultato » 206
10.1.8. Esplicitare la wish-list metodologica » 208
10.1.9. Esempi e modelli di rilevazione della wish-list » 208
10.1.10. Narrowing-down » 211
10.2. La ricerca del prodotto ideale e i nuovi modelli di customer satisfaction » 214
10.2.1. L’inclusione degli ideali nel modello di customer satisfaction » 214
10.2.2. L’asse evolutivo del prodotto (R&D) » 218
10.2.3. La ricerca dei prodotti straordinari » 221
10.3. Evoluzioni ulteriori: customer satisfaction oltre il prodotto » 224
10.3.1. Price satisfaction » 225
10.3.2. Distribution satisfaction » 226
10.3.3. Communication satisfaction » 228
10.3.4. Relationship satisfaction » 229
10.4. Interazioni tra i diversi tipi di customer satisfaction » 231
10.4.1. Interazioni prodotto/canale » 232
10.4.2. Behavioral rules e controllo totale » 234
10.4.3. Interazione prodotto/prezzo » 235
10.4.4. Interazioni prodotto/comunicazione » 237
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Conclusione e sviluppi futuri » 239
11.1. Uno sguardo al passato: concetti primari della competitività e struttura del metodo ALM » 239
11.1.1. Il vantaggio competitivo interno ed esterno » 239
11.1.2. La sequenza manageriale ALM » 240
11.1.3. I flussi di valore e il marketing relazionale » 243
11.2. Uno sguardo al presente » 245
11.3. Uno sguardo al futuro: evoluzioni del metodo » 246
11.3.1. Algebra mentale » 246
11.3.2. Tipologie di acquisto » 246
11.3.3. Orizzonte temporale e leve di vendita » 246
11.3.4. Nuove concezioni di vendita terapeutica e consulenziale » 247
11.3.5. La relazione tra scelte individuali e accettazione sociale » 247
11.3.6. Linee di azione strategica e mosse relazionali » 247
11.3.7. Impressioni visive sul cliente » 247
11.3.8. Tecniche di communication training » 248
11.3.9. Modelli di planning psicologico del messaggio » 248
11.3.10. Spartiti t-chart per il planning della comunicazione » 248
11.3.11. Matrici di incomunicabilità e distanze comunicative » 248
11.3.12. Web psychology e comunicazione aziendale sul web » 249
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Parte avanzata sulla Consumer Research
-
 Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Introduzione: l’antropologia di marketing 13
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Introduzione: l’antropologia di marketing 13
1.1. Problematiche del comportamento d’acquisto 14
1.2. Parte 1: L’analisi del cliente e del processo di acquisto 17
1.2.1. Mappa delle tematiche centrali per la parte 1 17
1.3. Parte 2: La comunicazione strategica centrata sul cliente 20
1.3.1. Mappa delle tematiche centrali per la parte 2 20
1.3.2. Un concetto olistico di comunicazione strategica 21
1.3.3. Centratura ed efficacia della comunicazione 21
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Il way-of-buying marketing: la ricerca di un’esperienza positiva nell’acquisto 25
2.1. Per chi vende: l’importanza di saper comunicare le differenze tramite la vendita consulenziale 27
2.2. Per chi acquista: l’importanza di saper percepire le differenze 28
2.3. Scelte di fondo e filosofia d’acquisto 29
2.3.1. Implicazioni aziendali 30
2.4. La ricerca sui processi di acquisto 33
2.4.1. Metodi qualitativi di analisi delle esperienze d’acquisto 34
2.4.1.1. Limitazioni della ricerca qualitativa 35
2.4.2. Metodi basati sulla misurazione statistica delle variabili psicologiche 35
2.4.2.1. Limitazioni della ricerca quantitativa 37
2.5. Pianificazione degli acquisti vs. approccio “alla giornata”: analisi degli atteggiamenti del buyer 37
2.5.1. L’acquisto non pianificato 40
2.5.2. Processi mentali nell’acquisto impulsivo 41
2.5.3. Acquisto impulsivo e acquisto compulsivo 43
2.5.4. Acquisto razionale/funzionale 47
2.5.5. Finta razionalità 50
2.6. Paradossi del consumo e razionalità nascoste 51
2.6.1. Funzioni multiple del consumo 54
2.7. Acquisto rituale/abitudinario 55
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Tipologie di acquisto, categorie e interpretazioni per un’antropologia dell’atto di acquisto 57
3.1. Motivazioni inconsce e subconscie di acquisto 57
3.2. L’analisi dei bisogni 60
3.3. Tipologie di acquisto e modelli 61
3.3.1. Primo modello: pulsioni consce, subconscie, inconsce 62
3.3.2. Secondo modello: il T-chart 63
3.3.3. Terzo modello: approccio delle leve temporali 64
3.3.4. Quarto modello: l’approccio Maslowiano 65
3.3.5. Quinto modello: l’approccio combinatorio (tipologico-temporale) 66
3.3.6. Sesto modello: Theory of Reasoned Action 66
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Pulsioni sessuali remote connesse agli atti di acquisto 68
4.1. Acquisto maschile inconscio/subconscio 68
4.1.1. Il transfer della dimostrazione 73
4.2. Acquisto femminile inconscio/subconscio 74
4.3. Implicazioni aziendali 78
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Cultura e comunicazione: marketing e comunicazione interculturale, management cross-culturale 79
5.1. Acquisto subconscio/culturale 79
5.2. Comunicazione interculturale e management 81
5.3. Coaching e training per l’inserimento di manager nei paesi esteri 82
5.3.1. La comunicazione interculturale manageriale e i task comunicazionali 83
5.3.2. Antropologia manageriale e integrazione / socializzazione interculturale 84
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Moventi simbolici nell’acquisto 86
6.1. Acquisto semiotico: movente simbolico, proiettivo, imitativo e mitologico 87
6.2. Imitazione delle innovazioni: la curva di diffusione 88
6.3. La diffusione di innovazioni e dei simboli nel marketing di massa 90
6.4. Promuovere prodotti e servizi innovativi nel Business to Business 95
6.5. Fattori facilitativi nella diffusione di prodotti/servizi innovativi e stadi del processo di adozione 96
6.6. Effetto sociale delle comunicazioni di marketing: la leva competitiva della comunicazione socialmente responsabile 98
6.7. La Meaning-Based Consumption Research 99
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Acquisto e gratificazione 101
7.1. Le forme di scambio e le fonti di gratificazione 101
7.2. Acquisto autogratificativo (self-gifting) 103
7.3. Acquisto eterogratificativo (gift-giving): il dono 105
7.3.1. Il dono e la gestione dell’immagine 108
7.3.2. Il dono e la traiettoria delle relazioni 110
7.4. Acquisto ricreativo (sociale o tecnologico) 112
7.5. Acquisto politico o di networking 113
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Confronto tra alternative: algebra mentale e modelli di scelta nella concorrenza 116
8.1. Grado di formalizzazione ed efficienza dell’acquisto 116
8.2. L’acquisto formalizzato 118
8.2.1. Implicazioni per la vendita all’impresa 120
8.3. Fondamenti del confronto tra prodotti: soddisfazione di utilizzo e soddisfazione proiettiva 121
8.4. Capire i ragionamenti del buyer: analisi di alcuni metodi di calcolo cognitivo 124
8.4.1. Metodo dei punteggi semplici (pagella del prodotto) 124
8.4.2. Metodo sottrattivo (basato sulla minimizzazione dell’insoddisfazione) 126
8.4.3. Metodo moltiplicativo 127
8.4.4. Metodo degli scostamenti ponderati 127
8.4.5. Metodo dei coefficienti di priorità bilanciati 128
8.5. Modelli compensativi e modelli discriminanti 129
8.6. Alla ricerca delle key-variables 132
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Aspettative altrui e decisione di acquisto: teorie del comportamento pianificato e dell’azione ragionata 137
9.1. Accountability: la necessità di spiegare le proprie scelte agli altri 137
9.2. La spirale del silenzio aziendale 140
9.3. Rendicontazione delle scelte di acquisto 142
9.4. Esplicitazione dei ragionamenti mentali 143
9.5. Fattori individuali e fattori sociali nella scelta del prodotto 144
9.6. Le radici dell’intenzione comportamentale 146
9.7. Componenti della teoria dell’azione ragionata 148
9.8. Teoria del comportamento pianificato (Theory of Planned Behavior) 149
9.8.1. Behavioral Beliefs: le credenze comportamentali 152
9.8.2. Normative Beliefs: le credenze normative 153
9.8.3. Control Beliefs: credenze sulle proprie capacità di controllo della situazione 154
9.8.3.1. La percezione di disponibilità economica, fattibilità e finanziabilità dell’investimento come leve facilitanti 155
9.9. Applicazioni della Teoria dell’Azione Ragionata ai comportamenti di acquisto 157
9.10. Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – La motivazione all’adattamento e le aspettative altrui 158
9.10.1.1. Come si formano le intenzioni d’acquisto 159
9.11. La componente normativa negli acquisti B2B 161
9.11.1. Scelte di prodotto e reazione prevista nel cliente finale 163
9.12. Una legge del valore: l’acquisto come strumento di rinforzo delle relazioni 164
9.13. Applicazione in un caso di studio di marketing comportamentale (fitness marketing) 165
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Otto situazioni psicologiche di acquisto 170
10.1. I 4 casi di atteggiamento individuale positivo 170
10.1.1. Situazione 1 171
10.1.2. Situazione 2 172
10.1.3. Situazione 3 173
10.1.4. Situazione 4 174
10.2. I 4 casi di atteggiamento individuale negativo 175
10.2.1. Situazione 5 175
10.2.2. Situazione 6 176
10.2.3. Situazione 7 177
10.2.4. Situazione 8 177
10.3. Percorsi della persuasione nei casi estremi 178
10.4. Il dialogo interiore nella scelta del prodotto 179
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Comunicazione strategica: approcci olistici alla comunicazione nell’impresa 182
11.1. Situazioni comunicative (COMSITS) 183
11.2. La comunicazione inconsapevole: i messaggi negativi emessi e le loro ripercussioni 183
11.3. Ambiti principali della comunicazione 185
11.4. Relazioni tra comunicazione interna ed esterna 186
11.5. Comunicazione esterna: i macro-obiettivi della comunicazione strategica 187
11.6. Brand awareness e knowledge building: strumenti per l’economia dell’attenzione del cliente 189
11.7. Immagine aziendale e Corporate Identity Engineering 191
11.8. Gli scostamenti d’immagine e la costruzione d’identità 193
11.8.1. Distanza tra identità auto-percepita e auspicata 197
11.8.2. Divergenze tra identità realmente percepita dal pubblico e falsi miti aziendali 197
11.8.3. Capire l’immagine che proiettiamo 198
11.8.4. Distonie dell’auto-percezione: l’incongruenza 198
11.9. Gestalt della comunicazione e immagine 201
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Il Marketing semantico 204
12.1. Le associazioni mentali nella comunicazione aziendale 204
12.1.1. La Means-End Chain: creare i vantaggi percepibili 208
12.1.2. Il messaggio e le reti semantiche: la scoperta del network del cliente e il marketing cognitivo 209
12.1.3. Le adiacenze semantiche 212
12.1.4. Errori di comunicazione e de-marketing semantico 213
12.1.5. Il demarketing semantico positivo – con chi lavoriamo, con chi non lavoriamo 215
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Azioni di comunicazione olistica basate su diagnosi di qualità comunicativa 216
13.1. La struttura di una campagna/intervento di comunicazione olistica 216
13.1.1. Benchmarking della comunicazione ed emersione delle esigenze di miglioramento 219
13.1.2. I risultati al centro della progettazione 220
13.2. Information planning e marketing dell’informazione 221
13.3. La fase di check-up comunicazionale 221
13.3.1. Il check-up della comunicazione esterna 222
13.3.2. Total Quality Communication (Relazionale & Web) 223
13.3.3. Push-information e Information-on-demand per il marketing dell’informazione 223
13.4. Total Quality Communication Check-Up e variabili per la diagnosi comunicazionale 224
13.4.1. Diagnosi espressiva del personale commerciale 225
13.4.2. Diagnosi di qualità del sistema commerciale 225
13.4.3. Diagnosi di efficienza ed efficacia delle reti di vendita 226
13.4.4. Diagnosi di qualità negoziale 226
13.4.5. Il check-up della comunicazione interna 227
13.4.6. Diagnosi dei sistemi di leadership, motivazione e gestione dei gruppi 228
13.4.7. Diagnosi di qualità dei sistemi di comunicazione digitale e webmarketing 229
13.4.8. Diagnosi di qualità nella comunicazione ai fornitori 231
13.5. Progettare la competitività comunicativa tramite la rilevazione dei segnali deboli e il bilancio immateriale 233
13.5.1. I segnali deboli della comunicazione come sistemi di rilevazione dell’efficienza aziendale 233
13.5.2. L’esigenza di produrre un bilancio immateriale 233
13.6. Il manager olistico: sinergia tra le tecnologie, strategie e sensibilità nei rapporti umani 235
13.6.1. Il fattore umano nell’era delle tecnologie 236
13.6.2. I contenuti per un processo di sviluppo del manager olistico e il nuovo ruolo della formazione 237
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – La Customer Experience e i flussi di comunicazione esperienziale 239
14.1. Customer experience e comunicazione frame-by-frame 239
14.2. I frames esperienziali 240
14.3. Lo spazio della ricerca 244
14.4. Linea di visibilità e Customer Experience nella comunicazione aziendale 244
14.4.1. La customer experience del cliente e il contatto con l’azienda: dalla visita aziendale allo show room 245
14.4.1.1. Analisi di un’esperienza di visita guidata aziendale 245
14.4.1.2. Analisi di un’esperienza di visita allo show-room 247
14.4.2. Progettare una diversa customer experience: il marketing ambientale e l’ergonomia del cliente 248
14.4.3. La linea di visibilità aziendale e i blueprint del cliente 249
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Strategia dei canali, Communication Mix e Activation Research 252
15.1. Centratura dei canali comunicativi 252
15.2. Tempo e momento di elaborazione del messaggio 254
15.2.1. Portata informativa del canale di comunicazione 255
15.2.2. Channel sensitivity: la sensibilità al canale comunicativo 255
15.3. Activation Research 256
15.3.1. Analisi economica dei costi / benefici di comunicazione 257
15.3.2. Analisi dei costi / benefici intangibili di comunicazione 258
15.3.3. Effetti intangibili della comunicazione: creazione delle condizioni favorevoli per la vendita e coltivazione del cliente 258
15.3.4. La focalizzazione delle risorse su obiettivi chiari 262
-
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Conclusioni: errori di management, barriere mentali e relazioni d’aiuto per l’efficacia comunicativa 265
16.1. La distorsione degli obiettivi a forte coinvolgimento personale 266
16.2. Coinvolgimento emotivo ed errori di mercato 266
16.3. Alcuni clamorosi errori di valutazione 268
16.4. Consulenza di processo e Action Research come soluzioni per un recupero dell’efficienza comunicativa 270
16.4.1. Il contributo della consulenza di processo 271
16.4.1.1. La consulenza di processo aziendale (CPA) 271
16.4.1.2. La consulenza di processo personale (CPP) e la scoperta delle proprie barriere mentali 273
16.4.2. Le qualità e capacità del consulente di processo 276
16.4.3. Il contributo della Action Research 277
16.4.3.1. La Action Research per lo sviluppo comunicativo personale (ARP) 278
16.4.3.2. La Action Research per lo sviluppo comunicativo aziendale (ARA) 279
16.4.4. Unione tra consulenza di processo e action research 280
Bibliografia 283
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti
Psicologia del marketing
La psicologia del marketing è lo studio degli individui, dei gruppi o delle organizzazioni e di tutte le attività associate all’acquisto , all’uso e alla cessione di beni e servizi . La psicologia del marketing consiste nel modo in cui le emozioni, gli atteggiamenti e le preferenze del consumatore influenzano il comportamento di acquisto . La psicologia del marketing è emersa negli anni ’40 e ’50 come una sottodisciplina distinta del marketing , ma è diventata una scienza sociale interdisciplinare che fonde elementi di psicologia , sociologia , antropologia sociale , antropologia , etnografia , etnologia , marketing ed economia (in particolare l’economia comportamentale ). .
Lo studio della psicologia del marketing indaga formalmente le qualità individuali come dati demografici , stili di vita della personalità e variabili comportamentali (come tassi di utilizzo, occasioni di utilizzo, fedeltà , difesa del marchio e disponibilità a fornire referral ), nel tentativo di comprendere i desideri e i modelli di consumo delle persone. . La psicologia del marketing indaga anche sulle influenze sul consumatore, dai gruppi sociali come famiglia, amici, sport e gruppi di riferimento, alla società in generale ( brand-influencer , opinion leader ).
Poiché la psicologia del marketing è difficile da prevedere, gli esperti di marketing e i ricercatori utilizzano l’etnografia , la neuroscienza del consumo e l’apprendimento automatico [1] e utilizzano i database di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per l’analisi dei modelli dei clienti. Gli estesi dati prodotti da questi database consentono un esame dettagliato dei fattori comportamentali che contribuiscono alle intenzioni di riacquisto dei clienti, alla fidelizzazione dei consumatori , alla fedeltà e ad altre intenzioni comportamentali come la volontà di fornire referenze positive, diventare sostenitori del marchio o impegnarsi in attività di cittadinanza del cliente. . I database aiutano anche nella segmentazione del mercato , in particolare nella segmentazione comportamentale come lo sviluppo di segmenti di fedeltà, che possono essere utilizzati per sviluppare strategie di marketing personalizzate strettamente mirate su base individuale.
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Origini della psicologia del marketing
Articolo principale: Storia del marketing § Storia del pensiero di marketing
Negli anni Quaranta e Cinquanta, il marketing era dominato dalle cosiddette scuole di pensiero classiche che erano altamente descrittive e facevano molto affidamento su approcci di studio di casi con l’uso solo occasionale di metodi di intervista. Alla fine degli anni Cinquanta, due importanti rapporti criticavano il marketing per la sua mancanza di rigore metodologico, in particolare per la mancata adozione di metodi di ricerca delle scienze comportamentali orientati matematicamente . [2] Era pronto il terreno affinché il marketing diventasse più interdisciplinare adottando una prospettiva comportamentista del consumatore.
A partire dagli anni ’50, il marketing iniziò a spostare la propria dipendenza dall’economia verso altre discipline, in particolare le scienze comportamentali , tra cui la sociologia , l’antropologia e la psicologia clinica . Ciò ha comportato una nuova enfasi sul cliente come unità di analisi. Di conseguenza, nuove conoscenze sostanziali sono state aggiunte alla disciplina del marketing, comprese idee come leadership d’opinione , gruppi di riferimento e fedeltà alla marca . Anche la segmentazione del mercato , in particolare la segmentazione demografica basata sull’indice dello stato socioeconomico (SES) e sul ciclo di vita della famiglia, è diventata di moda. Con l’aggiunta della psicologia del marketing, la disciplina del marketing ha mostrato una crescente sofisticazione scientifica rispetto allo sviluppo della teoria e alle procedure di test. [3]
Nei suoi primi anni, la psicologia del marketing era fortemente influenzata dalla ricerca sulla motivazione, che aveva aumentato la comprensione dei clienti, ed era stata ampiamente utilizzata dai consulenti del settore pubblicitario e anche nella disciplina della psicologia negli anni ’20, ’30 e ’40. Negli anni ’50, il marketing iniziò ad adottare tecniche utilizzate dai ricercatori sulla motivazione, tra cui interviste profonde, tecniche proiettive, test di appercezione tematica e una serie di metodi di ricerca qualitativa e quantitativa . [4] Più recentemente, gli studiosi hanno aggiunto una nuova serie di strumenti tra cui l’etnografia, le tecniche di foto-elicitazione e le interviste fenomenologiche . [5] Oltre a questi, la ricerca contemporanea ha approfondito ulteriormente le complessità del comportamento dei consumatori, incorporando approcci innovativi come studi di neuroimaging e analisi dei big data. Questi strumenti moderni forniscono informazioni più approfondite sulle motivazioni subconsce dei consumatori e sui processi decisionali. [6] Oggi, la psicologia del marketing (o CB come è affettuosamente conosciuta) è considerata un’importante sottodisciplina del marketing ed è inclusa come unità di studio in quasi tutti i programmi di marketing universitari.
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Definizione e spiegazione
La psicologia del marketing comprende “tutte le attività associate all’acquisto, all’uso e allo smaltimento di beni e servizi, comprese le risposte emotive, mentali e comportamentali del consumatore che precedono o seguono queste attività”. [7] Il termine consumatore può riferirsi sia ai consumatori individuali che ai consumatori organizzativi e, più specificamente, “un utente finale, e non necessariamente un acquirente, nella catena di distribuzione di un bene o servizio”. [8] La psicologia del marketing si occupa di: [9]
- attività di acquisto : l’acquisto di beni o servizi; come i consumatori acquistano prodotti e servizi e tutte le attività che portano a una decisione di acquisto, inclusa la ricerca di informazioni, la valutazione di beni e servizi e i metodi di pagamento inclusa l’esperienza di acquisto
- attività di uso o consumo : riguarda il chi, dove, quando e come del consumo e l’esperienza d’uso, comprese le associazioni simboliche e il modo in cui i beni sono distribuiti all’interno delle famiglie o delle unità di consumo
- attività di smaltimento : riguarda il modo in cui i consumatori smaltiscono prodotti e imballaggi; può includere anche attività di rivendita come eBay e mercati dell’usato
Le risposte dei consumatori possono essere: [10]
- risposte emotive (o affettive) : si riferiscono a emozioni come sentimenti o stati d’animo,
- mentali (o cognitive ): si riferiscono ai processi di pensiero del consumatore, ai loro
- risposte comportamentali (o conative) : si riferiscono alle risposte osservabili del consumatore in relazione all’acquisto e allo smaltimento di beni o servizi.
Secondo l’ American Marketing Association , la psicologia del marketing può essere definita come “l’interazione dinamica di affetti e cognizione, comportamento ed eventi ambientali attraverso la quale gli esseri umani gestiscono gli aspetti di scambio della loro vita”.
Come campo di studio, la psicologia del marketing è una scienza sociale applicata . L’analisi della psicologia del marketing è “l’uso di principi comportamentali , solitamente acquisiti sperimentalmente, per interpretare il consumo economico umano”. Come disciplina, la psicologia del marketing si trova all’intersezione tra la psicologia economica e la scienza del marketing. [11]
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – La decisione di acquisto e il suo contesto
il comportamento di acquisto e consumo è una sfida fondamentale per i professionisti del marketing. La psicologia del marketing, nel suo senso più ampio, si occupa di comprendere sia come vengono prese le decisioni di acquisto sia come vengono consumati o vissuti prodotti o servizi. I consumatori sono decisori attivi. Decidono cosa acquistare, spesso in base al reddito disponibile o al budget. Possono modificare le loro preferenze in relazione al budget e a una serie di altri fattori. [12] [13] [14]
Alcune decisioni di acquisto implicano processi lunghi e dettagliati che includono un’ampia ricerca di informazioni per selezionare tra alternative concorrenti. [15] Altre decisioni di acquisto. Nella pratica dei consumatori, i consumatori devono prendere decisioni molto complesse, spesso basate sulla mancanza di tempo, conoscenza o capacità di negoziazione. [16] Come gli acquisti d’impulso o gli acquisti abituali, vengono effettuati quasi istantaneamente con poco o nessun investimento di tempo o impegno nella ricerca di informazioni.
Alcune decisioni di acquisto vengono prese da gruppi (come famiglie, nuclei familiari o imprese) mentre altre vengono prese da individui. Quando una decisione di acquisto viene presa da un piccolo gruppo, come una famiglia, diversi membri del gruppo possono essere coinvolti in fasi diverse del processo decisionale e possono svolgere ruoli diversi. Ad esempio, una persona può suggerire la categoria di acquisto, un’altra può cercare informazioni relative al prodotto mentre un’altra ancora può recarsi fisicamente al negozio, acquistare il prodotto e trasportarlo a casa. È consuetudine pensare ai tipi di ruoli decisionali; ad esempio:
L’Iniziatore
la persona che propone un marchio (o un prodotto) a titolo oneroso (qualcosa in cambio );
L’influencer
qualcuno che consiglia una determinata marca;
Il decisore
la persona che prende la decisione finale di acquisto;
L’acquirente
chi lo ordina o lo acquista fisicamente;
L’utente
la persona che utilizza o consuma il prodotto. [17]
Per la maggior parte delle decisioni di acquisto, ciascuno dei ruoli decisionali deve essere svolto, ma non sempre dalla stessa persona. Ad esempio, nel caso in cui la famiglia debba decidere se cenare fuori, un genitore può avviare il processo facendo intendere che è troppo stanco per cucinare. I bambini sono importanti influenzatori nella decisione complessiva di acquisto, ma entrambi i genitori possono agire come decisori congiunti svolgendo un ruolo di controllo ponendo il veto ad alternative inaccettabili e incoraggiando alternative più accettabili. L’importanza dei bambini come influencer in un’ampia gamma di contesti di acquisto non dovrebbe mai essere sottovalutata e il fenomeno è noto come potere fastidioso . [18]
Per avvicinarsi ai processi mentali utilizzati nelle decisioni di acquisto, alcuni autori utilizzano il concetto di scatola nera , che rappresenta i processi cognitivi e affettivi utilizzati da un consumatore durante una decisione di acquisto. Il modello decisionale colloca la scatola nera in un ambiente più ampio che mostra l’interazione di stimoli esterni ed interni (ad esempio caratteristiche del consumatore, fattori situazionali, influenze di marketing e fattori ambientali) così come le risposte dei consumatori. [19] Il modello della scatola nera è legato alla teoria della scatola nera del comportamentismo , dove l’attenzione si estende oltre i processi che avvengono all’interno del consumatore e include anche la relazione tra gli stimoli e la risposta del consumatore.
Il modello decisionale presuppone che le decisioni di acquisto non avvengano nel vuoto. Piuttosto, si verificano in tempo reale e sono influenzati da altri stimoli, compresi gli stimoli ambientali esterni e la situazione momentanea del consumatore. Gli elementi del modello includono stimoli interpersonali (tra persone) o stimoli intrapersonali (all’interno delle persone), stimoli ambientali e stimoli di marketing. [20] Gli stimoli di marketing includono azioni pianificate e realizzate dalle aziende, mentre gli stimoli ambientali includono azioni o eventi che si verificano nell’ambiente operativo più ampio e includono dimensioni sociali, economiche, politiche e culturali. Inoltre, la scatola nera dell’acquirente include le caratteristiche dell’acquirente e il processo decisionale, che influenzano le risposte dell’acquirente.
Gli acquisti di profumi esclusivi, spesso acquistati come regali, sono decisioni ad alto coinvolgimento perché il regalo simboleggia la relazione tra chi dona e il destinatario previsto.
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Riconoscimento del problema
La prima fase del processo decisionale di acquisto inizia con il riconoscimento del problema (noto anche come bisogno di categoria o eccitazione del bisogno). Questo è quando il consumatore identifica un bisogno, tipicamente definito come la differenza tra lo stato attuale del consumatore e il suo stato desiderato o ideale. Un modo più semplice di pensare al riconoscimento del problema è che è il momento in cui il consumatore decide di essere “nel mercato” per un prodotto o un servizio per soddisfare un bisogno o un desiderio. La forza del bisogno sottostante guida l’intero processo decisionale. [21]
I teorici identificano tre ampie classi di situazioni di risoluzione dei problemi rilevanti per la decisione di acquisto: [22]
Ampia risoluzione dei problemi
Acquisti che garantiscono una maggiore riflessione, una più ampia ricerca di informazioni e una valutazione delle alternative. Si tratta in genere di acquisti costosi, o di acquisti ad alta visibilità sociale, ad esempio moda, automobili.
Risoluzione dei problemi limitata
Acquisti noti o familiari, acquisti regolari, riacquisti diretti. Articoli solitamente a basso prezzo.
Risoluzione dei problemi di routine
Acquisti ripetuti o acquisti abituali
I consumatori vengono a conoscenza di un problema in vari modi, tra cui: [23]
Esaurimento delle scorte/esaurimento naturale
Quando un consumatore ha bisogno di ricostituire le scorte di un articolo di consumo, ad esempio ha finito il latte o il pane.
Acquisto regolare
Quando un consumatore acquista regolarmente un prodotto, ad esempio giornali, riviste.
Insoddisfazione
Quando un consumatore non è soddisfatto del prodotto o servizio attuale.
Nuovi bisogni o desideri
I cambiamenti dello stile di vita possono innescare l’identificazione di nuovi bisogni, ad esempio l’arrivo di un bambino può indurre all’acquisto di una culla, di un passeggino e di un seggiolino per l’auto per il bambino.
Prodotti correlati
L’acquisto di un prodotto può comportare la necessità di accessori, pezzi di ricambio o beni e servizi complementari, ad esempio l’acquisto di una stampante comporta la necessità di cartucce d’inchiostro; l’acquisto di una fotocamera digitale comporta la necessità di schede di memoria.
Riconoscimento dei problemi indotti dal marketing
Quando l’attività di marketing convince i consumatori di un problema (di solito un problema che il consumatore non si rendeva conto di avere). I contenuti consumati consciamente e inconsciamente nei media tradizionali e nei social media svolgono notevolmente il ruolo di stimolo per il riconoscimento di un nuovo bisogno da parte del consumatore.
Nuovi prodotti o categorie
Quando i consumatori vengono a conoscenza di nuovi prodotti innovativi che offrono mezzi superiori per soddisfare un bisogno. Tecnologie dirompenti come l’avvento di dispositivi di comunicazione senza fili possono innescare la necessità di una vasta gamma di prodotti come nuovi mouse o stampanti.
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Ricerca informazioni
Durante le fasi di ricerca e valutazione delle informazioni, il consumatore opera attraverso processi progettati per arrivare a una serie di marchi (o prodotti) che rappresentano valide alternative di acquisto. In genere i consumatori effettuano prima una ricerca interna e scansionano la loro memoria per individuare i marchi adatti. L’ insieme evocato è l’insieme di marchi che un consumatore può evocare dalla memoria ed è tipicamente un insieme molto piccolo di circa 3-5 alternative. [24] I consumatori possono scegliere di integrare il numero di marchi nell’insieme evocato eseguendo una ricerca esterna utilizzando fonti come Internet, siti web di produttori/marchi, acquisti in giro, recensioni di prodotti, segnalazioni di colleghi e simili. La disponibilità delle informazioni ha aumentato il livello di informazione dei consumatori: il grado in cui sanno cosa è disponibile sul mercato, con quali caratteristiche e a quale prezzo. [25]
Il fatto che un consumatore conosca un marchio non significa necessariamente che lo consideri un potenziale acquisto. Ad esempio, il consumatore può essere a conoscenza di alcuni marchi, ma non essere disposto nei loro confronti (il cosiddetto set inetto ). Tali marchi saranno generalmente esclusi da un’ulteriore valutazione come opzioni di acquisto. Per altri marchi il consumatore può provare sentimenti indifferenti (l’ insieme inerte ). [26] Quando il consumatore si avvicina all’acquisto vero e proprio, distilla l’elenco mentale dei marchi in una serie di alternative che rappresentano opzioni di acquisto realistiche, note come set di considerazione . [27] Per definizione, il corrispettivo si riferisce al “piccolo insieme di marchi a cui il consumatore presta molta attenzione quando prende una decisione di acquisto”. [28] Ciò porta infine a un insieme di scelte che include le alternative che sono forti contendenti per l’acquisto. [29]
Nomi di marchi specifici entrano nella considerazione del consumatore in base alla misura in cui soddisfano i suoi obiettivi di acquisto e/o all’importanza o all’accessibilità del marchio al momento della decisione di acquisto. [30] Di conseguenza, i nomi dei marchi più memorabili hanno maggiori probabilità di essere accessibili. Tradizionalmente, uno dei ruoli principali della pubblicità e della promozione era quello di aumentare la probabilità che un marchio fosse incluso nell’insieme evocato dal consumatore. [31] L’esposizione ripetuta ai marchi attraverso una pubblicità intensiva è stato il metodo principale per aumentare la notorietà del marchio più importante . Tuttavia, l’avvento di Internet significa che i consumatori possono ottenere informazioni sul marchio/prodotto da una molteplicità di piattaforme diverse. In pratica, il set di considerazioni ha assunto maggiore importanza nel processo decisionale di acquisto perché i consumatori non dipendono più totalmente dalla memoria. Questo è il marketing, che potrebbe essere definito come “il processo attraverso il quale le aziende creano valore per i clienti e costruiscono solide relazioni con i clienti, al fine di acquisire in cambio valore dai clienti”. [32] Questa definizione implica fortemente che la relazione sia costruita sullo scambio e sulla “creazione” di valore. Ciò significa che si costruisce un bisogno del consumatore, presentandogli o pubblicizzando il prodotto attraverso uno studio analitico dei modelli di consumo dell’utente, dei suoi comportamenti e abitudini. L’implicazione per gli operatori di marketing è che le informazioni rilevanti sul marchio dovrebbero essere diffuse il più ampiamente possibile e incluse in qualsiasi forum in cui è probabile che i consumatori cerchino informazioni sul prodotto o sul marchio, siano essi media tradizionali o canali di media digitali. Pertanto, gli esperti di marketing necessitano di una conoscenza approfondita dei punti di contatto tipici del consumatore .
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Valutazione delle alternative
I consumatori che fanno acquisti alla Burlington Arcade di Londra si impegnano in una serie di attività di acquisto ricreative e funzionali, dallo shopping nelle vetrine al trasporto degli acquisti verso casa.
La valutazione del consumatore può essere vista come una fase distinta. In alternativa, la valutazione può avvenire in modo continuo durante l’intero processo decisionale. I consumatori valutano le alternative in termini di benefici funzionali (chiamati anche utilitaristici ) e psico-sociali (chiamati anche valori espressivi o simbolici ) offerti. [33]
- I benefici funzionali sono i risultati tangibili che possono essere sperimentati dal consumatore come il gusto o l’aspetto fisico.
- I benefici psicosociali sono i risultati più astratti o gli attributi legati alla personalità di un marchio, come la valuta sociale che potrebbe derivare dall’indossare un abito costoso o un marchio di marca o guidare un’auto “calda”.
L’immagine del marchio (o personalità del marchio) è un importante attributo psicosociale. I consumatori possono avere convinzioni sia positive che negative su un determinato marchio. [34] Un numero considerevole di ricerche suggerisce che i consumatori sono predisposti verso marchi con una personalità che corrisponde alla loro e che un buon abbinamento può influenzare la preferenza del marchio, la scelta del marchio, la soddisfazione per un marchio, l’impegno e la fedeltà al marchio e la propensione del consumatore a fornire referenze positive tramite passaparola. [ citazione necessaria ] La branca della psicologia del marketing che indaga la corrispondenza tra la personalità di un marchio e la personalità del consumatore è nota come ricerca sull’autocongruenza. [35] La presenza sui social media di un marchio gioca un ruolo importante in questa fase, con l’effetto descritto come “Pensa ai media normali come a una strada a senso unico dove puoi leggere un giornale o ascoltare un servizio in televisione, ma non puoi hai una capacità molto limitata di esprimere il tuo pensiero sull’argomento, i social media, d’altra parte, sono una strada a doppio senso che ti dà anche la capacità di comunicare.” [36] Le convinzioni dei consumatori su un marchio o su una categoria di prodotto possono variare in base a una serie di fattori, tra cui l’esperienza precedente del consumatore e gli effetti della percezione selettiva, della distorsione e della fidelizzazione. I consumatori meno informati su una categoria tendono a valutare un marchio in base alle sue caratteristiche funzionali. Tuttavia, quando i consumatori diventano più informati, gli attributi funzionali diminuiscono e i consumatori elaborano informazioni più astratte sul marchio, in particolare gli aspetti legati a se stessi. [37]
L’ organizzazione di marketing necessita di una profonda comprensione dei vantaggi più apprezzati dai consumatori e quindi di quali attributi siano più importanti in termini di decisione di acquisto del consumatore. È inoltre necessario monitorare altri marchi nell’ambito della considerazione del cliente per ottimizzare la pianificazione del proprio marchio. Durante la valutazione delle alternative, il consumatore classifica o valuta i meriti relativi delle diverse opzioni disponibili. Nessun processo di valutazione universale viene utilizzato dai consumatori in tutte le situazioni di acquisto. [38] Invece, i consumatori generano criteri di valutazione diversi a seconda di ciascuna situazione di acquisto unica. I social media consentono inoltre ai consumatori di condividere opinioni con i loro colleghi sul prodotto che stanno cercando di acquistare. [39] In questo modo, i consumatori possono valutare i lati positivi e negativi di ciascuna alternativa e decidere in modo ancora più conveniente quale sia il miglior prodotto da acquistare. Pertanto gli attributi di valutazione rilevanti variano a seconda delle diverse tipologie di consumatori e dei contesti di acquisto. Ad esempio, gli attributi importanti per valutare un ristorante includono la qualità del cibo, il prezzo, la posizione, l’atmosfera, la qualità del servizio e la selezione del menu. I consumatori, a seconda delle loro caratteristiche geografiche, demografiche, psicografiche e comportamentali , decideranno quali attributi sono importanti per loro. I potenziali clienti che cercano una piacevole esperienza culinaria potrebbero essere disposti a percorrere distanze maggiori per frequentare un locale raffinato rispetto a coloro che desiderano un pasto veloce in un ristorante più utilitaristico. Dopo aver valutato le diverse caratteristiche del prodotto, il consumatore classifica ciascuna caratteristica o beneficio da molto importante a meno importante. Queste priorità sono direttamente correlate ai bisogni e ai desideri del consumatore. [40] Pertanto, il consumatore arriva a un punteggio ponderato per ciascun prodotto o marca che rappresenta la valutazione soggettiva del consumatore dei punteggi degli attributi individuali ponderati in termini di importanza. Utilizzando questi punteggi, arrivano a un punteggio mentale totale o alla classifica per ciascun prodotto/marchio preso in considerazione. [41]
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Decisione di acquisto
Una volta valutate le alternative, il consumatore decide di procedere all’acquisto vero e proprio. Ad esempio, il consumatore potrebbe dire a se stesso: “Sì, un giorno acquisterò il marchio X”. Questa autoistruzione per effettuare un acquisto è nota come intenzione di acquisto. Le intenzioni di acquisto sono un forte ma imperfetto predittore delle vendite. A volte le intenzioni di acquisto semplicemente non si traducono in un acquisto effettivo e questo può segnalare un problema di marketing. [42] Ad esempio, un consumatore potrebbe voler acquistare un nuovo prodotto, ma potrebbe non essere a conoscenza dei punti vendita che lo immagazzinano, quindi l’acquisto non può procedere. La misura in cui le intenzioni di acquisto si traducono in vendite effettive è nota come tasso di conversione delle vendite . [43]
L’happy hour, in cui è possibile acquistare due drink al prezzo di uno, è un forte invito all’azione perché incoraggia i consumatori ad acquistare ora anziché rinviare l’acquisto a un momento successivo.
Le organizzazioni utilizzano una varietà di tecniche per migliorare i tassi di conversione. La fornitura di condizioni di credito o di pagamento agevolate può incoraggiare l’acquisto. Le promozioni di vendita, come l’opportunità di ricevere un premio o di partecipare a un concorso, possono fornire un incentivo all’acquisto immediato anziché rinviare gli acquisti a una data successiva. I messaggi pubblicitari con una forte call-to-action sono un altro strumento utilizzato per convertire i clienti. [44] Un invito all’azione è qualsiasi dispositivo progettato per incoraggiare la vendita immediata. [45] In genere, un invito all’azione include una formulazione specifica in una pubblicità o in una presentazione di vendita che impiega verbi imperativi come “Acquista ora!” o “Non aspettare!”. Altri tipi di inviti all’azione potrebbero fornire ai consumatori validi motivi per acquistare immediatamente un’offerta disponibile solo per un periodo di tempo limitato (ad esempio “L’offerta deve scadere a breve”; “Disponibilità limitata”) o un’offerta speciale solitamente accompagnata da un vincolo di tempo (es. ‘Ordina entro mezzanotte per ricevere un omaggio con il tuo ordine’; ‘Due al prezzo di uno solo per i primi 50 che chiamano’). Inoltre, la comodità del servizio è un risparmio di fatica, nel senso che riduce al minimo le attività che i clienti possono sostenere per acquistare beni e servizi. [46] La chiave per un potente invito all’azione è fornire ai consumatori ragioni convincenti per acquistare tempestivamente anziché rinviare le decisioni di acquisto.
Quando i consumatori si avvicinano alla decisione di acquisto effettiva, è più probabile che facciano affidamento su fonti di informazione personali. [47] Per questo motivo, i rappresentanti di vendita personali devono essere esperti nel dare presentazioni di vendita e nelle tattiche utilizzate per concludere la vendita. I metodi utilizzati potrebbero includere “prove sociali”, in cui il venditore fa riferimento al successo e alla soddisfazione precedenti di altri clienti che hanno acquistato il prodotto. L’attrazione della scarsità è un’altra tecnica in cui il venditore afferma che l’offerta è limitata, poiché costringe il consumatore a prendere una decisione più rapida e quindi a dedicare meno tempo alla valutazione delle alternative. [48]
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Valutazione post acquisto
Dopo l’acquisto e dopo aver sperimentato il prodotto o il servizio, il consumatore entra nella fase finale, ovvero la valutazione post-acquisto. Foxall ha suggerito che la valutazione post-acquisto può fornire un feedback chiave agli operatori di marketing perché influenza i futuri modelli di acquisto e le attività di consumo. [49] [50]
La fase post-acquisto è quella in cui il consumatore esamina e confronta le caratteristiche del prodotto, come prezzo, funzionalità e qualità, con le proprie aspettative. [51] La valutazione post-acquisto può essere vista come i passi compiuti dai consumatori per correlare le loro aspettative con il valore percepito e quindi influenzare la loro successiva decisione di acquisto per quel bene o servizio. [52] Ad esempio, se un consumatore acquista un nuovo telefono e la sua valutazione post-acquisto è positiva, sarà incoraggiato ad acquistare la stessa marca o dalla stessa azienda in futuro. Questa è nota anche come “intenzione post-acquisto”. [53] Al contrario, se un consumatore è insoddisfatto del nuovo telefono, può intraprendere azioni per risolvere l’insoddisfazione. Le azioni dei consumatori, in questo caso, potrebbero comportare la richiesta di un rimborso, la presentazione di un reclamo, la decisione di non acquistare più lo stesso marchio o dalla stessa azienda in futuro, o addirittura la diffusione di recensioni negative sul prodotto ad amici o conoscenti, magari tramite i social media.
Dopo l’acquisizione, il consumo o la disposizione, i consumatori possono avvertire qualche incertezza riguardo alla decisione presa, generando in alcuni casi rammarico. La dissonanza post-decisione [54] (nota anche come dissonanza cognitiva ) è la sensazione di ansia che si verifica nella fase post-acquisto, così come i sentimenti di disagio o le preoccupazioni sul fatto che sia stata presa o meno la decisione corretta al momento dell’acquisto. [55] Alcuni consumatori, ad esempio, potrebbero pentirsi di non aver acquistato uno degli altri marchi che stavano prendendo in considerazione. Questo tipo di ansia può influenzare il comportamento successivo dei consumatori e può avere implicazioni sul clientelismo ripetuto e sulla fidelizzazione del cliente.
I consumatori utilizzano una serie di strategie per ridurre la dissonanza post acquisto. Una strategia tipica è quella di rivolgersi ai colleghi o ad altre persone significative per la convalida della scelta di acquisto. I clienti sono sempre stati guidati dalle opinioni di amici e familiari, ma oggigiorno ciò è confermato dai Mi piace, dalle recensioni e dalle testimonianze sui social media. Le comunicazioni di marketing possono essere utilizzate anche per ricordare ai consumatori che hanno fatto una scelta saggia acquistando il marchio X. [56]
Quando i consumatori fanno confronti sfavorevoli tra l’opzione scelta e le opzioni rinunciate, possono provare rimorso post-decisione o rimorso dell’acquirente . I consumatori possono anche provare rimpianti a breve termine quando evitano di prendere una decisione di acquisto, ma questo rimorso può dissiparsi nel tempo. Attraverso le loro esperienze i consumatori possono apprendere e anche impegnarsi in un processo chiamato verifica delle ipotesi . Ciò si riferisce alla formazione di ipotesi sui prodotti o su un servizio attraverso l’esperienza precedente o il passaparola. Ci sono quattro fasi che i consumatori attraversano nella verifica delle ipotesi: generazione di ipotesi, esposizione delle prove, codifica delle prove e integrazione delle prove.
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti -Influenze sulla decisione di acquisto
Gli acquisti sono influenzati da un’ampia gamma di fattori interni ed esterni.
Consapevolezza del consumatore
La consapevolezza del consumatore si riferisce alla consapevolezza del consumo dei beni acquistati dai consumatori nell’ambiente di acquisto a lungo termine e nelle attività di acquisto. [57]
Il cambiamento del concetto di vita è il fattore soggettivo del cambiamento della consapevolezza del consumatore. Poiché gli standard di vita e i redditi delle persone continuano ad aumentare, i concetti di vita delle persone cambiano costantemente. [58] Le differenze nella personalità del consumatore sono le motivazioni interne dei cambiamenti nella consapevolezza del consumatore.
L’intensificazione della concorrenza sul mercato è un catalizzatore di cambiamenti nella consapevolezza dei consumatori. Molte aziende hanno lanciato i propri prodotti a marchio per affermarsi in un mercato sempre più competitivo. [59] Di fronte a una varietà di beni e marchi, la consapevolezza del marchio dei consumatori matura. Quando le persone acquistano beni, prestare attenzione al marchio è diventata una moda. Di fronte alla dura situazione della concorrenza, le aziende hanno iniziato a rendersi conto dell’importanza di implementare la strategia del marchio e hanno iniziato a concentrarsi sulla ricerca di mercato e, su questa base, a cogliere profondamente l’impulso psicologico del consumatore per migliorare la quota di mercato e la fedeltà al marchio. [60] Con il cambiamento del concetto di vita delle persone, la psicologia del consumo razionale dei consumatori è diventata sempre più importante. Marketing sociale, [61] Il marketing personalizzato , [62] gli acquisti di marca, [63] e la percezione del prezzo della merce da parte del consumatore (direttamente espressa come sensibilità del consumatore al prezzo) sono tutti fattori principali per comprendere gli atteggiamenti dei consumatori e aiutano a spiegare la reazione del mercato. domanda alle variazioni dei prezzi. [64]
Influenze interne sulla decisione di acquisto
Vedi anche: Segmentazione del mercato
Le influenze interne si riferiscono sia a fattori personali che interpersonali. La teoria sociale suggerisce che gli individui hanno sia un’identità personale che un’identità sociale . L’identità personale è costituita da caratteristiche personali uniche come abilità e capacità, interessi e hobby. L’identità sociale consiste nella percezione dell’individuo dei gruppi centrali a cui appartiene e può riferirsi a una fascia di età, a un gruppo di stili di vita, a un gruppo religioso, a un gruppo educativo o a qualche altro gruppo di riferimento. Gli psicologi sociali hanno stabilito che il bisogno di appartenenza è uno dei bisogni umani fondamentali. [65] Il comportamento d’acquisto HYPERLINK “https://en.wikipedia.org/wiki/Behaviour”è quindi influenzato da un’ampia gamma di fattori interni quali fattori psicologici, socioeconomici, demografici e di personalità. I fattori demografici includono il livello di reddito, gli aspetti psicografici (stili di vita), l’età, l’occupazione e lo stato socioeconomico. I fattori della personalità includono conoscenze, atteggiamenti, valori personali, credenze , emozioni e sentimenti. I fattori psicologici includono la motivazione , gli atteggiamenti , i valori personali e le convinzioni di un individuo. I fattori di identità sociale includono cultura, sottocultura e gruppi di riferimento. Altri fattori che possono influenzare la decisione di acquisto includono l’ ambiente e la precedente esperienza del consumatore con la categoria o il marchio.
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti –Motivazioni ed emozioni
La gerarchia di Maslow suggerisce che le persone cercano di soddisfare i bisogni fondamentali come cibo e alloggio prima che i bisogni di ordine superiore diventino significativi.
La motivazione di fondo del consumatore guida l’azione del consumatore, compresa la ricerca di informazioni e la decisione di acquisto. L’atteggiamento del consumatore nei confronti di un marchio (o preferenza di marca) è descritto come un collegamento tra il marchio e la motivazione all’acquisto. [66] Queste motivazioni possono essere negative (per evitare dolore o spiacevolezza) o positive (per ottenere qualche tipo di ricompensa come la gratificazione sensoriale). [67]
Un approccio alla comprensione delle motivazioni è stato sviluppato da Abraham Maslow . La gerarchia dei bisogni di Maslow si basa su cinque livelli di bisogni, organizzati in base al livello di importanza.
I cinque bisogni di Maslow sono: [56]
Fisiologico
livelli di base dei bisogni come cibo, acqua e sonno
Sicurezza
il bisogno di sicurezza fisica, riparo e protezione
Appartenente
il bisogno di amore, amicizia e anche il desiderio di accettazione da parte del gruppo
Stima
Il bisogno di status, riconoscimento e rispetto di sé
Auto -realizzazione
Il desiderio di autorealizzazione (es. crescita personale, espressione artistica)
I bisogni fisiologici e i bisogni di sicurezza sono i cosiddetti bisogni di ordine inferiore. I consumatori in genere utilizzano la maggior parte delle loro risorse (tempo, energia e finanze) nel tentativo di soddisfare questi bisogni di ordine inferiore prima che i bisogni di ordine superiore di appartenenza, stima e autorealizzazione diventino significativi. Parte di qualsiasi programma di marketing richiede la comprensione di quali motivazioni guidano le scelte di un determinato prodotto. Le comunicazioni di marketing possono illustrare come un prodotto o un marchio soddisfa queste esigenze. [59] L’approccio di Maslow è un modello generalizzato per comprendere le motivazioni umane in un’ampia varietà di contesti, ma non è specifico per le decisioni di acquisto.
La decisione di acquistare un preparato analgesico è motivata dal desiderio di evitare il dolore (motivazione negativa ). La decisione di acquistare una coppa di gelato è motivata dal desiderio di gratificazione sensoriale (motivazione positiva).
Un altro approccio propone otto motivazioni d’acquisto , cinque motivazioni negative e tre motivazioni positive, che danno energia alle decisioni di acquisto, come illustrato nella tabella seguente. [67] Si ritiene che queste motivazioni forniscano rinforzo positivo o rinforzo negativo. [68]
| Motivazioni ed emozioni d’acquisto di Rossiter e Percy | |
| Motivazione | Sequenza emotiva |
| NEGATIVO | |
| Rimozione del problema | Fastidio → Sollievo |
| Evitamento del problema | Paura → Rilassamento |
| Soddisfazione incompleta | Delusione → Ottimismo |
| Evitamento dell’approccio misto | Conflitto → Tranquillità |
| Esaurimento normale | Lieve fastidio → Convenienza |
| POSITIVO | |
| Gratificazione sensoriale | Opaco (o neutro) → Anticipazione sensoriale |
| Simulazione intellettuale | Annoiato (o neutrale) → Eccitato |
| Approvazione/conformità sociale | Apprensivo (o pieno di vergogna) → Lusingato/orgoglioso |
Nella letteratura di marketing, la motivazione del consumatore a cercare informazioni e a impegnarsi nel processo decisionale di acquisto è talvolta nota come coinvolgimento . [69] Il coinvolgimento del consumatore è stato definito come “la pertinenza o l’importanza personale di un messaggio [o di una decisione]”. [70] Le decisioni di acquisto sono classificate come a basso coinvolgimento quando i consumatori subiscono solo una piccola perdita psicosociale nel caso in cui prendano una decisione sbagliata. D’altro canto, una decisione di acquisto è classificata come ad alto coinvolgimento quando i rischi psicosociali sono percepiti come relativamente elevati. [71] Il livello di coinvolgimento del consumatore dipende da una serie di fattori, tra cui il rischio percepito di conseguenze negative in caso di una decisione sbagliata, la visibilità sociale del prodotto e la precedente esperienza del consumatore con la categoria di prodotto. [72]
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Percezione
Parte della strategia di marketing consiste nell’accertare il modo in cui i consumatori acquisiscono conoscenze e utilizzano le informazioni da fonti esterne. Il processo di percezione è il luogo in cui gli individui ricevono, organizzano e interpretano le informazioni per attribuire un significato. La percezione coinvolge tre processi distinti: percezione delle informazioni, selezione delle informazioni e interpretazione delle informazioni. Anche la sensazione fa parte del processo di percezione ed è collegata direttamente alle risposte dei sensi creando alcune reazioni verso il nome del marchio, la pubblicità e il packaging. Il processo di percezione è unicamente individuale e può dipendere da una combinazione di fattori interni ed esterni come esperienze, aspettative, bisogni e l’insieme del momento.
Quando esposti a uno stimolo, i consumatori possono rispondere in modi completamente diversi a causa dei processi percettivi individuali. [56] Numerosi processi potenzialmente supportano o interferiscono con la percezione. L’esposizione selettiva si verifica quando i consumatori decidono se essere esposti a input informativi. L’attenzione selettiva si verifica quando i consumatori si concentrano su alcuni messaggi escludendone altri. La comprensione selettiva è quella in cui il consumatore interpreta le informazioni in modo coerente con le proprie convinzioni. La ritenzione selettiva si verifica quando i consumatori ricordano alcune informazioni mentre ne dimenticano rapidamente altre. [73] Collettivamente i processi di esposizione selettiva, attenzione, comprensione e fidelizzazione portano i singoli consumatori a favorire determinati messaggi rispetto ad altri. Il modo in cui i consumatori combinano gli input di informazioni per arrivare a una decisione di acquisto è noto come integrazione . [74]
Gli esperti di marketing sono interessati alla percezione dei consumatori riguardo a marchi, imballaggi, formulazioni dei prodotti, etichettatura e prezzi. Di particolare interesse è la soglia di percezione (nota anche come differenza appena evidente ) in uno stimolo. Ad esempio, di quanto un operatore di marketing dovrebbe abbassare un prezzo prima che i consumatori lo riconoscano come un affare? [75] Inoltre, gli operatori di marketing che intendono entrare nei mercati globali devono essere consapevoli delle differenze culturali nella percezione. [76] Ad esempio, gli occidentali associano il colore bianco alla purezza, alla pulizia e all’igiene, ma nei paesi orientali il bianco è spesso associato al lutto e alla morte. Di conseguenza, l’imballaggio bianco sarebbe una scelta di colore inappropriata per le etichette alimentari sui prodotti da commercializzare in Asia.
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Psicologia del marketing simbolico
Il consumo simbolico diventa l’influenza interna della psicologia del marketing e forma un simbolo speciale. I simboli di consumo possono essere utilizzati per spiegare il consumatore come membro di un gruppo o come individuo unico. [77] Il comportamento di consumo dei consumatori non è solo consumo materiale e psicologico. Il consumo simbolico ha due significati: 1. Un simbolo di consumo. Il consumo esprime e trasmette un certo significato e messaggio. Il significato derivato dalla cultura ci consente di utilizzare i prodotti per simboleggiare la nostra appartenenza a vari gruppi sociali. [78] Questo consumo simbolico è il processo di espressione sociale e di comunicazione sociale. 2. Consumo simbolico: le persone consumano non solo i beni stessi ma anche determinati significati culturali e sociali da essi simboleggiati o rappresentati, inclusi l’umore, la bellezza, il grado, lo status, lo status, l’atmosfera, lo stile, il fascino emotivo, ecc. Il consumo simbolico è tipicamente riflesso nel consumo del marchio. Il marchio ha tre funzioni per i consumatori: valore funzionale, valore simbolico e valore esperienziale. Prendiamo i marchi di lusso: il potere dei marchi di lusso va oltre la semplice capacità di trasmettere identità. Alcuni consumatori vogliono fare impressione. I beni di lusso costituivano la routine quotidiana dell’aristocrazia, ma dopo che il concetto di classe sociale moderna si è offuscato, i consumatori li consideravano ancora come un biglietto per entrare nella classe superiore. I consumatori valutano un marchio in base a come si allinea con la nostra identità, il che aiuta a definire e mantenere il nostro concetto di sé. [79] Come simbolo di status nobile, ricchezza e successo, è diventato un’identità del consumatore e uno status symbol.
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Esperienza precedente
L’esperienza precedente del consumatore con la categoria, il prodotto o il marchio può avere un impatto importante sul processo decisionale di acquisto. I consumatori esperti (chiamati anche esperti) sono consumatori più sofisticati; tendono ad essere ricercatori di informazioni più abili, esaminano una gamma più ampia di fonti di informazione e utilizzano euristiche complesse per valutare le opzioni di acquisto. I consumatori alle prime armi, d’altro canto, sono meno efficienti nella ricerca di informazioni e tendono a percepire livelli più elevati di rischio di acquisto a causa della loro scarsa familiarità con il marchio o la categoria. Quando i consumatori hanno una precedente esperienza, hanno meno motivazione a cercare informazioni e dedicano meno sforzi alla ricerca di informazioni, ma possono elaborare le nuove informazioni in modo più efficiente. [80] Uno studio, ad esempio, ha rilevato che man mano che l’esperienza del consumatore aumenta, i consumatori considerano una gamma più ampia di alternative di acquisto (ovvero generano un insieme di considerazioni più ampio, ma solo a livello di categoria di prodotto). [81]
Fattore casuale
I fattori casuali si riferiscono a occasioni speciali e a una serie di condizioni casuali che i consumatori hanno al momento dell’acquisto. A volte, le decisioni di acquisto dei consumatori vengono prese in circostanze inaspettate, oppure una situazione ritarderà o accorcerà il processo decisionale delle persone. La ricerca ha scoperto che nell’attesa di scenari in cui i consumatori sono onnipresenti, segnali fisici apparentemente non correlati, come tappeti o linee guida per le code, possono agire come confini virtuali che alterano le decisioni iniziali dei consumatori. [82]
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti –Influenze esterne sulla decisione di acquisto
Il comportamento di acquisto può anche essere influenzato da influenze esterne, come cultura , sottocultura , classe sociale , gruppi di riferimento , famiglia e determinanti situazionali.
Cultura
Le persone con interessi condivisi, come skater e blader, tendono a formare gruppi informali noti come sottoculture.
La cultura è il più ampio e astratto dei fattori esterni. La cultura si riferisce alla complessità dell’apprendimento di significati, valori, norme e costumi condivisi dai membri di una società. Le norme culturali sono relativamente stabili nel tempo, quindi la cultura ha un effetto importante sulla psicologia del marketing. Gli studi di ricerca hanno costantemente dimostrato che la cultura influenza quasi ogni aspetto dell’acquisto: influenza ambiti psicologici di base come l’identità personale e la motivazione, il modo in cui vengono elaborate le informazioni e il modo in cui vengono interpretati i messaggi pubblicitari. [83]
La scelta culturale del comportamento di consumo , il fattore esterno decisivo – l’atmosfera sociale e culturale complessiva – e il fattore interno decisivo – la qualità artistica del consumatore, la ricerca estetica e l’orientamento ai valori culturali. La scelta culturale del consumo deve essere limitata da due fattori decisivi, interni ed esterni. La cosiddetta atmosfera sociale e culturale si concretizza nell’influenza dell’atmosfera di consumo, dei costumi e delle tendenze sui consumatori. Ad esempio, tutti i tipi di culto del denaro criticati dall’opinione pubblica sono l’influenza della cultura volgare. I cosiddetti fattori interni si riferiscono principalmente al tipo di regno spirituale e di orientamento ai valori che i consumatori trattano nei confronti del consumo, e ciò che mostrano attraverso il consumo è una certa mentalità culturale.
Gli esperti di marketing interessati all’espansione globale sono particolarmente interessati a comprendere le differenze interculturali negli acquisti e nei consumi. Ad esempio, Ferrari, uno dei marchi più importanti del mondo, ha scoperto che i consumatori cinesi sono molto diversi dalle loro controparti occidentali. Mentre i consumatori negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia si aspettano di aspettare 12 mesi per una Ferrari su misura, i potenziali acquirenti cinesi vogliono portare il veicolo fuori dallo showroom. La Cina è un “mercato di gratificazione immediata”. Gli acquirenti vedono i loro amici andare in giro a bordo di un’auto di lusso e vogliono avere la stessa il più rapidamente possibile. Per soddisfare la crescente domanda di beni di lusso, la Ferrari e altri produttori di auto di lusso sono stati costretti a modificare i loro processi produttivi per i mercati asiatici. [84]
Sottoculture
Gli appassionati di Harley-Davidson sono un esempio di sottocultura consumistica.
Le sottoculture possono essere basate su differenze di età, geografiche, religiose, razziali ed etniche. Più spesso, tuttavia, una sottocultura si verifica quando persone con interessi condivisi formano un gruppo coeso con un’identità distintiva (a volte chiamato tribù dei consumatori ). I membri delle sottoculture si autoselezionano e segnalano il loro status di appartenenza adottando simboli, rituali o comportamenti ampiamente compresi dagli altri membri della tribù (ad esempio un codice di abbigliamento, un’acconciatura o anche un modo di parlare unico). Ad esempio, all’interno della cultura giovanile è possibile identificare una serie di sottogruppi con interessi comuni come skater e blader, surfisti, raver, punk, skin-head , goth, homies e altri. Generalmente conosciute come comunità, poiché creano un senso di appartenenza a qualcosa di importante.
Un diverso tipo di sottocultura è una sottocultura del consumo basata su un impegno condiviso verso un marchio o un prodotto comune. In altre parole, le sottoculture del consumo superano i confini demografici, geografici e sociali. L’esempio più noto di sottocultura del consumo è quello dei proprietari di motociclette Harley-Davidson . I ricercatori etnografici che hanno studiato i motociclisti Harley ritengono che esistano solo due tipi di motociclisti: i proprietari di Harley e gli altri. [85] Harley-Davidson ha sfruttato i valori di questa sottocultura fondando l’Harley Owners Group (HOG). [86]
I membri della sottocultura “Goth” condividono un codice di abbigliamento.
Le sottoculture sono importanti per gli esperti di marketing per diversi motivi. In primo luogo, dato che le sottoculture possono rappresentare segmenti di mercato considerevoli, redditizi e influenti, ci sono evidenti vantaggi nello sviluppo e nella vendita di prodotti e servizi che soddisfino le esigenze dei membri della sottocultura. In secondo luogo, e forse in modo meno ovvio, molte nuove mode e mode emergono spontaneamente dall’interno di questi gruppi tribali. Gli osservatori di tendenze sono quindi interessati a studiare gli stili di vita e le attività delle tribù nel tentativo di individuare le nuove tendenze prima che diventino mainstream.
Classe sociale
La classe sociale si riferisce a divisioni relativamente omogenee in una società, tipicamente basate su variabili socioeconomiche come il livello di istruzione, il reddito e l’occupazione. La classe sociale può essere molto difficile da definire e misurare, tuttavia gli esperti di marketing di tutto il mondo tendono a utilizzare una classificazione convenzionale che divide una data popolazione in cinque quintili socioeconomici (ad esempio in Australia i gruppi AB, C, D, E e FG, dove AB è il quintile socio-economico superiore, ma in gran parte dell’Asia i quintili sono etichettati I, II, III, IV e V dove I è il quintile superiore). In Australia, ad esempio, il gruppo socioeconomico AB rappresenta solo il 24% della popolazione, ma controlla il 50% della spesa discrezionale. [87] I quintili superiori (ossia i segmenti socioeconomici AB) sono di particolare interesse per gli operatori del marketing di beni e servizi di lusso quali viaggi, ristorazione fuori casa, intrattenimento, automobili di lusso, servizi di investimento o di gestione patrimoniale, elettronica di consumo di fascia alta, e griffe (ad esempio Louis Vuitton). Tuttavia, i consumatori della classe media tendono a consumare con maggiore attenzione nel confronto e a raccogliere informazioni per confrontare diversi produttori nella stessa linea. Coloro che appartengono alle classi inferiori tendono ad acquistare di più d’impulso rispetto alla classe ricca che acquista beni per mantenere lo status sociale. [88]
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Gruppi di riferimento
Un gruppo di riferimento è definito come “un gruppo le cui presunte prospettive o valori vengono utilizzati da un individuo come base per il suo giudizio, le sue opinioni e le sue azioni”. I gruppi di riferimento sono importanti perché vengono utilizzati per guidare gli atteggiamenti, le credenze e i valori di un individuo. [59] Approfondimenti su come i consumatori acquisiscono un dato sistema di valori possono essere ottenuti dalla comprensione dell’influenza del gruppo e dei processi di socializzazione del gruppo .
La famiglia, gruppo di riferimento primario, esercita una forte influenza su atteggiamenti e comportamenti .
La letteratura identifica cinque grandi tipologie di gruppo di riferimento: primario, secondario, aspirazionale, dissociativo e formale:
Gruppi primari : gruppi, come la famiglia, che esercitano una forte influenza su atteggiamenti e comportamenti
Gruppi secondari : gruppi come club, società, squadre sportive, partiti politici, religioni che si allineano con le idee o i valori di una persona, ma esercitano un’influenza meno fondamentale sulla formazione di atteggiamenti e comportamenti
Gruppi aspirazionali gruppi a cui un individuo attualmente non appartiene, ma eventualmente aspira a diventarne membro perché il gruppo possiede caratteristiche che suscitano ammirazione.
Gruppi di riferimento dissociativi – un gruppo che ha un’immagine negativa; gli individui possono disapprovare i valori, gli atteggiamenti o i comportamenti del gruppo dissociativo e possono cercare di prendere le distanze da tali gruppi. [55]
Gli Opinion Leader possono agire come gruppi di riferimento in quanto esercitano una notevole influenza sociale grazie alla loro conoscenza del prodotto, competenza e credibilità. Nella letteratura di marketing, gli opinion leader sono anche conosciuti come influencer, esperti e persino hub. [89] Gli opinion leader sono specifici per una categoria di prodotto, quindi è improbabile che un opinion leader per i computer sia un opinion leader per la moda. In genere, gli opinion leader hanno alti livelli di coinvolgimento con la categoria di prodotto, sono grandi utilizzatori della categoria e tendono ad essere i primi ad adottare le nuove tecnologie all’interno della categoria. Giornalisti, celebrità e blogger sono buoni esempi di opinion leader grazie ai loro ampi social network e alla maggiore capacità di influenzare le decisioni delle persone. [55] In effetti, prove recenti suggeriscono che i blogger potrebbero emergere come un gruppo di opinion leader più importante rispetto alle celebrità. [90]
Per sfruttare il valore degli opinion leader nelle strategie di marketing, è importante essere in grado di identificare gli opinion leader unici per ogni categoria o situazione e questo può essere molto impegnativo. Alcune tecniche che possono essere utilizzate sono attraverso informatori chiave, tecniche sociometriche e auto-questionari. [91] Più spesso, tuttavia, gli esperti di marketing utilizzano l’istinto per identificare gli opinion leader. Ad esempio, è noto che i rivenditori di scarpe da ginnastica forniscono scarpe gratuite agli istruttori di palestra e di aerobica nella speranza che i membri della classe adottino la stessa marca dell’istruttore. I rivenditori di cosmetici e prodotti per la cura della pelle forniscono regolarmente agli editori di moda campioni gratuiti nella speranza che i loro prodotti vengano menzionati nelle riviste di moda.
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti –Influenze sui comportamenti di acquisto dei consumatori durante la pandemia di COVID-19
I dati dimostrano che alcuni comportamenti di acquisto dei consumatori sono diventati importanti durante la pandemia di COVID-19 [92] come risultato di fattori esterni e interni. Vale a dire, comportamenti come l’acquisto compulsivo, l’acquisto impulsivo, l’acquisto dettato dal panico e l’acquisto di vendetta – dove l’acquisto di panico e l’acquisto di vendetta erano più evidenti – si sono rivelati una strategia di coping per alleviare le risposte negative dei consumatori alla pandemia. [93]
Gli acquisti dettati dal panico si verificano quando i consumatori acquistano più cose del solito come conseguenza di sentimenti avversi di paura, ansia e incertezza che circondano una crisi o un evento dirompente. [94] Tali acquisti tendono ad essere eccessivi rispetto alla minaccia percepita. [95] Durante la pandemia, gli acquisti dettati dal panico di beni di prima necessità, come prodotti alimentari e igienici, sono aumentati in tutto il mondo. [93] Si consideri, in particolare, che l’Australia ha dovuto affrontare un picco senza precedenti nelle vendite di carta igienica, suscitando commenti da parte del suo Primo Ministro. [96] Gli acquisti dettati dal panico – in risposta al timore irrazionale della scarsità dei prodotti e all’accresciuta urgenza di procurarsi articoli ambiti – hanno fornito un senso di controllo ai consumatori durante la pandemia, nonostante una perdita di controllo negli ambienti sociali, professionali e sanitari che li circondano . [95]
Oltre agli acquisti dettati dal panico durante la pandemia, gli acquisti per vendetta sono stati evidenti durante i periodi in cui i negozi non essenziali hanno riaperto dopo i blocchi legati al COVID-19. [93] Gli acquisti per vendetta sono stati osservati specificamente nei negozi fisici di vendita al dettaglio di lusso. [93] Ad esempio, è stato riferito che un negozio Hermes a Guangzhou, in Cina, ha guadagnato 2,7 milioni di dollari nel primo giorno di apertura dopo il blocco, dove gli acquisti dei consumatori andavano da pelletteria, sciarpe e articoli per la casa a una borsa Birkin tempestata di diamanti. , tra le altre cose. [97]
L’acquisto di prodotti di lusso – dove “lusso” è definito come alta qualità, costoso e non necessario [98] – è associato a emozioni positive, spesso per compensare sentimenti negativi. [99] Vale a dire, l’acquisto per vendetta di prodotti di lusso ha fornito una liberazione emotiva e un senso di appartenenza, stima e autorealizzazione durante la pandemia di COVID-19, in cui le persone erano frustrate e psicologicamente a disagio. [100] Si può dire che tali acquisti abbiano raggiunto la gratificazione sensoriale e l’elusione dei problemi per i consumatori. [93]
È chiaro che i consumatori hanno cercato di ottenere la felicità interna attraverso il consumo come risposta alle crisi sanitarie esterne e alle misure di distanziamento sociale. [101] Sia l’acquisto di panico che l’acquisto di vendetta erano di natura compensativa e di natura terapeutica: un tentativo da parte dei consumatori di controllare una situazione esterna che era fuori dal loro controllo interno, oltre a fornire conforto, sicurezza e miglioramento del benessere. [93]
A causa delle tendenze ambientali, le persone iniziano a fare acquisti online di più per evitare i negozi fisici e rimanere senza contatto. Nel 2020 i clienti spenderanno di più in abbigliamento sportivo che in abbigliamento professionale e anche i prodotti tecnologici legati al telelavoro, come Zoom, hanno più consumatori di prima. [102]
Inoltre, gli studi hanno suggerito che dopo la pandemia, la consapevolezza delle persone sui rischi ambientali e sulla responsabilità della società di salvare il pianeta è aumentata, quindi le società hanno cambiato il loro comportamento di acquisto durante la pandemia. Le persone sceglieranno prodotti sostenibili anche se costano di più. Inoltre, negozi e marchi possono adottare un marketing sostenibile per costruire una nuova immagine di marca in grado di attirare i clienti. [103]
Kannan e Kulkarni illustrano anche alcuni fenomeni guidati dalla migrazione dei canali causata da COVID-19. Il primo fenomeno è che i clienti hanno una mentalità più aperta nel provare nuovi marchi e prodotti a causa della limitazione dei canali online di alcuni marchi; Il secondo fenomeno è che le restrizioni pandemiche di lunga data fanno sì che i clienti che utilizzano i canali online come sostituti dei loro acquisti offline inizialmente ora abbiano imparato a utilizzare efficacemente i canali online per la loro vita quotidiana. [102]
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Stili decisionali del consumatore
Si dice che coloro che fanno acquisti per piacere siano acquirenti ricreativi.
Numerosi teorici hanno sostenuto che è possibile identificare alcuni stili decisionali fondamentali. [104] [105] Uno stile decisionale è definito come un “orientamento mentale che caratterizza l’approccio del consumatore alle scelte”. [106] Sproles e Kendall (1986) hanno sviluppato un inventario degli stili di consumo (CSI) composto da otto fattori, come sensibilità al prezzo, consapevolezza della qualità, consapevolezza del marchio, ricerca di novità, consapevolezza della moda e abitudine. Sulla base di questi fattori, gli autori hanno sviluppato una tipologia di otto distinti stili decisionali: [107]
- Consapevole della qualità/perfezionista : caratterizzato dalla ricerca da parte del consumatore della migliore qualità nei prodotti; i consumatori attenti alla qualità tendono a fare acquisti sistematicamente effettuando più confronti e facendo acquisti in giro per confrontare qualità e valore.
- Attento al marchio : caratterizzato dalla tendenza ad acquistare marchi costosi e noti o griffe. Coloro che ottengono punteggi elevati in termini di consapevolezza del marchio tendono a credere che i prezzi più alti siano un indicatore di qualità e mostrano una preferenza per i grandi magazzini o i punti vendita di alto livello. Il concetto di consapevolezza del marchio può essere definito come la consapevolezza del marchio e delle sue offerte di prodotti che si distinguono dagli altri marchi sul mercato e hanno un vantaggio competitivo. I consumatori sono molto preoccupati di ciò che l’azienda del marchio pensa del suo nome e dei suoi prodotti.
- Attento alla ricreazione/edonistico : caratterizzato dal coinvolgimento del consumatore nel processo di acquisto. Coloro che hanno un punteggio elevato nella consapevolezza della ricreazione considerano lo shopping stesso come una forma di divertimento.
- Attento al prezzo : caratterizzato dalla consapevolezza del prezzo e del valore. Gli acquirenti attenti al prezzo si guardano intorno cercando prezzi più bassi, saldi o sconti e sono motivati dall’ottenimento del miglior rapporto qualità-prezzo.
- Novità/attenzione alla moda : caratterizzato dalla tendenza del consumatore a cercare nuovi prodotti o nuove esperienze per motivi di eccitazione; che traggono entusiasmo dalla ricerca di cose nuove; a loro piace tenersi aggiornati con mode e tendenze. La ricerca della varietà è associata a questa dimensione.
- Impulsivo : caratterizzato da negligenza nel prendere decisioni di acquisto, acquisti impulsivi e mancanza di preoccupazione significativa per i livelli di spesa o per l’ottenimento di valore. Coloro che ottengono punteggi elevati nelle dimensioni impulsive tendono a non essere coinvolti con l’oggetto né a livello cognitivo né emotivo.
- Confuso (per scelta eccessiva ) : caratterizzato dalla confusione del consumatore causata da troppe scelte di prodotto, troppi negozi o da un sovraccarico di informazioni sul prodotto. Un risultato del sovraccarico di informazioni .
- Abituale/fedeltà alla marca : caratterizzato dalla tendenza del consumatore a seguire un modello di acquisto di routine in ogni occasione di acquisto; i consumatori hanno marchi o negozi preferiti e hanno formato abitudini nella scelta, quindi la decisione di acquisto non implica molte valutazioni o acquisti in giro.
Il Consumer Styles Inventory (CSI) è stato ampiamente testato e riprovato in un’ampia varietà di paesi e contesti di acquisto. [108] Molti studi empirici hanno osservato variazioni interculturali negli stili decisionali, portando a numerosi adattamenti o modifiche della scala CSI per l’uso in paesi specifici. [109] Gli stili decisionali dei consumatori sono importanti per gli esperti di marketing perché descrivono comportamenti relativamente stabili nel tempo e sono quindi utili per la segmentazione del mercato. [110]
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti -Altri argomenti di psicologia del marketing
Oltre a comprendere la decisione di acquisto, gli esperti di marketing sono interessati a una serie di aspetti diversi della psicologia del marketing che si verificano prima, durante e dopo aver effettuato una scelta di acquisto. Le aree di particolare interesse includono la percezione del rischio e le attività di riduzione del rischio, il cambio di marca, il cambio di canale, la fedeltà alla marca, i comportamenti di cittadinanza del cliente e le intenzioni e i comportamenti comportamentali post-acquisto , tra cui la difesa del marchio, i referral, l’attività del passaparola, ecc.
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Percezione del rischio e attività di riduzione del rischio
La percezione del rischio da parte del consumatore è una considerazione importante nella fase pre-acquisto della decisione di acquisto. Il rischio percepito è definito come “la percezione del consumatore dell’incertezza e delle conseguenze negative derivanti dall’impegno in un’attività”. [111] Il rischio è costituito da due dimensioni: le conseguenze , che si riferiscono al grado di importanza o alla gravità di un risultato, e l’incertezza , che rappresenta la valutazione soggettiva del consumatore della probabilità che si verifichi. [112] Ad esempio, molti turisti hanno paura dei viaggi aerei perché, sebbene la probabilità di essere coinvolti in un incidente aereo sia molto bassa, le conseguenze sono potenzialmente disastrose.
La letteratura di marketing identifica molti diversi tipi di rischio, di cui cinque sono i più frequentemente citati: [113]
Facilitare la sperimentazione di un prodotto può aiutare ad alleviare la percezione del rischio.
- Rischio finanziario : la potenziale perdita finanziaria in caso di una decisione sbagliata
- Rischio prestazionale ( noto anche come rischio funzionale ): l’idea che un prodotto o un servizio non funzionerà come previsto
- Rischio fisico : il potenziale danno fisico se qualcosa va storto durante un acquisto
- Rischio sociale : il potenziale di perdita dello status sociale associato ad un acquisto
- Rischio psicologico : la possibilità che un acquisto provochi una perdita di autostima
Se un consumatore percepisce un acquisto rischioso, si impegnerà in strategie per ridurre il rischio percepito fino a quando non rientra nei suoi livelli di tolleranza o, se non è in grado di farlo, si ritirerà dall’acquisto. [114] Pertanto, la percezione del rischio da parte del consumatore guida le attività di ricerca di informazioni.
Gli operatori del marketing dei servizi hanno sostenuto che la percezione del rischio è più elevata per i servizi perché mancano degli attributi di ricerca dei prodotti (cioè proprietà tangibili che possono essere ispezionate prima del consumo). [115] In termini di percezione del rischio, gli esperti di marketing e gli economisti identificano tre ampie classi di acquisto: beni di ricerca , beni di esperienza e beni di credenza con implicazioni per i processi di valutazione dei consumatori. [116] I beni di ricerca, che includono la maggior parte dei prodotti tangibili, possiedono caratteristiche tangibili che consentono ai consumatori di valutare la qualità prima dell’acquisto e del consumo. I beni esperienziali, come ristoranti e club, possono essere valutati con certezza solo dopo l’acquisto o il consumo. Nel caso dei beni credenti, come molti servizi professionali, il consumatore ha difficoltà ad apprezzare appieno la qualità del bene anche dopo l’avvenuto acquisto e consumo. Possono sorgere difficoltà nel valutare la qualità dopo il consumo perché il costo per ottenere informazioni è proibitivo o perché il consumatore non ha le competenze e le conoscenze necessarie per intraprendere tali valutazioni. Questi beni sono chiamati prodotti di credenza perché le valutazioni di qualità del consumatore dipendono interamente dalla fiducia accordata al produttore del prodotto o al fornitore di servizi. [117]
Le tipiche strategie di riduzione del rischio utilizzate includono: [118] [119]
I potenziali acquirenti ispezionano attentamente la merce prima di acquistare costosi gioielli d’oro .
- Messaggi pubblicitari e promozionali : prestare maggiore attenzione alla promozione relativa al prodotto o al marchio, compresi i messaggi pubblicitari
- Shopping Around : confrontare offerte e prezzi, ispezionare la merce
- Acquistare un marchio noto : utilizzare un marchio noto e rispettabile come indicatore di merce di qualità
- Acquista da un negozio affidabile : affidarsi a un punto vendita affidabile come indicatore di qualità
- Recensioni di prodotti : lettura di recensioni indipendenti sui principali media (es. giornali, riviste), scritte da esperti indipendenti
- Recensioni di prodotti online o testimonianze generate dai consumatori : lettura delle esperienze di altri consumatori (ad esempio TripAdvisor, recensioni dei clienti Amazon)
- Campionamento o prova su scala limitata : ove possibile, ottenere campioni, prova gratuita o un “test drive” prima dell’acquisto
- Specifiche del produttore : lettura delle informazioni fornite dai produttori, ad esempio brochure o specifiche
- Referral : ottenere referral da amici o parenti
- Rappresentanti di vendita : parlare con i rappresentanti di vendita nei punti vendita
- Garanzie Prodotti : ricerca di garanzie o avalli formali
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Adozione di nuovi prodotti e diffusione delle innovazioni
Vedi anche: Diffusione delle innovazioni e modello di diffusione dei bassi
La diffusione delle innovazioni secondo Rogers. Man mano che gruppi successivi di consumatori adottano l’ innovazione ( mostrata in blu), la sua quota di mercato (gialla) alla fine raggiungerà il livello di saturazione.
All’interno della psicologia del marketing, una particolare area di interesse è lo studio di come nuovi prodotti, servizi, idee o tecnologie innovative si diffondono attraverso i gruppi. Approfondimenti su come le innovazioni vengono diffuse (cioè diffuse) tra le popolazioni possono aiutare gli operatori di marketing ad accelerare il processo di adozione del nuovo prodotto e a mettere a punto il programma di marketing nelle diverse fasi del processo di diffusione. Inoltre, i modelli di diffusione forniscono parametri di riferimento rispetto ai quali è possibile monitorare l’introduzione di nuovi prodotti.
Un’ampia letteratura è stata dedicata alla diffusione dell’innovazione. [120] Gli studi di ricerca tendono a rientrare in due grandi categorie: ricerca generale sulla diffusione, che è un approccio che cerca di comprendere il processo generale di diffusione, e ricerca applicata sulla diffusione, che consiste in studi che descrivono la diffusione di prodotti specifici in particolari momenti nel tempo o all’interno di determinate comunità sociali. [121] Nel complesso questi studi suggeriscono una certa regolarità nel processo di adozione; inizialmente pochi membri adottano l’innovazione ma col tempo ondate successive e sovrapposte di persone iniziano ad adottare l’innovazione. [122] Questo modello contribuisce a una curva generalizzata a forma di S, come mostrato nella figura a destra. Tuttavia, la forma esatta e la tempistica delle curve variano nei diversi mercati del prodotto, tanto che alcune innovazioni si diffondono in tempi relativamente brevi, mentre altre possono richiedere molti anni per ottenere un’ampia accettazione da parte del mercato.
Il modello di diffusione sviluppato da Everett Rogers è ampiamente utilizzato nel marketing dei consumatori perché segmenta i consumatori in cinque gruppi, in base al tasso di adozione del nuovo prodotto. [123] Rogers definisce la diffusione dell’innovazione come il processo attraverso il quale tale innovazione viene “comunicata attraverso determinati canali nel tempo tra i membri di un sistema sociale”. [124] Quindi il processo di diffusione comprende una serie di elementi, l’innovazione, i canali di comunicazione, il tempo e il sistema sociale. Un’innovazione è qualsiasi nuova idea, oggetto o processo che viene percepito come nuovo dai membri del sistema sociale. I canali di comunicazione sono i mezzi attraverso i quali le informazioni sull’innovazione vengono trasmesse ai membri del sistema sociale e possono includere mass media, media digitali e comunicazioni personali tra membri del sistema sociale. Il tempo si riferisce alla velocità con cui l’innovazione viene recepita dai membri del sistema sociale.
Tabella 1: Categorie di adottanti [125]
| Gruppo adottanti | Proporzione di tutti gli adottanti | Caratteristiche psicosociali e demografiche |
| Innovatori | 2,5% | · adottare nuovi prodotti o concetti con largo anticipo rispetto alla comunità sociale
· avventuroso ; come nuove idee · sono disposti ad accettare qualche incertezza/rischio nel processo decisionale di acquisto · sono ricercatori attivi di informazioni · Cosmopolita ; muoversi in ampi circoli sociali · avere accesso a risorse finanziarie (che aiutano ad assorbire potenziali perdite quando le innovazioni falliscono) · tendono ad essere utenti accaniti o entusiasti di categoria (ad esempio, i tecnici sono i primi ad adottare le nuove tecnologie di comunicazione) · tendono ad essere più giovani, istruiti e benestanti |
| Primi utilizzatori | 13,5% | · secondo gruppo per adottare nuovi prodotti o concetti
· non troppo avanti rispetto alla comunità in termini di innovazione · avere il rispetto delle loro comunità sociali · i potenziali adottanti guardano ai primi adottanti come modelli di ruolo · sono importanti opinion leader · status sociale più elevato e livello di istruzione elevato |
| Maggioranza anticipata | 34% | · terzo gruppo per adottare nuovi prodotti o concetti
· adottare innovazioni solo marginalmente superiori alla media della comunità · tendono ad essere più ponderati nel processo decisionale di acquisto · status sociale medio e livelli di istruzione |
| Maggioranza tardiva | 34% | · adottare nuovi prodotti o concetti leggermente più tardi della media
· scettico nel processo decisionale di acquisto · L’adozione è spesso una risposta alle pressioni della comunità sociale |
| Ritardatari | 16% | · ultimo gruppo ad adottare nuovi prodotti o concetti
· molto prudente; bisogna avere la certezza che un’innovazione non fallirà prima dell’acquisto · sono i più avversi al rischio tra tutti i segmenti degli adottanti; non mi piace il cambiamento · tradizionalisti ; resistente al cambiamento; guardare al passato · un po’ isolati all’interno della loro comunità sociale · spesso adottano innovazioni quando stanno diventando obsolete · tendono ad essere più anziani, meno istruiti e meno abbienti |
Una serie di fattori contribuiscono alla velocità con cui le innovazioni vengono diffuse attraverso una comunità sociale. [126]
Facilitare un “test drive” può incoraggiare i consumatori ad accelerare i tassi di adozione.
- Vantaggio relativo : il grado in cui un’innovazione è percepita come superiore alle alternative
- Compatibilità : la misura in cui un’innovazione si adatta ai valori, agli stili di vita e alle esperienze passate di un individuo
- Complessità : il grado in cui un’innovazione viene percepita come facile o difficile da comprendere e utilizzare
- Testabilità : la misura in cui un individuo può sperimentare l’innovazione su scala limitata prima dell’adozione
- Osservabilità : il grado in cui i risultati dell’innovazione sono visibili agli altri membri della comunità sociale
Le innovazioni che presentano alcuni o tutti questi fattori hanno maggiori probabilità di essere adottate rapidamente. Di conseguenza, le comunicazioni di marketing possono sottolineare i vantaggi relativi dell’innovazione rispetto ad altre soluzioni al problema del consumatore. I messaggi di marketing possono anche concentrarsi sulla compatibilità e sull’osservabilità. Gli operatori di marketing possono anche facilitare l’adozione offrendo prove su scala limitata (ad esempio campioni, test drive, vendita su approvazione) consentendo ai consumatori di sviluppare e comprendere l’innovazione e il modo in cui viene utilizzata prima dell’acquisto.
Gli studi hanno dimostrato che il tasso di diffusione di molte nuove tecnologie sta accelerando. [127] I dati contenuti nel rapporto Household Penetration of Selected Communications Technologies illustrano i tassi di penetrazione delle famiglie statunitensi di determinate tecnologie di comunicazione, misurati come percentuale di tutte le famiglie. [128] La pendenza della curva diventa più ripida con ogni innovazione successiva che indica un tasso di diffusione più rapido. Ad esempio, ci sono voluti decenni perché il telefono raggiungesse tassi di penetrazione del 50% a partire dal 1900 circa, ma ci sono voluti meno di cinque anni perché i cellulari raggiungessero gli stessi tassi di penetrazione. Per spiegare il ritmo crescente di adozione, alcuni hanno sottolineato questioni dal lato dell’offerta, come la riduzione delle barriere all’ingresso e i minori costi di innovazione, [129] [130] mentre altri hanno sostenuto che i consumatori determinano i tassi di adozione perché attribuiscono un’elevata incidenza valore sulla comodità delle nuove innovazioni. [131]
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Cambio di marca
Il cambio di marca avviene quando un consumatore sceglie di acquistare una marca diversa dalla marca normale o abituale. I consumatori cambiano marchio per una serie di motivi, tra cui il fatto che il negozio non aveva il marchio normale o il desiderio del consumatore di varietà o novità nella scelta del marchio. Nel mercato dei beni di consumo in rapida evoluzione (FMCG), l’incidenza del cambiamento è relativamente elevata. Gran parte dell’attività di marketing è mirata a chi cambia marca. Rossiter e Bellman hanno proposto una classificazione dei consumatori basata sulla fedeltà alla marca/ comportamento di cambiamento : [132]
Fedeli al marchio
Acquista la marca preferita in quasi ogni occasione di acquisto
Cambiatori di marca favorevoli
Mostrano una preferenza moderata per il marchio o i marchi che acquistano e possono essere facilmente indotti ad acquistare marchi concorrenti
Altri commutatori di marca
Normalmente acquistano un marchio concorrente, probabilmente perché non conoscono il nostro marchio o a causa di un’esperienza negativa con il nostro marchio
Utenti di nuova categoria
Coloro che non sono a conoscenza di una categoria ma hanno il potenziale per diventare nuovi utenti
Gli esperti di marketing sono particolarmente interessati a comprendere i fattori che portano al cambio di marca. Un ampio sondaggio globale condotto da Nielsen mostra che quattro acquirenti su 10 (41%) hanno affermato che ottenere un prezzo migliore li incoraggerebbe a cambiare marca (o fornitore di servizi/rivenditore), il 26% ha affermato che la qualità è un incentivo a cambiare, Il 15% auspicava un contratto di servizio migliore e l’8% ha affermato che le funzionalità migliorate costituiscono un incentivo al cambiamento. [133] Tuttavia, sono state osservate differenze interculturali tra gli intervistati. Il prezzo è stato il principale incentivo al cambiamento per oltre la metà dei nordamericani (61%) e degli europei (54% ) ma il prezzo e la qualità hanno avuto la stessa influenza in Asia-Pacifico e Medio Oriente/Africa, con circa un terzo degli intervistati in entrambi i casi. regioni che riferiscono che sia il prezzo che la qualità costituivano i principali incentivi al passaggio.
Il concetto di costo di cambiamento (noto anche come barriere di cambiamento ) è pertinente alla comprensione del cambiamento di marca. I costi di cambio si riferiscono ai costi sostenuti da un consumatore quando passa da un fornitore a un altro (o da una marca a un’altra). Sebbene i costi di cambiamento siano spesso monetari, il concetto può anche riferirsi a costi psicologici come tempo, fatica e disagi sostenuti a seguito del cambiamento. Quando i costi di cambiamento sono relativamente bassi, come nel caso di molti beni di largo consumo (FMCG), l’incidenza del cambio di marca tende ad essere maggiore. [ citazione necessaria ] Un esempio di passaggio che include costi sia monetari che psicologici è quando gli utenti Android o Apple desiderano passare a una piattaforma diversa, dovrebbero sacrificare i propri dati, inclusi brani musicali, app o contenuti multimediali acquistati e potrebbero anche aver bisogno imparare nuove routine per diventare un utente efficiente.
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Cambio di canale
L’avvento dei “killer di categoria”, come Officeworks australiano, ha contribuito ad un aumento del comportamento di cambio canale .
Il cambio di canale (da non confondere con lo zapping o la navigazione tra i canali in TV) è l’azione dei consumatori che passano a un diverso ambiente di acquisto (o canale di distribuzione) per acquistare beni, ad esempio passando dai negozi fisici a Internet. [134] Una delle ragioni principali di questo comportamento di cambio canale è la comodità che lo shopping online offre ai consumatori. I consumatori possono fare acquisti online a qualsiasi ora del giorno, senza dover guidare, viaggiare o camminare per raggiungere un negozio fisico, e navigare per tutto il tempo che desiderano. Il richiamo aggiuntivo delle offerte e degli sconti “solo online” aiuta a rafforzare la preferenza del consumatore per gli acquisti online. Altri fattori responsabili di questo cambiamento sono la globalizzazione dei mercati, l’avvento di categorie killer (come Officeworks e Kids ‘R Us ) nonché i cambiamenti nel contesto normativo legale. Ad esempio, in Australia e Nuova Zelanda, a seguito di un allentamento delle leggi che vietano ai supermercati di vendere prodotti terapeutici, i consumatori stanno gradualmente abbandonando le farmacie per rivolgersi ai supermercati per l’acquisto di analgesici minori, preparati per la tosse e il raffreddore e medicinali complementari come vitamine e medicinali a base di erbe. rimedi. [135]
Per il consumatore, il cambio di canale offre un’esperienza di acquisto più diversificata. Tuttavia, gli esperti di marketing devono prestare attenzione al cambio di canale a causa del potenziale di erosione della quota di mercato. L’evidenza di un cambio di canale può suggerire che sono in gioco forze dirompenti e che la psicologia del marketing sta subendo cambiamenti fondamentali. Un consumatore può essere spinto a cambiare canale quando il prodotto o il servizio può essere trovato a un prezzo inferiore, quando diventano disponibili modelli superiori, quando viene offerta una gamma più ampia o semplicemente perché è più conveniente fare acquisti attraverso un canale diverso (ad esempio online o tramite un unico canale). smettere di fare acquisti). [136] Come copertura contro le perdite di quote di mercato dovute al comportamento di cambiamento , alcuni rivenditori si impegnano nella vendita al dettaglio multicanale. [137]
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Acquisti impulsivi
Secondo una ricerca del 1962 di Hawkins Stern, gli acquisti d’impulso rientrano in quattro categorie: compreso l’acquisto d’impulso puro, l’acquisto d’impulso ricordato, l’acquisto d’impulso suggerito e l’acquisto d’impulso pianificato. [138] Mentre l’acquisto d’impulso puro coinvolge un cliente che sperimenta un forte desiderio per un prodotto che inizialmente non aveva pianificato di acquistare, l’acquisto d’impulso ricordato si verifica quando un acquirente ricorda la necessità di un prodotto vedendolo in un negozio. [48] [139] L’acquisto d’impulso suggerito si verifica quando un consumatore vede un prodotto di cui non ha alcuna conoscenza preliminare, ne immagina un utilizzo e decide che ne ha bisogno, e l’acquisto d’impulso pianificato avviene quando il piano di acquisto di un consumatore cambia durante lo shopping.
È più probabile che le torte formato famiglia siano un acquisto pianificato, mentre le porzioni individuali hanno molte più probabilità di essere un acquisto non pianificato.
Una ricerca del 2013 condotta da Nielsen International suggerisce che circa il 72% degli acquisti di beni di largo consumo sono pianificati, ma che il 28% degli acquisti nei supermercati sono acquisti non pianificati o impulsivi. I principali acquisti non pianificati nella categoria alimentare sono caramelle ( lecca lecca ), cioccolato, biscotti, dessert surgelati e snack, mentre i principali acquisti non pianificati nella categoria non alimentare sono cosmetici, deodoranti per ambienti, spazzolini da denti, saponi per le mani, e lozioni per mani/corpo. [140] Ciò spiega perché i supermercati collocano questi tipi di prodotti nella parte anteriore del negozio o vicino alla cassa, dove il consumatore trascorre più tempo ed è più propenso a notarli e quindi a inserirli nel carrello. I rivenditori utilizzano le informazioni ricavate da questo tipo di ricerca per progettare i negozi in modo da massimizzare le opportunità di acquisto d’impulso.
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti –Affetto: emozioni, sentimenti e umore
Lo stato affettivo del consumatore ha implicazioni per una serie di dimensioni diverse della psicologia del marketing, tra cui la ricerca di informazioni, la valutazione delle alternative, la scelta del prodotto, gli incontri con il servizio, i reclami e le risposte pubblicitarie. Westbrook (1987, p. 259) definisce l’affetto come una “classe di fenomeni mentali caratterizzati unicamente da uno stato affettivo soggettivo, sperimentato consapevolmente, che comunemente accompagna emozioni e stati d’animo”. [141] La ricerca suggerisce che l’affetto gioca un ruolo importante negli atteggiamenti sottostanti, oltre a modellare la valutazione e il processo decisionale. [142]
I ricercatori sui consumatori hanno notato le difficoltà nel separare i concetti di affetto, emozioni, sentimenti e umore. Il confine tra emozioni e umore è difficile da tracciare e i ricercatori sui consumatori spesso utilizzano i concetti in modo intercambiabile. [143] Ancora altri ricercatori notano che una comprensione dettagliata della relazione tra affetto e psicologia del marketing è stata ostacolata dalla mancanza di ricerca nell’area. [144] In effetti, all’interno della letteratura sulla psicologia del marketing, vi è un ampio consenso sul fatto che il ruolo delle emozioni è un’area attualmente poco studiata e che necessita di maggiore attenzione, sia teoricamente che empiricamente.
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Ricerca informazioni
Gli studi hanno scoperto che le persone di umore positivo sono più efficienti nelle attività di ricerca di informazioni. Cioè sono più efficienti nell’elaborazione delle informazioni, sono in grado di integrare le informazioni identificando relazioni utili e arrivare a soluzioni creative ai problemi. Grazie alla loro efficienza nell’elaborazione delle informazioni, coloro che sono di umore positivo sono generalmente più veloci nel prendere decisioni e più facili da accontentare. La ricerca mostra costantemente che le persone di umore positivo hanno maggiori probabilità di valutare le informazioni in modo positivo. [145] Poiché gli ambienti online diventano sempre più importanti come strumento di ricerca per i consumatori, potrebbe essere prudente che i web designer considerino questioni di progettazione del sito come la facilità di navigazione, per evitare che una progettazione scadente contribuisca alla frustrazione dei clienti generando così cattivo umore e portando infine a valutazioni sfavorevoli del prodotto/marchio.
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Scelta
Il piacere immediato di mangiare caramelle spesso supera i benefici a lungo termine di una scelta alimentare più sana.
L’affetto può svolgere un ruolo importante nelle decisioni di acquisto impulsivo . La ricerca suggerisce che i consumatori attribuiscono un peso maggiore alle ricompense e alle punizioni affettive immediate, mentre le ricompense ritardate ricevono un peso minore. [146] Ad esempio, il piacere immediato di mangiare un dolce spesso supera i benefici a lungo termine di mangiare un’alternativa sana come la frutta. Ciò si verifica perché il guadagno emotivo immediato è un forte fattore che i consumatori possono facilmente visualizzare , mentre l’obiettivo più distante non ha la forza sufficiente per guidare la scelta.
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti –Esperienza del cliente
I clienti di cattivo umore sono più difficili da accontentare. Sono più lenti nell’elaborare le informazioni e di conseguenza impiegano più tempo a prendere decisioni. Tendono ad essere più polemici e hanno maggiori probabilità di lamentarsi.
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Soddisfazione del cliente
La relazione tra affetto e soddisfazione del cliente è un’area che ha ricevuto notevole attenzione accademica, soprattutto nella letteratura sul marketing dei servizi. [147] L’affermazione che esiste una relazione positiva tra affetto e soddisfazione è ben supportata in letteratura. In una meta-analisi delle prove empiriche, condotta nel 2001, Szymanski et al., suggeriscono che l’affetto può essere sia un antecedente che un risultato della soddisfazione. Si propone che le emozioni suscitate durante il consumo lascino tracce affettive nella memoria a cui i consumatori possono accedere e integrarsi nelle loro valutazioni di soddisfazione. [148]
Una meta-analisi del 2011 [149] illustra come sia l’intenzione di riacquisto che la fedeltà godano di una forte relazione positiva (0,54) con la soddisfazione del cliente. Un’altra [150] meta-analisi rileva che “I risultati indicano che sia le variabili legate alle funzioni cognitive (inclusa la consapevolezza del marchio, la personalità del marchio e l’identità del marchio) sia le variabili legate all’edone (incluso l’atteggiamento edonico, l’intrattenimento e l’attrattiva estetica) hanno impatti significativi sulla percezione della qualità e del valore nei confronti del marchio (inclusi qualità percepita, reputazione, immagine del marchio, valore percepito, impegno e fiducia). Inoltre, queste variabili sono tutti predittori significativi della fedeltà al marchio.
Una terza [151] meta-analisi, del 2013, elabora il concetto di personalità del marchio (BP): “In primo luogo, i fattori chiave della BP sono la comunicazione con dichiarazioni di benefici edonistici, le attività di branding, il paese di origine del marchio e le informazioni del consumatore. In secondo luogo, lo studio rileva che gli effetti della BP sono più forti per i marchi maturi che per i marchi nelle prime fasi del ciclo di vita. In terzo luogo, la sincerità e la competenza hanno la maggiore influenza sulle variabili di successo del marchio (ad esempio, l’atteggiamento del marchio, l’immagine, l’impegno, intenzione di acquisto), mentre l’eccitazione e la durezza hanno l’influenza più debole sull’atteggiamento e sull’impegno del marchio.”
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti –Pubblicità
L’emozione può svolgere un ruolo importante nella pubblicità. Nella pubblicità, sono comuni due diversi approcci alla persuasione: (a) annunci pensati che richiedono elaborazione cognitiva (noto anche come percorso centrale verso la persuasione ) e (b) annunci con sensazioni che vengono elaborati a livello emotivo (noto anche come percorso periferico ). itinerario ). [152] Gli inserzionisti possono aggirare l’elaborazione cognitiva e razionale che può portare a controargomentazioni semplicemente facendo appello alle emozioni. Gli studi di neuroimaging suggeriscono che quando valutano i marchi, i consumatori utilizzano principalmente le emozioni (sentimenti ed esperienze personali) piuttosto che le informazioni (attributi, caratteristiche e fatti del marchio). [153]
È relativamente ampiamente accettato che le risposte emotive richiedano meno risorse di elaborazione (cioè siano più facili) e si traducano anche in associazioni più durature con il marchio pubblicizzato. [154] I sentimenti suscitati dal messaggio pubblicitario possono modellare gli atteggiamenti nei confronti del marchio e della pubblicità. [155]
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti –Fedeltà del cliente
Vedere anche: marketing fedeltà , fidelizzazione dei clienti , fedeltà al marchio , programma fedeltà e programma fedeltà dei clienti
Fedeltà del cliente , definita come “la relazione tra l’atteggiamento relativo di un individuo e il clientelismo ripetuto” (Dick e Basu, 1994: p. 99). Pertanto, per definizione, la lealtà ha sia una componente attitudinale che una componente comportamentale . Dick e Basu hanno proposto quattro tipi di lealtà basati sull’atteggiamento relativo e sul comportamento clientelare : [156]
La matrice della lealtà di Dick e Basu
Nessuna lealtà
Caratterizzato da un atteggiamento relativo basso e da un basso comportamento clientelare ripetuto . Può verificarsi quando i marchi concorrenti sono visti come simili o nel caso di nuovi marchi (o categorie) per i quali non è trascorso tempo sufficiente affinché la fedeltà si stabilisca.
Fedeltà spuria
Caratterizzato da un atteggiamento relativo basso e da un alto patrocinio ripetuto. La lealtà spuria si verifica quando il consumatore effettua acquisti ripetuti a causa di fattori situazionali come l’accesso e la comodità. o posizionamento sugli scaffali. La lealtà fittizia può verificarsi anche quando non esistono alternative reali o quando il consumatore è “vincolato” all’acquisto di un determinato marchio a causa di un accordo quasi contrattuale o di uno status di membro che crea difficoltà per il cambiamento. In altre parole, laddove i costi di cambiamento sono relativamente elevati, si può osservare un elevato comportamento di clientelismo nonostante l’assenza di un atteggiamento favorevole nei confronti del marchio. Un esempio potrebbe essere un consumatore che mentre va al lavoro acquista la benzina sempre nello stesso punto vendita perché non ci sono altri punti vendita nelle vicinanze.
Fedeltà latente
Caratterizzato da un elevato atteggiamento relativo e da un basso patrocinio ripetuto. La lealtà latente si verifica quando i fattori situazionali prevalgono su forti atteggiamenti favorevoli . Ad esempio, una persona potrebbe avere un ristorante preferito ma potrebbe non frequentarlo a causa delle preferenze dei commensali.
Lealtà
(cioè vera lealtà) Caratterizzato da un atteggiamento favorevole e da un comportamento clientelare favorevole . Per gli esperti di marketing, la vera lealtà è la situazione ideale.
I programmi frequent flyer sono tra i programmi premio più conosciuti .
di fidelizzazione si basano sulla consapevolezza che acquisire un nuovo cliente costa 5-20 volte di più che fidelizzare un cliente esistente. [157] Gli esperti di marketing utilizzano una varietà di programmi di fidelizzazione per rafforzare l’atteggiamento dei clienti nei confronti del marchio (o del fornitore di servizi/rivenditore) al fine di fidelizzare i clienti, ridurre al minimo le defezioni dei clienti e rafforzare i legami di fedeltà con i clienti esistenti. In generale esistono due tipi di programmi : programmi di ricompensa e programmi di riconoscimento. In un Programma Premio , il cliente accumula punti per ogni acquisto, e i punti possono successivamente essere scambiati con beni o servizi. [158] I programmi di riconoscimento operano su una base di quasi-iscrizione in cui al consumatore viene rilasciata una carta che, dietro presentazione, dà diritto a vari diritti come aggiornamenti gratuiti, privilegi speciali o accesso a prodotti/servizi che normalmente non sono disponibili ai non membri e che riconoscere lo status “VIP” del cliente affezionato. [159] Ad esempio, un hotel potrebbe riconoscere i clienti fedeli fornendo un cesto di frutta e una bottiglia di champagne in omaggio in camera all’arrivo. Mentre i programmi di ricompensa sono motivati dal desiderio del consumatore di beni materiali, i programmi di riconoscimento sono motivati dal bisogno di stima, riconoscimento e status del consumatore. Molti programmi di fidelizzazione commerciale sono schemi ibridi, che combinano elementi sia di ricompensa che di riconoscimento. Inoltre, non tutti i programmi di ricompensa sono progettati per incoraggiare la fedeltà. Alcuni programmi di ricompensa sono progettati per incoraggiare altri tipi di comportamento positivo dei clienti come la fornitura di referenze o la fornitura di raccomandazioni positive tramite passaparola ( WOM ). [160]
Il marketing di fidelizzazione può comportare l’uso di database e software sofisticati per analizzare e profilare i segmenti di fidelizzazione dei clienti al fine di identificare i segmenti più desiderabili, stabilire obiettivi per ciascun segmento e, infine, tentare di aumentare le dimensioni della base di clienti fedeli.
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti –Comportamento di cittadinanza del cliente
Il comportamento di cittadinanza del cliente è il lavoro che i clienti svolgono per i marchi in cambio di fedeltà. [161] La letteratura sul marketing dei servizi [ chi? ] identifica sette tipi distinti di comportamento di cittadinanza : [162] voce (quando i clienti rivolgono il loro reclamo al fornitore di servizi per rettificare e mantenere la relazione), manifestazione di affiliazione, polizia (l’osservazione di altri clienti per garantire il loro comportamento appropriato ) , flessibilità, miglioramento del servizio (fornire idee e suggerimenti alle organizzazioni ), passaparola e atti di servizio benevoli.
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti –Psicologia del marketing su Internet
I modelli tradizionali di psicologia del marketing sono stati sviluppati da studiosi come Fishbein e Ajzen [163] e Howard e Sheth [164] negli anni ’60 e ’70. Più recentemente, Shun e Yunjie hanno sostenuto che la psicologia del marketing online è diversa dal comportamento offline e di conseguenza richiede nuove teorie o modelli. [165] Dopo il COVID-19, la psicologia del marketing online sembra più essenziale, perché da quando è iniziato il COVID-19, circa il 31% in più di persone ha iniziato a fare acquisti online con il 43% di tutti gli intervistati rispetto a solo il 12% degli intervistati prima del COVID-19. [166]
La ricerca ha identificato due tipi di valore del consumatore nell’acquisto, vale a dire il valore del prodotto e il valore dello shopping. È probabile che il valore del prodotto sia simile sia per gli acquirenti online che per quelli offline. Tuttavia, l’esperienza di acquisto sarà sostanzialmente diversa per gli acquirenti online. In un ambiente di acquisto offline, i consumatori traggono soddisfazione dall’essere all’interno dell’ambiente del negozio fisico o del panorama della vendita al dettaglio (motivazioni edonistiche). Nel caso degli acquisti online, gli acquirenti traggono soddisfazione dalla capacità di navigare in un sito web e dalla comodità della ricerca online che consente loro di confrontare i prezzi e di “guardarsi intorno” con un impegno di tempo minimo. Pertanto il consumatore online è motivato da fattori più utilitaristici. [167]
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti –Diversi tipi di comportamento online
I consumatori possono utilizzare le piattaforme online per varie fasi della decisione di acquisto. Alcuni consumatori utilizzano fonti online semplicemente per acquisire informazioni sugli acquisti pianificati. Altri utilizzano piattaforme online per effettuare l’acquisto vero e proprio. In altre situazioni, i consumatori possono anche utilizzare piattaforme online per intraprendere comportamenti post-acquisto , come rimanere in contatto con un marchio unendosi a una comunità di marchio. Oppure possono diventare sostenitori del marchio pubblicando una recensione del prodotto online o fornendo riferimenti al marchio tramite i social media. Alcuni fornitori di e-commerce hanno incontrato difficoltà nel corteggiare i consumatori che cercano informazioni online, ma preferiscono comunque rivolgersi ai rivenditori fisici per i loro acquisti. Per comprendere le esigenze e le abitudini di questi e altri tipi di acquirenti online, gli esperti di marketing online hanno segmentato i consumatori in diversi tipi di comportamento online in base alle loro caratteristiche comportamentali online . Lewis e Lewis (1997) hanno identificato cinque segmenti di mercato in base al modo in cui i consumatori utilizzano Internet nel processo decisionale di acquisto: [168]
- I “cercatori diretti di informazioni” sono utenti che cercano principalmente informazioni su un prodotto o servizio online, ma non vi è alcuna garanzia che possano essere convertiti in acquirenti online.
- I “cercatori di informazioni non indirizzati” sono i nuovi arrivati a un prodotto o servizio. È più probabile che interagiscano con le istruzioni online e facciano clic sulle pagine Web collegate nella pubblicità.
- Gli “Acquirenti Diretti” hanno una mentalità predeterminata e desiderano acquistare un prodotto o un servizio specifico online.
- I “cacciatori di occasioni” sono utenti attenti al prezzo che amano scoprire i prodotti durante le promozioni. Per questi utenti, gli sconti rappresentano una grande attrazione per la conversione delle vendite online.
- I “cercatori di intrattenimento” sono consumatori online attratti dal marketing offerto come attività divertente. I giochi online interattivi potrebbero essere utili per attirare questo tipo di clienti.
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti –Una tipologia di psicologia del marketing online
Wendy Moe (2003) [169] sostiene che nell’ambiente offline, i consumatori che fanno acquisti nei negozi possono essere facilmente classificati da addetti alle vendite esperti solo osservando i loro comportamenti di acquisto . Tale classificazione potrebbe non apparire online, ma Moe e Fader [170] hanno sostenuto che è possibile prevedere l’azione pratica di acquisto, navigazione e ricerca online indagando i modelli di clic e la ripetizione della visita all’interno del comportamento online . Inoltre, un rapporto di E-consultancy sul “benchmarking dell’esperienza dell’utente” ha delineato tre tipi di comportamento di consumo online come classificazione preziosa per la ricerca sulla progettazione di pagine web per servire meglio diversi tipi di comportamento di consumo . Le tre categorie sono: “tracker”, “cacciatori” ed “esploratori”.
- I “tracker” sono i consumatori online che stanno esattamente cercando un prodotto che desiderano assolutamente acquistare. Usano Internet per informazioni sul prezzo, sui metodi di consegna, sul servizio post-acquisto e così via. Una volta che hanno trovato le informazioni corrette, è necessario poco sforzo per consentire loro di svolgere l’attività.
- I “cacciatori” conoscono solo le categorie del prodotto di cui hanno bisogno, ad esempio un romanzo per il tempo libero. Tuttavia, non hanno preso una decisione specifica su quale romanzo acquistare. Usano Internet per trovare un elenco di prodotti delle categorie necessarie per effettuare un confronto. Questo tipo di consumatore online ha bisogno di consigli e aiuto per svolgere la propria attività.
- Gli “esploratori” non hanno in mente nemmeno le categorie di prodotto. In realtà, vogliono solo comprare qualcosa online. C’è più incertezza su questo tipo di consumatori online.
Influenza di Internet sul processo di acquisto
| Tabella [171] Impatto di Internet sul processo di acquisto hide | ||||||
| Entra in scena
processo di acquisto |
1 Inconsapevole | 2 Consapevole delle necessità del prodotto
sviluppare specifiche |
3 Fornitore
ricerca |
4 Valutare e
Selezionare |
5 Acquistare | 6 Valutazione post-acquisto
e feedback |
| Comunicazioni
obiettivi |
Generare consapevolezza | Caratteristiche della posizione,
vantaggio e marchio |
Generazione di lead
(dalla gamma di clienti) |
Assistere all’acquisto
decisione |
Facilitare l’acquisto | Supporta l’uso e
mantenere gli affari |
| Internet Marketing
tecniche |
Banner pubblicitari,
PR, collegamenti |
Contenuto del sito Web
( più supporto per la ricerca) |
Motori di ricerca,
intermedi |
Contenuto del sito Web
intermedi |
Contenuto del sito Web | Contenuti del sito web personalizzati
e interazione |
Come mostra la tabella precedente, la prima riga indica il processo di acquisto di un nuovo prodotto da parte di un consumatore, mentre la seconda e la terza riga illustrano le influenze positive che Internet potrebbe avere sul processo di acquisto creando comunicazioni efficaci con i consumatori online. Ad esempio, supponiamo che un consumatore veda con noncuranza una pubblicità sui laptop su Wechat , un popolare social media cinese sviluppato da Tencent . Comincia a sentire che il suo portatile è un po’ antiquato e vuole comprarne uno nuovo, che è il risultato di una buona pubblicità posta su uno strumento Internet quotidiano. Non sa nulla su come acquistarne uno nuovo dato che oggi il business cambia così velocemente, quindi cerca su Google per trovare una risposta. Nella pagina dei risultati trova annunci promozionali che provengono principalmente da JD.com e Taobao , due rivenditori online cinesi concorrenti in questo campo. Preferisce utilizzare JD.com , che fornisce confronti dettagliati di marchi, prezzi, località e metodi di pagamento e consegna. Dopo un’attenta selezione, effettua l’ordine tramite JD.com tramite pagamento Wechat . JD.com ha uno dei canali di distribuzione più veloci in Cina e supporta un eccellente servizio post-acquisto per mantenere la propria posizione sul mercato.
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti –Il ruolo dell’estetica e della fluidità visiva in relazione alla scelta del consumatore
I consumatori decidono se un prodotto gli piace o meno entro 90 secondi dalla prima visione. [172] Pertanto, avere un prodotto esteticamente gradevole è essenziale sul mercato. Studi sulla fluidità di elaborazione e sulla psicologia del marketing hanno rivelato che “le persone preferiscono visualizzazioni visive più facili da elaborare e comprendere”. [173] e “Quando un prodotto corrisponde alle associazioni dell’utente con esso, viene percepito come più attraente”. [173] I prodotti visivamente fluidi attingono alle associazioni preesistenti del consumatore con i loro elementi di design, portando a un senso di familiarità e comprensione con il prodotto a portata di mano. Segnali visivi come colore , composizione, tipografia e immagini sono associati al fenomeno della fluidità.
Colore
Vedi anche: Psicologia del colore
Nessun marchio di nome è associato all’economia e alla convenienza. A causa dell’associazione del giallo con l’economicità, il logo di questo marchio viene elaborato in modo fluido e semplice dai consumatori.
La ricerca sulla psicologia del colore ha dimostrato che il 62-90% della valutazione dei prodotti di consumo si basa solo sul colore . [172] In effetti, è stato dimostrato che i colori sono collegati alle percezioni dei consumatori [174] sulla qualità, l’affidabilità e il valore di un prodotto. I colori blu e nero sono considerati più affidabili, preziosi e costosi mentre il giallo, l’arancione e il marrone sono associati a buon mercato e bassa qualità. [175] Pertanto, un prodotto destinato ad essere percepito come “di alta qualità” con una tavolozza prevalentemente arancione e marrone mancherebbe di fluidità visiva e probabilmente non riuscirebbe a suscitare una risposta positiva tra i consumatori. Tuttavia, ciò può essere vantaggioso se il consumatore è già alla ricerca di un articolo noto per essere poco costoso, nel qual caso l’uso del giallo, dell’arancione o del marrone sarebbe appropriato. Il colore può anche essere utilizzato per segnalare la personalità del marchio. [176]
Composizione
La composizione è un altro strumento visivo che ha la capacità di influenzare l’elaborazione delle informazioni e influenzare le percezioni dei consumatori. Gli studi hanno dimostrato che i consumatori nei paesi occidentali associano i prodotti allineati a destra o posizionati sul lato destro di un display a una qualità superiore. [177] Gli esseri umani hanno anche un pregiudizio centrale, che fa sì che i prodotti centrati o simmetrici nella composizione o nella visualizzazione sembrino intrinsecamente più piacevoli. [177] I prodotti centrati nella composizione o con elementi centrati sono percepiti come più attraenti, popolari e importanti rispetto ai prodotti allineati a sinistra o a destra. [178] Quando un oggetto è centrato dal punto di vista compositivo, è più facile per lo spettatore interpretarlo e comprenderlo. Diventa più “fluido” e quindi esteticamente più gradevole. [179]
Immagini
Le prove hanno dimostrato che le immagini pittoriche sono correlate a casi più elevati di ricordo e riconoscimento del consumatore. Le immagini pittoriche sono anche più facili da elaborare e attirano più rapidamente l’attenzione del consumatore. [180] Esistono prove significative che quando ai consumatori vengono presentate più scelte, vedranno gli oggetti in modo più positivo ed esteticamente più gradevoli se circondati da immagini congruenti. [179] Dopo un’esposizione ripetuta, queste immagini familiari vengono incorporate nel lessico visivo del consumatore e ne diventano “fluenti”. Le immagini con livelli più elevati di fluidità visiva sono percepite come più familiari, simpatiche e amichevoli e hanno quindi maggiori probabilità di essere scelte dai consumatori. [181]
Elementi tipografici
Sebbene gli studi abbiano dimostrato che le immagini pittoriche sono più facili da elaborare e comprendere per i consumatori, [180] la scelta della tipografia rimane un elemento indispensabile del design del prodotto. I caratteri scritti a mano e con script sono associati all’individualità, alla femminilità e al lusso, mentre i caratteri sans serif incarnano energia, pulizia e modernità. [182] È stato anche dimostrato che la dimensione del carattere ha una correlazione diretta con gli attributi emotivi assegnati a un prodotto. Uno studio ha dimostrato che le dimensioni e il peso dei caratteri più grandi sono percepiti come più intimidatori e autorevoli. [183] Sebbene le immagini regnino sovrane nella progettazione del prodotto, è importante notare che il tipo viene elaborato con la stessa facilità delle informazioni pittoriche quando il consumatore ha già familiarità con il prodotto.
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti –Impatto ambientale
Un aspetto dell’azione individuale sul cambiamento climatico è la psicologia del marketing che influenza quanto e quali tipi di materiali vengono utilizzati per produrre beni e cibo, quanto materiale viene riciclato o compostato , quanto finisce come inquinamento, quanto finisce nelle discariche , dove vengono prodotti i beni, la distanza percorsa e l’ impronta di carbonio della produzione, del trasporto e dello smaltimento. Il marketing verde si rivolge ai consumatori che tengono conto dell’impatto ambientale dei loro acquisti. Uno studio del 2017 non ha rilevato alcun impatto del marketing verde sulla psicologia del marketing in Bangladesh. [ citazione necessaria ] Lo studio suggerisce che siano adottate politiche che riducano il costo dei prodotti ecologici. Incoraggia inoltre l’implementazione di programmi che sensibilizzino i consumatori riguardo al tema del consumo verde .
Ci sono fattori psicologici che contribuiscono alla percezione del consumatore riguardo al proprio contributo personale alle azioni che inducono il cambiamento climatico. Uno dei pregiudizi più studiati è indicato come il pregiudizio “migliore della media” o di auto-miglioramento. [184] Questo pregiudizio descrive la tendenza di un individuo a percepire che le proprie azioni sono superiori, soprattutto se confrontate con colleghi o consumatori demograficamente simili. È stato scoperto che questo pregiudizio cognitivo è effettivamente presente quando si considera il modo in cui i consumatori percepiscono i loro sforzi a favore dell’ambiente. [184] Ciò potrebbe essere il risultato di informazioni sul cambiamento climatico che portano a sentimenti di colpa e preoccupazione, che attivano un processo di pensiero inconscio (negazione, effetto superiore alla media e altre reazioni cognitive) che porta a una ridotta percezione di la minaccia del cambiamento climatico. Si tratta di un meccanismo di difesa mentale che alla fine porta a una riduzione della responsabilità individuale percepita nel prendere parte a comportamenti ecologici e alla vita su un unico pianeta. [184]
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti -Metodi di ricerca utilizzati
Vedi anche: Ricerche pubblicitarie
Per ottenere informazioni approfondite sulla psicologia del marketing, i ricercatori utilizzano la serie standard di metodi di ricerca di mercato come sondaggi , interviste approfondite e focus group . Sempre più spesso i ricercatori si rivolgono a metodologie e tecnologie più nuove nel tentativo di cercare una comprensione più profonda del motivo per cui i consumatori si comportano in determinati modi. Questi metodi più recenti includono la ricerca etnografica (nota anche come osservazione partecipante) e le neuroscienze , nonché progetti di laboratorio sperimentali. Inoltre, i ricercatori spesso si rivolgono a discipline separate per ottenere approfondimenti potenzialmente utili per lo studio della psicologia del marketing. Ad esempio, l’economia comportamentale sta aggiungendo nuove intuizioni su alcuni aspetti della psicologia del marketing.
Ricerca etnografica
Gli studi sull’utilizzo del prodotto vengono utilizzati per migliorare la progettazione dell’imballaggio.
La ricerca etnografica o etnografica ha le sue origini nell’antropologia . Tuttavia, gli esperti di marketing utilizzano la ricerca etnografica per studiare il consumatore in termini di tendenze culturali, fattori di stile di vita, atteggiamenti e il modo in cui il contesto sociale influenza la selezione, il consumo e l’utilizzo del prodotto. La ricerca etnografica, chiamata anche osservazione partecipante , tenta di studiare la psicologia del marketing in contesti naturali piuttosto che in ambienti artificiali come i laboratori. Diversi tipi di ricerca etnografica vengono utilizzati nel marketing , tra cui; [185]
- Utilizzo osservato del prodotto: osservare l’utilizzo regolare del prodotto a casa o al lavoro, per ottenere informazioni su come i prodotti vengono aperti, preparati, consumati, conservati, smaltiti, ecc. per ottenere informazioni sull’utilità dell’imballaggio, dell’etichettatura e dell’uso generale
- Studi quotidiani: visite prolungate durante le situazioni di utilizzo del prodotto per ottenere informazioni dettagliate sulle norme e sulle aspettative dei consumatori
- Acquisto accompagnato o shop- along : il ricercatore accompagna un acquirente in una spedizione di acquisto per ottenere informazioni dettagliate sulle risposte dei consumatori al merchandising e ad altre tattiche di vendita
- Studi culturali : simili all’etnografia tradizionale; soggiorni prolungati con un gruppo o una tribù con l’obiettivo di scoprire le regole e le convenzioni fondamentali che governano il comportamento
- Etnografia di guerriglia: osservazioni casuali in contesti pubblici per aiutare a stabilire domande di ricerca o per ottenere informazioni rapide su comportamenti specifici
- Mystery shopping : osservazioni nel contesto della vendita al dettaglio con l’obiettivo di acquisire informazioni sull’esperienza di servizio del cliente
- Metodologie multiple : combinazione di metodi di ricerca etnografica con tecniche di ricerca convenzionali con l’obiettivo di triangolare i risultati
Gli osservatori di tendenze come BrainReserve di Faith Popcorn fanno ampio uso della ricerca etnografica per individuare le tendenze emergenti. [186]
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti –Neuroscienze del consumo
Il neuromarketing utilizza sofisticati sensori biometrici come l’EEG per studiare le risposte dei consumatori a stimoli specifici.
La neuroscienza del consumatore (nota anche come neuromarketing ) si riferisce all’uso commerciale delle neuroscienze quando applicate all’indagine dei problemi di marketing e alla ricerca sui consumatori. Alcuni ricercatori hanno sostenuto che il termine neuroscienza del consumatore è preferito rispetto a neuromarketing o altre alternative. [187] [188]
La neuroscienza dei consumatori impiega sofisticati sensori biometrici, come l’elettroencefalografia (EEG), la risonanza magnetica funzionale (fMRI) e il tracciamento oculare , [189] per studiare i modi in cui i consumatori rispondono a stimoli specifici come l’esposizione dei prodotti, i marchi, le informazioni sugli imballaggi, ecc. o altri segnali di marketing. Tali test rivelano stimoli che attivano il centro del piacere del cervello .
La neuroscienza dei consumatori è diventata una componente principale dei metodi di ricerca sui consumatori. La società internazionale di ricerche di mercato Nielsen Research ha recentemente aggiunto il neuromarketing ai suoi servizi acquisendo Innerscope , una società specializzata nella ricerca di neuromarketing, consentendo così a Nielsen di aggiungere la ricerca di neuromarketing alla suite di servizi disponibili ai clienti. [190]
La ricerca sulle neuroscienze dei consumatori ha portato ad alcuni risultati sorprendenti:
Prezzo o valore dell’inquadratura
Ad esempio, uno studio ha riferito di un abbonamento a una rivista in cui ai potenziali abbonati venivano offerte due opzioni: un abbonamento online per $ 59 o un abbonamento combinato online e cartaceo per $ 129 all’anno. La maggior parte delle persone ha scelto l’opzione solo online. Tuttavia, quando è stata introdotta una terza opzione: stampare solo per $ 129 (ovvero l’esca ), l’opzione online e stampa sembrava avere un valore migliore e un numero significativo di persone è passato a quella opzione. In altre parole, il prezzo esca aiuta a inquadrare il valore. [191] Gli esperti di marketing utilizzano diversi metodi per definire il valore : ad esempio, citare opzioni di pagamento mensile anziché un unico prezzo tutto compreso.
Fatica della scelta
La ricerca di Sheena Iyengar ha sperimentato il numero di marmellate gourmet in mostra. Quando i consumatori si sono trovati di fronte a un gran numero di alternative (24 marmellate), il 60% dei consumatori si è fermato a guardare, ma solo pochi (3%) hanno effettivamente effettuato un acquisto. Tuttavia, quando i consumatori si trovavano di fronte a meno marchi (6 marmellate), erano più propensi a effettuare un acquisto, con il 30% che avrebbe poi acquistato qualcosa. Risultati simili sono stati osservati in altre categorie. I risultati suggeriscono che, sebbene i consumatori apprezzino la possibilità di scelta, il processo di selezione è doloroso e può portare ad un affaticamento della scelta. [192] Un problema per gli operatori di marketing e i rivenditori è determinare il “punto ottimale” in cui ai consumatori viene data una scelta sufficiente per soddisfare il loro desiderio di varietà, ma non ne vengono sopraffatti.
Paralisi decisionale
Uno studio ha esaminato la formulazione utilizzata per sollecitare donazioni filantropiche. I consumatori sono stati esposti a varianti nell’esecuzione del testo pubblicitario: “Saresti disposto ad aiutare con una donazione?” e “Saresti disposto ad aiutare facendo una donazione? Ogni centesimo aiuterà”. Quelli a cui era stata data la seconda opzione avevano quasi il doppio delle probabilità di donare. I ricercatori hanno concluso che è più probabile che le persone agiscano quando vengono forniti i parametri. Chiarindo che “anche un centesimo” potrebbe fare la differenza, la seconda riga fornisce indicazioni e rende la richiesta più realizzabile. [193] Per gli esperti di marketing, l’implicazione è che quando si chiede ai consumatori di intraprendere un’azione, specificare un piccolo passo aiuta a superare la paralisi dell’azione. Questa scoperta suggerisce inoltre che anche piccole differenze nel testo pubblicitario possono portare a risultati migliori. Le istruzioni sulle azioni renderanno l’annuncio più mirato.
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti -Guarda anche
- Gestione della pubblicità : spiega come i concetti della psicologia del marketing vengono utilizzati per sviluppare strategie pubblicitarie
- Ricerca pubblicitaria : fornisce informazioni su come i concetti di psicologia del marketing informano i metodi di ricerca utilizzati per comprendere l’efficacia della pubblicità
- Modelli di atteggiamento verso gli annunci
- Consapevolezza del marchio : spiegazione dettagliata della consapevolezza del marchio
- Gestione del marchio : spiega come i concetti di psicologia del marketing vengono utilizzati per gestire la consapevolezza e la crescita del marchio attraverso il ciclo di vita del prodotto
- Processo decisionale d’acquisto : offre una spiegazione alternativa al processo decisionale d’acquisto del consumatore
- Socializzazione del consumo
- Confusione dei consumatori
- Laboratorio Alimentare e di Marca
- Ricerca di marketing : fornisce informazioni su come i concetti di psicologia del marketing informano i metodi di ricerca utilizzati nel marketing, nella psicologia del marketing, nella consapevolezza del marchio e nella gestione della pubblicità
- Acquisto predittivo
- Gestione del ciclo di vita del prodotto (marketing) : spiegazione dettagliata di come cambia la consapevolezza del consumatore nel corso del ciclo di vita del prodotto e di come ciò richieda strategie diverse in ciascuna fase
- Superstizione# Comportamento dei consumatori
- Guardare le vetrine
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti -Riferimenti
- ^ Schivinski , Bruno (5 settembre 2019). “Suscitare il coinvolgimento sui social media relativo al marchio: un quadro di inferenza condizionale” . Giornale di ricerca aziendale . 130 : 594–602. doi : 1016/j.jbusres.2019.08.045 . ISSN 0148-2963 . S2CID 203045048 .
- ^ Tadajewski, M., “A History of Marketing Thought”, capitolo 2 in Contemporary Issues in Marketing e psicologia del marketing, Elizabeth Parsons e Pauline Maclaran (a cura di), Routledge, 2009, pp 24-25
- ^ Sheth, JN ., “Storia del comportamento dei consumatori: una prospettiva di marketing”, in Prospettiva storica nella ricerca sui consumatori: prospettive nazionali e internazionali, Jagdish N. Sheth e Chin Tiong Tan (a cura di), Singapore, Association for Consumer Research, 1985, pp 5-7.
- ^ Fullerton, RA “La nascita del comportamento del consumatore: ricerca sulla motivazione negli anni ’50”, Journal of Historical Research in Marketing, 5, n. 2, 2013, pp.212-222
- ^ Tadajewski, M., “A History of Marketing Thought”, capitolo 2 in Contemporary Issues in Marketing e psicologia del marketing, Elizabeth Parsons e Pauline Maclaran (a cura di), Routledge, 2009, p. 28
- ^ Plassmann, Hilke; Ramsøy, Thomas Zoëga; Milosavljevic, Milica (gennaio 2012). “Marchio del cervello: una revisione critica e una prospettiva” . Giornale di psicologia dei consumatori . 22 (1): 18–36. doi : 1016/j.jcps.2011.11.010 . ISSN 1057-7408 .
- ^ Kardes , F., Cronley, M. e Cline, T., Consumer Behavior, Mason, OH, South-Western Cengage, 2011 p.7
- ^ “Cos’è un consumatore? Definizione e significato” . Dizionario aziendale . Archiviata dall’originale il 28 luglio 2020. Estratto il 9 novembre 2023.
- ^ Kardes , F., Cronley, M. e Cline, T., Consumer Behavior, Mason, OH, South-Western Cengage, 2011 p.9; Sassatelli , R., Cultura del consumo: storia, teoria e politica, Sage, 2007, p. 10
- ^ Kardes , F., Cronley, M. e Cline, T., Consumer Behavior, Mason, OH, South-Western Cengage, 2011 pp 10-11
- ^ Foxal , G., “Fondamenti dell’analisi psicologica del marketing”, Marketing Theory, 1, n. 2, pp 165–199
- ^ Lynn R. Kahle ; Angeline G. Chiudi (2011). Conoscenza del comportamento dei consumatori per un marketing efficace nello sport e negli eventi. New York: Routledge. ISBN 978-0-415-87358-1 .
- ^ Elisabetta A. Minton; Lynn R. Kahle (2014). Sistemi di credenze, religione ed economia comportamentale. New York: Business Expert Press LLC. ISBN 978-1-60649-704-3 .
- ^ * Schöfer , Klaus, Passaparola : influenze sulla scelta delle fonti di raccomandazione, 1998. ISBN 978-3838641454
- ^ Belch, G, Belch, MA , Kerr, G. e Powell, I., Gestione della pubblicità e della promozione: una prospettiva di comunicazione di marketing integrata , McGraw-Hill, Sydney, Australia, 2009, p.126
- ^ Mullainathan, Sendhil; Shafir, Eldar (2013). Scarsità: perché avere troppo poco significa così tanto (Prima ed.). New York: Henry Holt e compagnia. ISBN 9780805092646 .
- ^ Rossiter, JR e Percy, L., “Advertising Communication Models”, in: Advances in Consumer Research, Volume 12, Elizabeth C. Hirschman e Moris B. Holbrook (a cura di), Provo, UT: Association for Consumer Research, 1985, pp 510-524., Online: http://acrwebsite.org/volumes/6443/volumes/v12/NA-12 o http://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id= 6443
- ^ Kenway, J. e Bullen, E., Consuming Children: Istruzione, intrattenimento, pubblicità, Buckingham, Open University Press, 2001
- ^ Sandhusen , RL, Marketing, cfr. S.218
- ^ Sandhusen , Richard L., Marketing (2000). Cfr. 219
- ^ Scott Armstrong (1991). “Previsione del comportamento dei consumatori da parte di esperti e principianti” . Giornale di ricerca sui consumatori . 18 (2): 251–256. doi : 10.1086/209257 .
- ^ Egan, J., Marketing Communications, Londra, Thomson Learning, pp 54-55
- ^ Punj, G. e Srinivasan, N., “Influenza del riconoscimento dei problemi sulla ricerca e su altre variabili del processo decisionale: un quadro per l’analisi”, in Advances in Consumer Research , vol. 19, John F. Sherry, Jr. e Brian Sternthal (a cura di), Provo, UT: Association for Consumer Research, 1992, pp 491–497, Online: http://acrwebsite.org/volumes/7348/volumes/v19/ NA-19
- ^ Reilly, M. e Parkinson, TL, “Correlazioni individuali e di prodotto delle dimensioni evocate del set per i beni confezionati di consumo”, in Elizabeth C. Hirschman e Moris B. Holbrook (a cura di), Advances in Consumer Research, 12, Provo, UT: Associazione per la ricerca sui consumatori, pp 492–497, online: http://acrwebsite.org/volumes/6440/volumes/v12/NA-12
- ^ Clemons, E. (2008). Come le informazioni cambiano il comportamento dei consumatori e come il comportamento dei consumatori determina la strategia aziendale. Giornale dei sistemi informativi gestionali, 25(2), 13-40. Estratto da http://www.jstor.org/stable/40398715
- ^ Kakkar, Pradeep (luglio 1976). “Insieme inerte o insieme dedotto? Un commento”. Giornale di marketing. 40 (3): 59–60. doi : 1177/002224297604000312 . S2CID 167299845 .
- ^ Roberts, John (1989). “Un modello radicato di dimensione e composizione della considerazione” . Progressi nella ricerca sui consumatori. 16 : 749–757.
- ^ Howard, JA e Sheth, JN ., La teoria del comportamento dell’acquirente , New York: Wiley, 1969
- ^ “Lettura di marketing: comportamento del consumatore e processo di acquisto ^ 8167” . Negozio HBR. Estratto 1 marzo 2024.
- ^ Shocker, Allan D.; Ben-Akiva, Moshe; Boccarà , Bruno; Nedungadi, Prakash (1 agosto 1991). “La considerazione influenza il processo decisionale e la scelta dei consumatori: problemi, modelli e suggerimenti”. Lettere di marketing. 2 (3): 181–197. doi : 1007/BF00554125 . S2CID 189942892 .
- ^ Dizionario aziendale, http://www.businessdictionary.com/definition/evoked-set.html Archiviato il 30/11/2016 in Internet Archive
- ^ Kotler P. & Keller, K. (2006). Gestione del marketing. Pearson Prentice Hall, New Jersey
- ^ Belch, G, Belch, MA , Kerr, G. e Powell, I., Gestione della pubblicità e della promozione: una prospettiva di comunicazione di marketing integrata, McGraw-Hill, Sydney, Australia, 2009, p.138
- ^ Winchester, JR e Bogomolova, S., “Credenze positive e negative sul marchio e defezione/assorbimento del marchio”, European Journal of Marketing , vol. 42, n. 5/6, 2008, pp. 553 – 570
- ^ Sirgy , MJ, “Utilizzo dell’autocongruenza e della congruenza ideale per prevedere la motivazione all’acquisto”, Journal of Business Research, 1985, vol. 13, n. 3, pp 195-206, doi : 1016/0148-2963(85)90026-8
- ^ Nazioni, D. (2019). ” Che cosa sono i social media? ” Lifewire .
- ^ Sirgy , HJ, Lee, DJ e Yu, GB, “Revisiting Self-congruity Theory in Consumer Behavior”, in Routledge International Handbook of Consumer Psychology, Cathrine V. Jansson-Boyd e Magdalena J. Zawisza (a cura di), Routledge, 2017 , P. 193
- ^ Kotler, P e Armstrong, G., Principi di marketing, Upper Saddle River, NJ, Pearson, 2014.
- ^ Stileman , P. (2009), In che misura i social media hanno cambiato la relazione tra marchio e consumatore, tesi di laurea in pubblicità, Bucks New University
- ^ Suri, R. e Monroe, KB ., “Effetto dei piani di acquisto dei consumatori sulla valutazione delle offerte di pacchetti”, in Advances in Consumer Research vol. 22, Frank R. Kardes e Mita Sujan (a cura di), Provo, UT, Association for Consumer Research, 1995 pp 588–593, online: http://acrwebsite.org/volumes/7816/volumes/v22/NA-22
- ^ Siddiqui, S. e Agarwal, K., “Il processo decisionale di acquisto del consumatore: un quadro teorico”, International Journal of Science Technology and Management, 6, n. 6, 2017, pp 361-367
- ^ Morwitz, VG ., Steckel, J. e Gupta, A., “Quando le intenzioni di acquisto prevedono le vendite?” International Journal of Forecasting, 23, n. 3, 2007, pp 347-64.
- ^ Armstrong, JS, Morwitz, V. e Kumar, V., “Previsioni di vendita per prodotti e servizi di consumo esistenti: le intenzioni di acquisto contribuiscono all’accuratezza?” International Journal of Forecasting, 16, n. 3, 2000, pp 383–397; Estratto da http://repository.upenn.edu/marketing_papers/143
- ^ Dizionario aziendale, http://www.businessdictionary.com/definition/call-to-action.html Archiviato il 25 ottobre 2016 in Internet Archive
- ^ Eisenberg, B., INVITO ALL’AZIONE: formule segrete per migliorare i risultati online, Nashville, Tennessee, Thomas Nelson, 2006, p. 20
- ^ Berry, LL, Seiders, K., Grewal, D., 2002. Comprendere la comodità del servizio. Giornale di marketing 66 (3), 1-17
- ^ Srinivasan, N., “Informazioni sulla ricerca esterna pre-acquisto”, in Valarie A. Zeithaml (a cura di), Review of Marketing 1990 , Marketing Classics Press (AMA), 2011, pp 153-189
- ^ Vai a: a b Andrea, Broden; Soderberg, Caroline (2011). Acquisto d’impulso, ragioni per cui, elettronica di consumo – Oh mio Dio.
- ^ Foxall, G. (2005) Comprendere la scelta del consumatore, Palgrave Macmillan, 2005
- ^ Engel, James F., Kollat, David T. e Blackwell, Rodger D. (1968) Comportamento dei consumatori , 1a ed. New York: Holt, Rinehart e Winston 1968
- ^ Gupta, Alok; Su, Bo- Chiuan ; Walter, Zhiping (2004). “Taylor e Francis in linea” . Giornale internazionale del commercio elettronico. 8 (3): 131–161. doi : 1080/10864415.2004.11044302 . S2CID 16054242 .
- ^ Gilly, Maria C.; Gelb, Betsy D. (1982). “Processi di consumo post-acquisto e consumatore che si lamenta”. Giornale di ricerca sui consumatori . 9 (3): 323–328. doi : 1086/208927 . JSTOR 2488627 .
- ^ Kuo, Ying-Feng; Wu, Chi-Ming; Deng, Wei-Jaw (2009). “Le relazioni tra qualità del servizio, valore percepito, soddisfazione del cliente e intenzione post-acquisto nei servizi mobili a valore aggiunto”. I computer nel comportamento umano. 25 (4): 887–896. doi : 1016/j.chb.2009.03.003 . S2CID 42136133 .
- ^ Dissonanza post-decisione
- ^ Vai a: a b C MacInnis, DJ; Pieters, R. & Hoyer, WD (2014). 486670 Psicologia del marketing. Cengage Learning Australia Pty Limited.
- ^ Vai a: a b C Belch, GE e Belch, MA (2012). Pubblicità e promozione: una prospettiva di comunicazione di marketing integrata. New York: McGraw-Hill Irwin.
- ^ “Come creare una mappa del percorso del cliente: dalla consapevolezza alla conversione” . Adgo. URL consultato il 19 ottobre 2018 ( archiviata dall ‘ url originale il 16 novembre 2018).
- ^ Woodside, arco; Wilson, Elizabeth (1 gennaio 1985). “Effetti della consapevolezza dei consumatori della pubblicità del marchio sulle preferenze” . Giornale di ricerca pubblicitaria. 25 : 41–48.
- ^ Vai a: a b C Quester, PG; Neal, CM; Pettigrew, S.; et al. (2008). Psicologia del marketing: implicazioni per la strategia di marketing. Sydney: McGraw-Hill Irwin.
- ^ Lokhande, Murlidhar (5 maggio 2006). “Consapevolezza dei consumatori: un caso di studio della città di Jalna” . Giornale indiano di marketing. XXXVI: 23–28.
- ^ “Cos’è il marketing sociale? | NSMC” . www.thensmc.com. Estratto il 9 novembre il 2018.
- ^ “Cos’è il marketing personalizzato? Definizione e significato” . BusinessDictionary.com. Archiviata dall ‘ url originale il 9 novembre 2018. Estratto il 9 novembre 2018.
- ^ “Aumenta la notorietà del marchio della tua azienda” . business.com. Estratto il 19 ottobre il 2018.
- ^ “Consapevolezza del prezzo del prodotto tra i consumatori e test dei prezzi” . www.research-pmr.com. Estratto il 9 novembre il 2018.
- ^ Bhattacharya, CB, Hayagreeva, R e Glynn, MA, ” Capire il legame di identificazione: un’indagine dei suoi correlati tra i membri del museo d’arte “, Journal of Marketing, 59, n. 4 (ottobre 1995), DOI: 10.2307 /1252327, pp. 46-57
- ^ Rossiter, J e Bellman, S., Marketing Communications: Teoria e applicazioni, Pearson Australia, 2005, pp 103-120
- ^ Vai a: a b Rossiter, JR e Percy, L., ” Emotions and Motivations in Advertising “, in Advances in Consumer Research, 18, Rebecca H. Holman e Michael R. Solomon (a cura di), Provo, UT, Association per la ricerca sui consumatori, 1991, pp 100-110
- ^ Pham, MT e Higgins, ET, “Promozione e prevenzione nel processo decisionale dei consumatori: lo stato dell’arte e le proposizioni teoriche”, in S. Ratneshwar e David Glen Mick , (a cura di), Consumo interno: motivazioni dei consumatori, obiettivi e Desideri , Londra: Routledge, 2005, pp 8-43.
- ^ Clarke, K. e Belk. RW, “Gli effetti del coinvolgimento del prodotto e della definizione delle attività sullo sforzo previsto del consumatore”, in Advances in Consumer Research, 06, William L. Wilkie (a cura di), Ann Abor, MI: Association for Consumer Research, pp 313–318, online : http://acrwebsite.org/volumes/9220/volumes/v06/NA-06
- ^ McInnis, DJ e Jaworski, BJ, “Due percorsi verso i modelli di persuasione nella pubblicità: indicazioni su revisione, critica e ricerca”, in Valarie A. Zeithaml (a cura di), Review of Marketing 1990 , Marketing Classics Press (AMA), 2011, pp 3-42
- ^ Percy, Larry; Rossiter, John R. (luglio 1992). “Un modello di strategie pubblicitarie di brand awareness e attitudine al marchio”. Psicologia e marketing. 9 (4): 263–274. doi : 1002/mar.4220090402 .
- ^ Agnello, CW, Capelli, JF . e McDaniel, C., Essentials of Marketing, Mason, Ohio, South-Western Cengage, 2009, pag. 174
- ^ Trehan, M e Trehan, E., Pubblicità e gestione delle vendite, Nuova Delhi, VK Enterprises, p. 165
- ^ Lynn R. Kahle ; Pierre Valette-Firenze (2012). Stili di vita del mercato nell’era dei social media. New York: ME Sharpe, Inc. ISBN 978-0-7656-2561-8 .
- ^ Kardes , F., Cronley, M. e Cline, T., Consumer Behavior, Mason, OH, South-Western Cengage, 2011 p.329
- ^ Weber, EU e Hsee , C., ” Differenze interculturali nella percezione del rischio, ma somiglianze interculturali negli atteggiamenti verso il rischio percepito “, Management Science, 44, n. 9, 1998, pp 1205-1217
- ^ Hoyer, Wayne; Debora, MacInnes; Pieters, Rik (2018). Comportamento dei consumatori (7a ed.). Australia: Cengage. P. 431. ISBN 9781337514804 .
- ^ Hoyer, Wayne; Debora, MacInnes; Pieters, Rik (2018). Comportamento dei consumatori (7a ed.). Australia: Cengage. P. 432. ISBN 9781337514804 .
- ^ Hoyer, Wayne; Debora, MacInnes; Pieters, Rik (2018). Comportamento dei consumatori (7a ed.). Australia: Cengage. P. 439. ISBN 9781337514804 .
- ^ Carroll, CE, Manuale di comunicazione e reputazione aziendale , Chichester, Sussex, Wiley, 2013, p. 44
- ^ Johnson, MD e Lehmann, DR, ” Esperienza del consumatore e set di considerazione per marchi e categorie di prodotti “, in Advances in Consumer Research , vol. 24, 1992, Merrie Brucks e Deborah J. MacInnis (a cura di), Provo, UT: Association for Consumer Research, Pagine: 295-300.
- ^ Reisch, Lucia A.; Zhao, Min (novembre 2017). Economia comportamentale , psicologia del marketing e politica dei consumatori: stato dell’arte. Stampa dell’Università di Cambridge. P. 199.
- ^ Torelli, CJ e Rodas, M., “Globalizzazione, branding e comportamento del consumatore multiculturale”, in Routledge International Handbook of Consumer Psychology, Cathrine V. Jansson-Boyd e Magdalena J. Zawisza (a cura di), Routledge, 2017, p. 41-58
- ^ Neal, D., ” La Ferrari con il tatuaggio del drago “, Wall Street Journal , 10 maggio 2012
- ^ Schouten, J e Mcalexander, JH, “Sottoculture del consumo: un’etnografia dei nuovi motociclisti”, Journal of Consumer Research, vol, 22, n. 1, giugno 1995
- ^ Bhattacharya, CB, Rao, H. e Glynn, MA, “Understanding the Bond of Identification: An Investigation of its Correlates between Art Museum Members”, Journal of Marketing, 59, n. 4, 46-57
- ^ The Age , [Giornale, Melbourne, Australia], “Bargain Basement Blues”, 2 settembre 2002 http://www.theage.com.au/articles/2002/09/20/1032054962889.html . Si noti che mentre ogni quintile rappresenta il 20% della popolazione all’inizio di un periodo di misurazione, nel tempo può verificarsi uno spostamento della fascia, spiegando perché gli AB rappresentano il 24% nel 2002
- ^ Ramya, N (2016). “Fattori che influenzano il comportamento d’acquisto dei consumatori” . Sportello di ricerca.
- ^ Iyengar, R., Valente, T. e Van den Bulte, C., ” Opinion Leadership and Social Contagion in New Product Diffusion “, in Advances in Consumer Research , Vol 36, eds. Ann L. McGill e Sharon Shavitt , Duluth, MN: Associazione per la ricerca sui consumatori, pp 36-37
- ^ Paul McIntyre, “I blogger indipendenti superano le celebrità come principali influencer dei social media”, Australian Financial Review , 22 giugno 2015, online: http://www.afr.com/business/independent-bloggers-overtake-celebrities-as-key- social-media-influencer-20150528-ghbovu ; (Si noti che una versione ridotta di questo articolo è apparsa anche su Marketing Magazine, 16 luglio 2015); Blogger Outreach ha detronizzato Celebrity Endorsement, Marketing Magazine, 16 luglio 2015, online: https://www.marketingmag.com.au/hubs-c/blogger-outreach-dethroned-celebrity-endorsement
- ^ Flynn, LR, Goldsmith, RE e Eastman, JK, “Opinion leader e cercatori di opinione: due nuove scale di misurazione”, Journal of Academy of Marketing Science , vol. 24, n. 2, pp 137-147.
- ^ “Ricerca sulla psicologia del marketing sul COVID 19” . cxm.co.uk. Estratto il 10 febbraio il 2020.
- ^ Vai a: a b C D e f Samuel Lins, Sibele Aquino, Ana Raquel Costa (14 marzo 2021) ‘Dal panico alla vendetta: comportamenti di acquisto compensativi durante la pandemia’, International Journal of Psychiatry.
- ^ Cambridge Dictionary, Cambridge University Press (2020), accesso il 23 aprile 2021 da: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/panic-buying .
- ^ Vai a: a b Steven Taylor (marzo 2021) “Comprendere e gestire gli acquisti dettati dal panico legati alla pandemia” Journal of Anxiety Disorders 78.
- ^ ABC News Video Services (26 giugno 2020) “VIDEO: il primo ministro Scott Morrison dice che non c’è bisogno di acquisti dettati dal panico” ABC News, accesso il 23 aprile 2021 da: https://www.abc.net.au/news/2020 -06-26/il primo ministro-scott-morrison-dice-che-non-è-necessario-acquistare-panico/12398700 ; Zona Black (3 giugno 2020) “Acquisto dovuto al panico: gli australiani sono in cima alle classifiche globali per l’accumulo di carta igienica” The New Daily, accesso il 23 aprile 2021 da: https://thenewdaily.com.au/finance/consumer/2020/06/03/ panico-acquista-australia-perché/ ; BBC News Services (26 giugno 2020) “L’Australia limita le vendite di rotoli di carta igienica dopo gli acquisti dettati dal panico” BBC News, accesso il 23 aprile 2021 da: https://www.bbc.com/news/world-australia-53196525 .
- ^ Tianwei Zhang (13 aprile 2020) “Hermes ha incassato 2,7 milioni di dollari in un negozio cinese sabato: fonti” Women’s Wear Daily, accesso il 23 aprile 2021 da: https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/ hermes-hauled-in-2-7-milioni-in-one-china-store-on-sabato-sources-1203559738/ . Vedi anche: Shalini Nagarajan (16 aprile 2020) “Il marchio di lusso francese Hermes guadagna 2,7 milioni di dollari in un giorno in un flagship store in Cina mentre gli acquirenti facoltosi si sfogano dopo il blocco del coronavirus” Business Insider Australia, accesso il 23 aprile 2021 da: https ://www.businessinsider.com.au/wealthy-chinese-shoppers-slurge-at-hermes-store-in-china-2020-4?r=US&IR=T ; Robert Williams, Jinshan Hong (12 marzo 2020) “La spesa per vendetta stimola la ripresa del lusso cinese dal virus” Bloomberg, accesso il 23 aprile 2021 da: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-12/luxury -gli acquirenti-in-cina-escono-dalla-quarantena-per-comprare-di-nuovo .
- ^ Caroline Tynan, Sally McKechnie, Celine Chhuon (1 agosto 2009) “Co-creazione di valore per i marchi di lusso” Journal of Business and Research 63 (2010) 1156 – 1163.
- ^ Sonny Nwankwo, Nicolas Hamelin, Meryem Khaled (5 maggio 2014) Journal of Retailing and Consumer Services 21 (2004) 735 – 744.
- ^ Jun-Hwa-Cheah, David Waller, Park Thaichon , Hiram Ting, Xin-Jean Lim ‘L’immagine del prezzo e l’ effetto della sugrofobia sull’intenzione di acquisto al dettaglio di lusso’ (5 giugno 2020) Journal of Retailing and Consumer Services 57 (2020) 102188.
- ^ Selin Atalay, Margaret Meloy (2 maggio 2011) “Terapia al dettaglio: uno sforzo strategico per migliorare l’umore” Psicologia e marketing 28 (6), 638 – 660.
- ^ Vai a: a b Kannan, PK; Kulkarni, Gauri (1 gennaio 2021). “L’impatto del Covid-19 sui percorsi dei clienti: implicazioni per il marketing interattivo”. Giornale di ricerca nel marketing interattivo. 16 (1): 22–36. doi : 1108/JRIM-03-2021-0078 . ISSN 2040-7122 . S2CID 239635412 .
- ^ Timozio , Elkana; Ottavio, Gilbert Sterling (2021). “Cambiamento globale del comportamento dei consumatori nei confronti della distribuzione al dettaglio a causa della pandemia di COVID-19: una revisione sistematica” . Giornale di scienza della distribuzione. 19 (11): 69–80. doi : 15722/jds.19.11.202111.69 . ISSN 1738-3110 .
- ^ Durvasula, S., Lysonski , S. e Andrews, JC (1993), “Generalizzabilità interculturale di una scala per profilare gli stili decisionali dei consumatori”, The Journal of Consumer Affairs , vol. 27 n. 1, pp. 55-65
- ^ Sproles, GB (1985), “Dal perfezionismo al fadismo : misurare gli stili decisionali dei consumatori”, in Schnittgrund , KP . (a cura di), American Council on Consumer Interests ( ACCI ), Atti di conferenza , Columbia, MO, pp. 79-85.
- ^ Sproles, Gran Bretagna (1983). Concettualizzazione e misurazione del processo decisionale ottimale del consumatore. Giornale degli affari dei consumatori , vol. 17 n. 2, pp 421-438.
- ^ Sproles, GB, e Kendall, EL, “Una metodologia per profilare gli stili decisionali dei consumatori”, Journal of Consumer Affairs , Vol., 20 No. 2, 1986, pp 267 -279
- ^ Jain, R. e Sharma, A., “Una revisione del Consumer Style Inventory (CSI) di Sproles & Kendall per l’analisi degli stili decisionali dei consumatori”, Indian Journal of Marketing , vol. 43, n. 3, 2013
- ^ Bauer, HH, Sauer, NE e Becker, C., “Indagare sulla relazione tra coinvolgimento del prodotto e stili decisionali dei consumatori”, Journal of Marketing Psychology . vol. 5, 2006 342–354.
- ^ Mishra, A., “Innovatività dei consumatori e stili decisionali dei consumatori: un’analisi confermativa e di segmentazione”, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research , vol. 25, n. 1, 2015, doi : 1080/09593969.2014.911199
- ^ Dowling, Grahame R. e Richard Staelin (1994), “Un modello di rischio percepito e attività di gestione del rischio prevista”, Journal of Consumer Research , 21 (giugno), pp 119-34.
- ^ Mitchell, V.‐ e Boustani, P., “Un’indagine preliminare sulla percezione e riduzione del rischio pre e post acquisto”, European Journal of Marketing , vol. 28 n. 1, 1994, pp.56 – 71
- ^ Ross, I., “Rischio percepito e comportamento del consumatore: una revisione critica”, in Advances in Consumer Research, Volume 2, Mary Jane Schlinger, (a cura di) MI, Association for Consumer Research, 1975, pp 1-20 <Online: http://acrwebsite.org/volumes/5741/volumes/v02/NA-02 >
- ^ Büttner, OB, Schulz, S. e Silberer, S, “Rischio percepito e deliberazione nella scelta del rivenditore: comportamento dei consumatori nei confronti delle farmacie online”, Advances in Consumer Research , vol. 33, 2006
- ^ Mitchell, Volkswagen. e Greatorex, M. “Percezione del rischio e riduzione nell’acquisto di servizi al consumo”, The Service Industries Journal , vol. 13, n. 4, 1993, pp. 179-200
- ^ Zeithaml, VA Come i processi di valutazione dei consumatori differiscono tra beni e servizi, (1981), in: Atti della conferenza AMA , James H. Donnelly e William R. George (a cura di), Chicago IL: American Marketing Association , p. 186-190
- ^ Jourdan, P., “Prodotti di ricerca o esperienza: un’indagine empirica su servizi, beni durevoli e non durevoli”, in: Asia Pacific Advances in Consumer Research , volume 4, Paula M. Tidwell e Thomas E. Muller (a cura di) , Provo, UT, Association for Consumer Research, (2001), pp 167-174 Online: http ://acrwebsite.org/volumes/11342/volumes/ap04/AP-04
- ^ Dowling, GR . e Staelin , R., “Un modello di rischio percepito e attività di gestione del rischio prevista”, Journal of Consumer Research , vol. 21, n. 1, 1994, pp. 119-134
- ^ Mitchell, Volkswagen. e Greatorex, M., “Percezione del rischio e riduzione nell’acquisto di servizi al consumo”, Service Industries Journal , 1993, pp 179-200
- ^ Rogers, EM , “Adozione e diffusione di nuovi prodotti”, Journal of Consumer Research , vol. 2, n. 4, 1976, pp. 290-301
- ^ Mahajan, V. e Peterson, EA , Modelli per la diffusione dell’innovazione , volume 48, 1985.
- ^ Dizionario aziendale, http://www.businessdictionary.com/definition/diffusion-of-innovation.html Archiviato il 30 ottobre 2016 in Internet Archive
- ^ Lowrey, TM, “L’uso della teoria della diffusione nel marketing: un approccio qualitativo al comportamento innovativo dei consumatori”, in Advances in Consumer Research , vol. 18, ed. Rebecca H. Holman e Michael R. Solomon, Provo, UT: Associazione per la ricerca sui consumatori, 1991, pp 644-650. Online: http://acrwebsite.org/volumes/7230/volumes/v18/NA-18 .
- ^ Rogers, EM, Diffusione delle innovazioni, New York, The Free Press, p. 5.
- ^ Basato su Rogers, EM, The Diffusion of Innovations , 5a ed., NY, Free Press, 2003
- ^ Rogers, EM, Diffusione delle innovazioni, 5a ed., New York, The Free Press, 2003 pp 11-12.
- ^ Desilver, D.”Il tasso sempre più accelerato di adozione della tecnologia, Pew Research, 14 marzo 2014, online: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/03/14/chart-of-the-week -il-tasso-di-adozione-della-tecnologia-in-sempre-accelerazione/
- ^ La figura si basa sui dati forniti da Google, https://www.docs.google.com/spreadsheets/d/1uvn7o1X19Equ5EDvjXEMxpziAEAsXTJK9Xbf8NwYiAo/htmlview
- ^ Mercato realista, http://marketrealist.com/2015/12/adoption-rates-dizzying-heights/
- ^ McGrath, R., ” Il ritmo dell’adozione della tecnologia sta accelerando “, Harvard Business Review , 25 novembre 2013
- ^ Forbes Technology Council, “Come i consumatori stanno influenzando l’adozione della nuova tecnologia, blog di Forbes, 21 giugno 2016, online: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2016/06/21/how-consumers-are -influenzare-l’adozione-di-nuove-tecnologie/#5a48cc917ba6
- ^ Rossiter, J e Bellman, S., Comunicazioni di marketing: teoria e applicazioni , Pearson Australia, 2005, pp 80-87.
- ^ Nielsen International, Global Survey of Loyalty Sentiment , 2013: [Risultati principali del sondaggio], online: http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2013/the-price-is-right-incentives- che-stimola-il-comportamento-di-cambio.html
- ^ “Spiegare il comportamento di cambio canale dei consumatori utilizzando la teoria del comportamento pianificato” (PDF) .
- ^ Roy Morgan Research, “How Vital are Vitamins:, risultato della ricerca n. 5503, comunicato stampa, 14 marzo 2014 online: http://roymorgan.com.au/findings/5503-how-vital-are-vitamins-201403252241 Archiviato il 6 ottobre 2016 in Internet Archive
- ^ Reardon, J., McCorkle, DE “Un modello di consumatore per il comportamento di cambio di canale”, International Journal of Retail and Distribution Management , vol. 30, n. 4, pp.179-185
- ^ Dholakia1, RR, Zhao, M. e Dholakia, N., “Vendita al dettaglio multicanale: un caso di studio delle prime esperienze.”, Journal of Interactive Marketing , vol. 19, marzo, pp 63–74, 2009, DOI: 10.1002/dir.20035
- ^ Stern, Hawkins (1 gennaio 1962). “L’importanza dell’acquisto d’impulso oggi”. Giornale di marketing. 26 (2): 59–62. doi : 2307/1248439 . JSTOR 1248439 .
- ^ Weber, Elke U.; Barone, Jonathan (1 gennaio 2001). Conflitti e compromessi nel processo decisionale . Stampa dell’Università di Cambridge. ISBN 9780521772389 .
- ^ Ricerca Nielsen, ” Collegare ciò che chiedono i consumatori con ciò che acquistano gli acquirenti “, 2013
- ^ Citato in Bagozzi, R., Gurhan -Canli, Z., Priester, J., The Social Psychology Of Marketing psicologia , Open University Press, Buckingham, PA, 2002, p. 38
- ^ Eagly , AH e Chaiken, S. La psicologia degli atteggiamenti, Harcourt Brace Jovanovich, Fort Worth, Texas, 1993.
- ^ McPhail, J. e Mattson, J “L’effetto degli stati d’umore sull’incontro di servizio diadico”, Asia Pacific Advances in Consumer Research, 2, eds. Russel Belk e Ronald Groves (a cura di), Provo, UT: Association for Consumer Research, 1996 pp 41-46. Online: http://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=11530
- ^ Johnson, AR e Stewart, DW ., ” Una rivalutazione del ruolo delle emozioni nella psicologia del marketing: approcci tradizionali e contemporanei “, in Malhotra, NK, Review of Marketing Research, Vol 1, Armonk, Londra, 2005, pp 3- 33
- ^ Bagozzi, R., Gurhan -Canli, Z., Priester, J., The Social Psychology Of Marketing psicologia , Open University Press, Buckingham, PA, 2002, pp 60-63
- ^ Cohen, JB; Pham, MT; Andrade, EB (1 giugno 1999). “La natura e il ruolo dell’affetto nel comportamento dei consumatori” . APA PsycNet : 33–34. Estratto il 9 settembre il 2021.
- ^ Gountas , S. e Gountas , J. “L’influenza delle emozioni del cliente sulla valutazione del prodotto del servizio”, Perdue, RR e Immermans , HJP e Uysal, M. Psicologia del consumatore del turismo, dell’ospitalità e del tempo libero, (Vol. 3) , 2004
- ^ Szymanski, DM e Henard, DH , “Soddisfazione del cliente; una meta-analisi delle prove empiriche”, Journal of the Academy of Marketing Science , vol. 29, n. 1 2001 pp 16-35, online: http://davidhenard.com/Landing_Page/About_files/Szymanski%20%26%20Henard%202001.pdf Archiviato il 12 ottobre 2016 in Internet Archive
- ^ https://commons.erau.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=db-management [ URL nudo PDF ]
- ^ Wu, Wann-Yih; Anridho , Nadia (1 gennaio 2016). “Gli antecedenti della fedeltà alla marca: uno studio di meta-analisi” . Giornale internazionale di servizi e standard. 11 (3): 242. doi : 1504/IJSS.2016.10000889 – tramite ResearchGate.
- ^ Eisend , Martin; Stokburger -Sauer, Nicola E. (27 febbraio 2013). “Personalità del marchio: una revisione meta-analitica degli antecedenti e delle conseguenze”. Lettere di marketing. 24 (3): 205–216. doi : 1007/s11002-013-9232-7 . S2CID 144201875 .
- ^ Cacioppo, JT, Petty, RE .; Chuan Feng, K. e Rodriguez, R. “Percorsi centrali e periferici verso la persuasione: una prospettiva di differenza individuale”, Journal of Personality and Social Psychology , Vol 51, No. 5, 1986, pp 1032-1043. https://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.51.5.1032
- ^ Murray, PN, “Come le emozioni influenzano ciò che acquistiamo: il nucleo emotivo del processo decisionale del consumatore”, Psychology Today , 26 febbraio 2013 Online: https://www.psychologytoday.com/blog/inside-the-consumer- mind/201302/how-emotions-influence-what-we-buy
- ^ Heath, R.; Brandt, D. & Nairn, A (2006). “Relazioni con il marchio: rafforzate dall’emozione, indebolite dall’attenzione”. Giornale di ricerca pubblicitaria. 46 (4): 410–419. doi : 2501/s002184990606048x . S2CID 54530013 .
- ^ Riempire, C (2013). Comunicazioni di marketing: marchi, esperienze e partecipazione. Regno Unito: Pearson Education Limited.
- ^ Dick, AS e Basu, K. “Fidelizzazione del cliente: verso un quadro concettuale integrato”, Journal of the Academy of Marketing Science , vol. 22, n. 2, 1994, pp 99-113
- ^ Gallo, A., “Il valore di mantenere i clienti giusti, Harvard Business Review Online, https://hbr.org/2014/10/the-value-of-keeping-the-right-customers
- ^ Wirtz, J., Mattila, AS e Lwin, MO, “Quanto sono efficaci i programmi di premi fedeltà nel guidare la quota del portafoglio?” Journal of Service Research , volume 9, n. 4, 2007, pp 327-334 DOI: 10.1177/1094670506295853
- ^ Rust, RT, Zeithaml, VA e Lemon, KN ., Driving Customer Equity: How Customer Lifetime Value is Reshaping Corporate Strategy , The Free Press, NY, 2000, p. 111
- ^ Ryu, G. e Feick, L., “Un centesimo per i tuoi pensieri: programmi di ricompensa per referral e probabilità di referral”, Journal of Marketing , vol. 71, gennaio 2007, pp 84–94
- ^ Bove, LL, Pervan, SJ ., Beatty, SE e Shiu, E, “Ruolo del lavoratore dei servizi nell’incoraggiare i comportamenti di cittadinanza organizzativa del cliente”, Journal of Business Research , vol. 62, 2009, pp 698–705, doi:10.1016/j.jbusres .2008.07.003
- ^ Bove, L., Robertson, N. e Pervan, S., “Customer Citizenship Behaviors : Towards the Development of a Typology”, Atti della conferenza dell’Australia New Zealand Marketing Academy, Adelaide, 1–3 dicembre 2003 <online: http:// /smib.vuw.ac.nz:8081/WWW/ANZMAC2003/papers/BB13_bovel.pdf Archiviato il 2 luglio 2007 in Internet Archive. > p. 332
- ^ Fishbein, M. e Ajzen, I., Credenza, atteggiamento, intenzione e comportamento: un’introduzione alla teoria e alla ricerca, 1975, Addison-Wesley, Reading, MA
- ^ Howard, JA e Sheth, JN . , 1969, La teoria del comportamento dell’acquirente, vol. 14.New York, Wiley
- ^ Shun, C. e Yunjie , X., “Effetti dei risultati, dei processi e del piacere dello shopping sulla psicologia del marketing online”, Ricerca e applicazioni sul commercio elettronico, vol. 5, 2006, pp 272–28, <Online: https://www.researchgate.net/profile/Shun_Cai/publication/220066620_Effects_of_outcome_process_and_shopping_enjoyment_on_online_consumer_behaviour/links/58cbb43692851c31f656c821/Effects -del -processo-di-risultato-e-del-godimento-dello-shopping-su- comportamento-del-consumatore-online.pdf >
- ^ Jílková, Petra; Králová, Petra (febbraio 2021). “Psicologia del marketing digitale e tendenze dell’e-commerce durante la crisi COVID-19” . Progressi internazionali nella ricerca economica. 27 (1): 83–85. doi : 1007/s11294-021-09817-4 . ISSN 1083-0898 . PMC 7988251 .
- ^ Shun, C. e Yunjie , X., “Effetti dei risultati, dei processi e del piacere dello shopping sulla psicologia del marketing online”, Ricerca e applicazioni sul commercio elettronico, vol. 5, 2006, pp 275–76, <Online: https://www.researchgate.net/profile/Shun_Cai/publication/220066620_Effects_of_outcome_process_and_shopping_enjoyment_on_online_consumer_behaviour/links/58cbb43692851c31f656c821/Effects -del -processo-di-risultato-e-del-godimento-dello-shopping-su- comportamento-del-consumatore-online.pdf >
- ^ Citato in Dann, S. e Dann, S., E-Marketing: Theory and Application London , Palgrave-Macmillan, 2011, pp 144-45
- ^ Moe, W. (2003). “Acquisto, ricerca o navigazione: distinzione tra acquirenti online che utilizzano il flusso di clic di navigazione in negozio” . Giornale di psicologia dei consumatori . 13 (1): 29–39. doi : 1207/s15327663jcp13-1&2_03 (inattivo il 6 maggio 2024).
- ^ Moe, W.; Fader, P. (2004). “Catturare l’evoluzione del comportamento delle visite nei dati clickstream”. Giornale di marketing interattivo. 18 (1): 5–19. CiteSeerX 1.1.37.5128 . doi : 10.1002/dir.10074 . S2CID 2776467 .
- ^ Chaffey, D. (2006). Marketing su Internet (3a ed.. ed.). Harlow: Financial Times Prentice Hall. P. 109 . ISBN 978-1405871815 .
- ^ Vai a: a b Moir, Diane (19 ottobre 2011). “Tutela del marchio solo del colore: come e quando un colore sviluppa un significato secondario e perché i marchi di colore non possono mai essere intrinsecamente distintivi” . Recensione di diritto di Touro. 27 (2). ISSN 8756-7326 .
- ^ Vai a: a b Palmer, Stephen E.; Castello, Karen B.; Sammartino, Jonathan (2 gennaio 2013). “Estetica visiva e preferenze umane”. Rassegna annuale di psicologia. 64 (1): 77–107. doi : 1146/annurev-psych-120710-100504 . ISSN 0066-4308 . PMID 23020642 . S2CID 6258525 .
- ^ Labrecque, Lauren I.; Patrizio, Vanessa M.; Milne, George R. (febbraio 2013). “La tavolozza prismatica degli esperti di marketing: una revisione della ricerca sul colore e le direzioni future: la tavolozza prismatica degli esperti di marketing” . Psicologia e marketing. 30 (2): 187–202. doi : 1002/mar.20597 .
- ^ “Assegnazione dei colori – Associazioni” . www.joehallock.com. Estratto il 28 marzo il 2020.
- ^ Labrecque, Lauren I.; Milne, George R. (1 settembre 2012). “Rosso emozionante e blu competente: l’importanza del colore nel marketing”. Giornale dell’Accademia di scienze del marketing. 40 (5): 711–727. doi : 1007/s11747-010-0245-y . ISSN 1552-7824 . S2CID 255381568 .
- ^ Vai a: a b Chae, Boyoun ; Hoegg , JoAndrea (1 agosto 2013). “Il futuro sembra” giusto “: effetti della posizione orizzontale delle immagini pubblicitarie sull’atteggiamento verso il prodotto” . Giornale di ricerca sui consumatori . 40 (2): 223–238. doi : 1086/669476 . ISSN 0093-5301 .
- ^ Valenzuela, Ana; Raghubir, Priya (2009). “Credenze basate sulla posizione: l’effetto della scena centrale”. Giornale di psicologia dei consumatori . 19 (2): 185–196. doi : 1016/j.jcps.2009.02.011 . ISSN 1532-7663 .
- ^ Vai a: a b Reber, Rolf; Schwarz, Norbert (1 settembre 1999). “Effetti della fluidità percettiva sui giudizi di verità” . Coscienza e cognizione. 8 (3): 338–342. doi : 1006/ccog.1999.0386 . ISSN 1053-8100 . PMID 10487787 . S2CID 2626302 .
- ^ Vai a: a b Lewis, Michael; Whitler, Kimberly A.; Hoegg , JoAndrea (1 settembre 2013). “Fase della relazione con il cliente e utilizzo della pubblicità con immagine dominante rispetto a quella con testo dominante: uno studio sul campo” . Giornale della vendita al dettaglio. 89 (3): 263–280. doi : 1016/j.jretai.2013.01.003 . ISSN 0022-4359 .
- ^ Oppenheimer, Daniel M.; Frank, Michael C. (1 marzo 2008). “Una rosa in qualsiasi altro carattere non avrebbe un odore così dolce: effetti della fluidità percettiva sulla categorizzazione” . Cognizione. 106 (3): 1178–1194. doi : 1016/j.cognition.2007.05.010 . ISSN 0010-0277 . PMID 17618616 . S2CID 9786621 .
- ^ Brumberger , E. (2003). “La retorica della tipografia: la persona del carattere tipografico e del testo” . Comunicazione tecnica. 50 : 206–223. ISSN 0049-3155 .
- ^ Bayer, Mareike; Sommer, Werner; Schacht, Annekathrin (9 maggio 2012). “La dimensione del carattere conta: emozione e attenzione nelle risposte corticali alle parole scritte” . PLOS UNO. 7 (5): e36042. Codice Bib : ..736042B . doi : 10.1371/journal.pone.0036042 . ISSN 1932-6203 . PMC 3348912 . PMID 22590518 .
- ^ Vai a: a b C Leviston, Zoe; Uren, Hannah (marzo 2020). “Sopravvalutare il proprio comportamento ‘verde’: un pregiudizio migliore della media può funzionare per ridurre la minaccia personale percepita derivante dal cambiamento climatico” . Giornale di questioni sociali. 76 : 70–85. doi : 1111/josi.12365 . S2CID 213919455 .
- ^ Mariampolski , H., Etnografia per gli esperti di marketing: una guida all’immersione del consumatore, Sage, 2006, pp 43-38
- ^ Brain Reserve, sito web della Trend Bank, http://www.faithpopcorn.com/trendbank Archiviato il 24 ottobre 2016 in Internet Archive
- ^ Ramsøym TZ, Introduzione al neuromarketing e alle neuroscienze del consumatore , Danimarca, Neurons Inc, 2015, p.3
- ^ Hubert, M. & Kenning, P. (2008): Una panoramica attuale delle neuroscienze del consumatore, in: Journal of Marketing Psychology, n. 7(4-5), S. 272-292.
- ^ Choi, DY ., Hahn, MH e Lee, KC, “A Comparison of Buying Decisions by Product Involvement: An Eye Tracking Study”, in Intelligent Information and Database Systems, alla 4a conferenza asiatica ACIIDS (parte 3), Jeng- Shyang Pan, Shyi -Ming Chen, Ngoc Thanh Nguyen (a cura di), marzo 2012, pp 37-46
- ^ Dooley, R., “Nielsen Doubles Down on Neuro”, rivista Forbes , 3 giugno 2015 Online: https://www.forbes.com/sites/rogerdooley/2015/06/03/nielsen-doubles-down-on- neuro/
- ^ Ariely, Dan, Prevedibilmente irrazionale, NY, Harper Collins, 2009; Shiv, B., Carmon, Z. e Ariely, D., “Effetti placebo delle azioni di marketing: i consumatori possono ottenere ciò per cui pagano”, Journal of Marketing Research, 42, n. 4, 2005, pp. 383-393https: //doi.org/10.1509/jmkr.2005.42.4.383
- ^ Dooley, R., “Più scelte, meno vendite”, Blog di marketing sulle neuroscienze , online: http://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/more-choices-fewer-sales.htm
- ^ Ciotti, G. “Paralisi analitica e psicologia del marketing” Online: https://www.helpscout.net/consumer-behavior/
Ulteriori letture[ modifica ]
- Blackwell, Miniard e Engel (2006). Psicologia del marketing ( 10a ed.). Thomson Apprendimento.
- Deaton, Angus ; Muellbauer , John, Economia e comportamento dei consumatori , Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1980. ISBN 0-521-22850-6
- Deutsch, D. e Deutsch, JA (1975). Memoria a breve termine . New York: stampa accademica.
- Ferber, R. (1976). Una sintesi di aspetti selezionati della psicologia del marketing . Chicago, Illinois.
- Guilford, JP (1967). La natura dell’intelligenza umana . New York: McGraw-Hill.
- Howard, J., Sheth, JN . (1968), Teoria del comportamento dell’acquirente , J. Wiley & Sons, New York, NY.
- Kardes , Frank R.; Cronley, Maria L.; Cline, Thomas W., Comportamento dei consumatori , Mason, OH: South-Western, Cengage Learning , 2011. ISBN 978-0-538-74540-6
- Kaplan, MF e Schwartz, S. (1975). Giudizio umano e processi decisionali . New York: stampa accademica.
- Klapper, JT (1949). Gli effetti dei mass media . New York: Columbia University, Ufficio di ricerca sociale applicata.
- Laermer , Richard; Simmons, Mark, Punk Marketing , New York: HarperCollins, 2007. ISBN 978-0-06-115110-1 (Recensione del libro di Marilyn Scrizzi , in Journal of Consumer Marketing 24(7), 2007)
- Loudon, DL . (1988), Comportamento del consumatore: concetti e applicazioni , McGraw Hill, Londra.
- McGuire, WJ (1976). “Fattori psicologici che influenzano la scelta del consumatore”, in R. Ferber, ed., Una sintesi di aspetti selezionati del comportamento del consumatore . Washington, DC : Fondazione nazionale della scienza.
- McNair, B. (1958), Sviluppo della vendita al dettaglio , Harper & Row, New York, NY.
- Packard, Vance , (1957) I persuasori nascosti , New York, D. McKay Co.
- Pollio, HR (1974). La psicologia dell’attività simbolica . Lettura, MA: Addison-Wesley
- Schiffman, LG (1993), Comportamento dei consumatori , Prentice Hall International, Londra; Schiffman, LG e Kanuk, L. (2010), 10a edizione; [1] Schiffman, LG e Wisenblit , JL, (2015), 11a edizione. [2]
- Schwartz, Barry (2004), Il paradosso della scelta: perché più è meno , Ecco, New York.
- Shell, Ellen Ruppel , Cheap: The High Cost of Discount Culture , New York: Penguin Press, 2009. ISBN 978-1-59420-215-5
- Solomon, MR (1994), Comportamento dei consumatori , Allyn & Bacon, Londra.
- Stefflre , V. (1968). Studi sulla struttura del mercato: nuovi prodotti per vecchi mercati e nuovi mercati (esteri) per vecchi prodotti . New York: Wiley.
- Tversky, A. e Kahneman, D. (1982). Giudizio in condizioni di incertezza: euristiche e pregiudizi Cambridge University Press
Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Semantica articolo
- master in psicologia del marketing e comunicazione
- master psicologia marketing
- master comunicazione aziendale
- psicologia del marketing
- comunicazione aziendale
- master marketing psicologico
- master marketing e comunicazione
- psicologia aziendale
- master in psicologia
- marketing psicologico
- master in comunicazione
- comunicazione aziendale master
- master psicologia aziendale
- marketing e comunicazione
- psicologia del marketing e comunicazione
- master psicologia e marketing
- psicologia del lavoro
- master psicologia del lavoro
- marketing aziendale
- master in marketing
- master psicologia della comunicazione
- master marketing e psicologia
- psicologia del marketing aziendale
- master in psicologia aziendale
- psicologia applicata al marketing
- comunicazione psicologica
- master in comunicazione psicologica
- marketing e comunicazione aziendale
- master in psicologia della comunicazione
- master comunicazione e marketing
- psicologia per il marketing
- master in marketing aziendale
- psicologia e marketing
- master psicologia e comunicazione
- master in psicologia del marketing
- comunicazione e marketing
- marketing psicologia
- master in comunicazione aziendale
- master in marketing psicologico
- psicologia della comunicazione
- master marketing aziendale
- master in psicologia e marketing
- marketing e comunicazione master
- master in psicologia applicata
- master in marketing e comunicazione
- psicologia del marketing master
- master psicologia del lavoro e marketing
- marketing psicologia e comunicazione
- comunicazione aziendale e marketing
- master in psicologia organizzativa
- psicologia del consumatore
- master in psicologia del consumatore
- master marketing e psicologia aziendale
- comunicazione e psicologia
- master comunicazione psicologia
- marketing e psicologia del lavoro
- psicologia del lavoro e marketing
- master in comunicazione e psicologia
- marketing e psicologia della comunicazione
- master psicologia aziendale e marketing
- psicologia del marketing digitale
- master in marketing e psicologia digitale
- master marketing digitale e psicologia
- psicologia della pubblicità
- master in psicologia della pubblicità
- master in marketing digitale
- marketing digitale
- master psicologia digitale
- comunicazione e marketing digitale
- psicologia e comunicazione digitale
- master in comunicazione digitale
- master in marketing e pubblicità
- marketing e pubblicità
- master pubblicità e psicologia
- psicologia della pubblicità digitale
- master in marketing e pubblicità digitale
- comunicazione aziendale digitale
- master in psicologia e comunicazione aziendale
- master comunicazione aziendale e marketing
- psicologia e pubblicità
- master in psicologia e pubblicità
- marketing e psicologia pubblicitaria
- master marketing e psicologia pubblicitaria
- psicologia della comunicazione aziendale
- master in psicologia della comunicazione aziendale
- marketing e comunicazione digitale
- master in marketing e comunicazione digitale
- psicologia aziendale e comunicazione
- master in psicologia aziendale e comunicazione
- marketing aziendale e psicologia
- master marketing aziendale e psicologia
- master in psicologia del marketing aziendale
- comunicazione aziendale e psicologia
- master in comunicazione aziendale e psicologia
- master in marketing e comunicazione aziendale
- psicologia del marketing e della comunicazione aziendale
- master in marketing e comunicazione integrata
- psicologia del marketing e pubblicità
- master psicologia del marketing e pubblicità
- comunicazione integrata aziendale
- master in comunicazione integrata aziendale