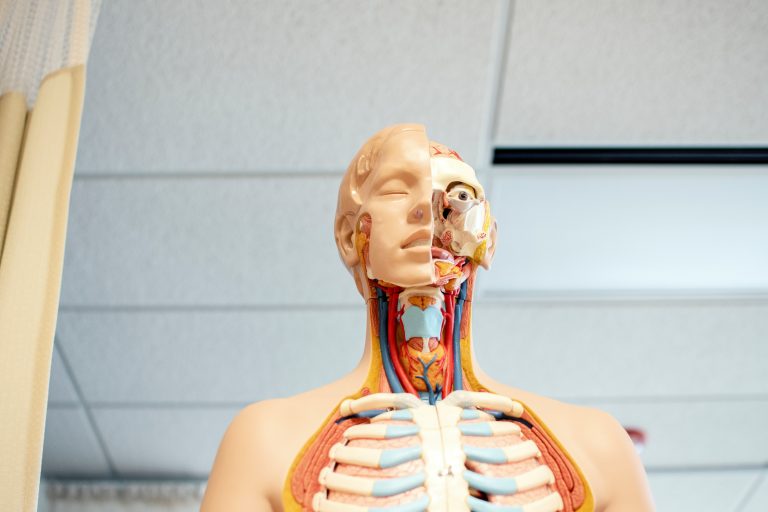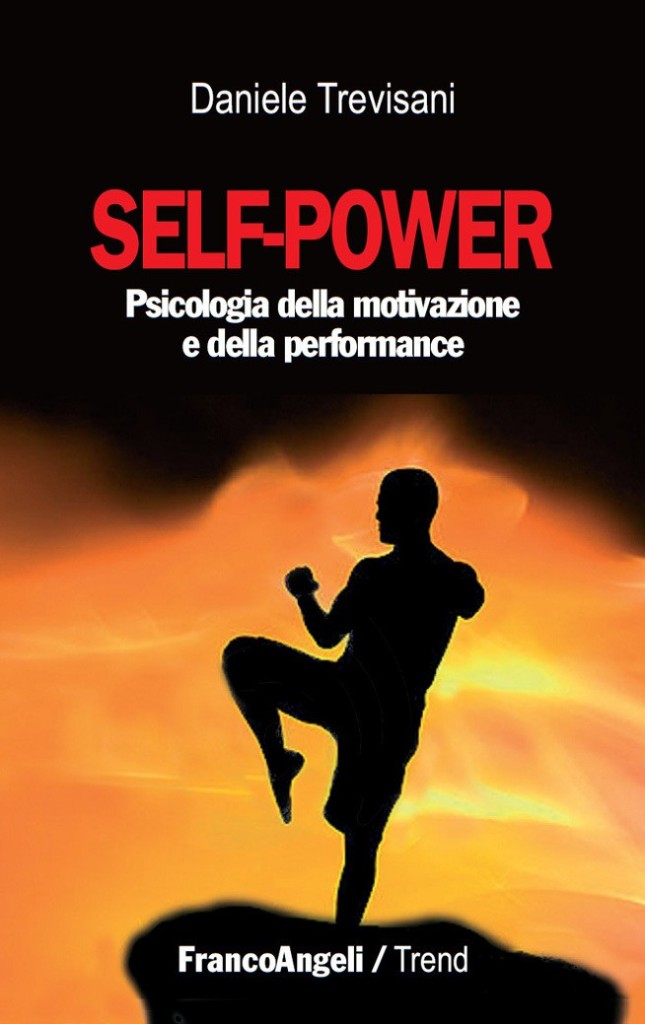© Articolo estratto dal libro di Daniele Trevisani “Negoziazione interculturale. Comunicare oltre le barriere culturali. Dalle relazioni interne sino alle trattative internazionali”. Franco Angeli editore, Milano. Pubblicato con il permesso dell’autore
La Mental Noise Theory (rumore mentale)
La Mental Noise Theory evidenzia che le persone irritate o che vivono emozioni negative hanno maggiori difficoltà nell’ascoltare e nell’elaborare l’informazione.
Il “rumore mentale” può ridurre dell’80% l’abilità di elaborare la comunicazione e di capire[1].
Tra le ragioni che conducono alla riduzione di efficienza comunicativa sino al 20% si collocano:
- traumi dovuti a esperienze precedenti;
- agende (priorità) in competizione;
- eccesso emotivo (eccesso di attivazione);
- scarso senso di autoefficacia (self-efficacy) e assertività.
La consapevolezza delle proprie predisposizioni emotive
Secondo Schein[2], per poter negoziare o lavorare positivamente è necessario identificare la propria predisposizione emotiva.
Schein evidenzia questa dinamica all’interno del processo di consulenza (relazione consulente-cliente) ma essa ha una validità che si estende a tutte le dinamiche di gestione del potere nei gruppi, come nel caso della negoziazione:
Se la mia indole mi predispone a rispondere a certi tipi di fatto con certi tipi di reazione emotiva, è necessario che io conosca questa predisposizione per giudicarne il grado di adeguatezza in determinate situazioni. Se per esempio tendo a mettermi sulla difensiva e adirarmi ogni volta che un cliente mi tiene testa o mi dà torto, devo riconoscere l’esistenza di questa tendenza e imparare a controllarmi o a gestire le mie emozioni nel miglior modo possibile,specialmente se, a mio giudizio, una polemica con il cliente non sarebbe produttiva ai fini del processo di consulenza. Non sempre, tuttavia, è sbagliato mettersi sulla difensiva o adirarsi. Talvolta è anzi la reazione più adeguata, ma per scegliere e decidere il modo migliore di affrontare la situazione è necessario conoscere le proprie predisposizioni[3]..
Come risulta evidente, la direzione data da Schein non è quella della repressione emotiva assoluta, ma la gestione consapevole.
L’ecologia della comunicazione e la leadership emotiva
L’ecologia della comunicazione rappresenta uno stimolo sensoriale complesso (inteso come insieme di input visivi, verbali, tattili, olfattivi, gustativi, cinestesici). Ogni elemento che raggiunge il sistema percettivo del soggetto è in grado di generare emozioni (forti o deboli, centrali o periferiche).
La serie di stimoli sensoriali che si attivano nella partecipazione alla negoziazione è quindi un portatore di attivazione emozionale.
Noi viviamo costantemente all’interno di specifiche aree emozionali o vissuti emozionali, ci spostiamo di emozione in emozione, spesso velocemente, altre volte lentamente.
L’incontro negoziale e le attività negoziali sono momenti di forte attivazione emotiva, poiché mettono in gioco i propri interessi personali, gli interessi del ruolo rappresentato, gli interessi dell’impresa, ma anche la propria “faccia” ed immagine, verso se stessi (autostima) e verso gli altri.
L’esito negoziale – positivo o negativo – può incidere sulla propria storia personale, sulla sicurezza di sè, sul senso di autoefficacia.
Tali fattori emotivi si amplificano in genere nella negoziazione interculturale, in cui possono entrare in gioco altre ed ulteriori dimensioni[4], quali:
- la Communication Apprehension (apprensione o ansia da comunicazione) amplificata da incontri di tipo interculturale;
- l’etnocentrismo, la considerazione che la propria cultura sia superiore e la difficoltà di accettare opinioni provenienti da culture diverse;
- la IWTC (intercultural willingness to communicate), intesa come generale atteggiamento o predisposizione (positiva o negativa) verso l’incontrare genti di culture diverse.
Diversi fenomeni rendono difficile mettere in pratica una gestione delle emozioni consapevole, razionale, in grado di farle emergere dal subconscio e dall’inconscio, per potervi “fare i conti” e reagire adeguatamente.
I rapporti tra le emozioni, la comunicazione interculturale e le performance del lavoro di gruppo
Quanto sono importanti le emozioni nell’incidere sulla performance?
Nel metodo ALM si evidenzia con forza che il vissuto emotivo di un gruppo è uno dei fattori più importanti per poter ottenere performance durature ed efficaci.
Anche un gruppo momentaneo, composto da persone che negoziano per un tempo limitato, diventa per quel periodo di tempo un team, un raggruppamento di persone che cercano di raggiungere risultati, ciascuno per se (nei modelli più arretrati) o con soddisfazione reciproca elevata, nei modelli win-win più evoluti.
L’importanza dei vissuti emotivi nei gruppi interculturali è evidenziata anche nei setting più estremi, come nei multicultural crews spaziali. La pianificazione e gestione delle missioni spaziali cambia drasticamente quando i team sono composti da persone che provengono da culture e nazioni diverse.
Sebbene accomunati da una passione e da una professione, i diversi bagagli di esperienze e di acculturazione possono portare il team-member a collidere in ambienti ristretti, non appena queste differenze iniziano a trasudare.
Diversi studi esaminano il problema, per meglio comprendere l’influenza e la gestione delle differenze culturali tra membri di equipaggi e team tecnico-scientifici che lavoreranno e vivranno nello spazio nel futuro[5]. Questi studi si rifanno quindi alle ricerche sulla intercultural effectiveness (efficacia interculturale) sulla Terra, si occupano inoltre di come migliorare le procedure di e selezione/valutazione, il training interculturale, il monitoraggio e il supporto, e il debriefing delle esperienze vissute dagli astronauti.
Essere chiusi in una stanza a “far funzionare una negoziazione” non è molto diverso – per le dinamiche interculturali in corso – dall’essere chiusi in un’astronave e doverla far operare.
Durante le manovre (fisiche o conversazionali), possono emergere una molteplicità di vissuti emotivi (rabbia, delusione, o anche semplice fastidio) che stratificandosi possono portare alla rottura del rapporto e al malfunzionamento delle operazioni.
Non si tratta solo di grandi scelte, ma a volte di micro-dettagli comportamentali, semplici gesti. Piccoli elementi secondari che all’interno di una cultura non disturbano possono risultare sgradevoli quando a giudicarli è una cultura diversa[6].
Riconoscere le emozioni è quindi indispensabile per la performance negoziale.
Il rischio dei trascinamenti emotivi durante le negoziazioni
Per trascinamento emotivo intendiamo la situazione in cui una emozione, apparentemente ben gestita e rimossa, si ripresenti sotto altre forme in momenti successivi e vada ad incidere negativamente sugli esiti di una negoziazione.
Il trascinamento può accadere:
- all’interno della stessa sessione negoziale, andando a colpire soggetti diversi da quelli che hanno generato un impatto emotivo negativo, ma anche
- tra le diverse sessioni, trasportando stati negativi da un incontro all’altro.
I trascinamenti intra-sessione
I trascinamenti intra-sessione accadono in modo molto maggiore di quanto ritenuto a livello cosciente. Un caso classico è quello della rabbia trattenuta verso uno degli interlocutori, che viene poi rigettata verso un’altro interlocutore presente, in forma modificata, attenuata o rafforzata.
Osserviamo il seguente caso, una trascrizione originale e non censurata, sul vissuto emotivo di una riunione negoziale:
Eravamo al tavolo da circa venti minuti ed eravamo appena entrati nel vivo, dopo un pò di convenevoli vari (chiacchiere sul tempo, il caffè della macchinetta, eccetera), iniziamo a discutere del merito ed ecco che entra uno, si siede, sta zitto un pò, poi inizia a dire le sue cazzate atomiche. Io chiedo se posso avere il piacere di sapere il ruolo nel progetto, e lui dice che lui ha un ruolo in tutti i progetti, e vuole vedere chi entra e chi esce dalla sua azienda. Sul progetto dice che non c’entra niente ma supervisiona un pò. Praticamente è venuto a dire che “teneva a bada” i suoi ragazzotti perché non facessero puttanate. Te la metto in un altro modo: era venuto a segnare il suo territorio come un cane che piscia sugli alberi per dire che quell’albero è suo. In pratica era entrato sulla riunione e aveva pisciato sui presenti, sui suoi collaboratori e sugli esterni, me compreso, per far capire che quello era territorio suo. Io ero appena entrato, non conoscevo nessuno, ero un esterno, e sulle prime ci sono rimasto male. Poi ho pensato che di stronzi come questi ne ho già visti un sacco in giro per le aziende, e non dovevo lasciarmi prendere più di tanto, dovevo andare dritto per la mia strada, che era di portare a casa il contratto e basta. Il bastardo magari se lo incontravo per la strada lo mettevo sotto in macchina, ma li no, altrimenti saltava tutto.
Ho continuato a farmi pisciare in testa per un pò, poi su alcuni punti l’ho contraddetto non in modo forte, ma appena sfumato, giusto per fargli capire che io ero un esperto e su certi punti non poteva permettersi di affermare di tutto e di più, senza sapere un cazzo. Comunque sta di fatto che entra ed esce dalla riunione, fa i cazzi suoi, risponde al cellulare, chiama gente in riunione e lavora li dentro, insomma, fa il figo, forse per far vedere che lui li può fare, poi esce e non torna più. Ho pensato “è morto, è sparito, finalmente, non torna più”. Verso la fine della riunione, lui non c’era ancora, cerchiamo di tirare le somme e a me esce una frase di questo tipo “si, possiamo certamente fare un buon progetto, l’importante è tenere fuori dal progetto la politichetta aziendale da due soldi, io sono uno che se c’è un problema lo dice e non fa finta di niente solo perché è scomodo dirlo”. Teniamo conto di una cosa: ero nel posto più sbagliato del pianeta per dire una cosa così. Avrei dovuto tirarla fuori dopo essere entrato come fornitore, dopo aver trovato qualche alleato, non lì, al primo incontro. E mi accorgo adesso che mentre dicevo questo strizzavo gli occhi, sembravo Clint Eastwood che sta per sparare a qualcuno. Adesso riconosco che avevo un mucchio di rabbia ancora addosso, farmi pisciare addosso dallo stronzo, mi aveva dato fastidio, e la stavo rigettando sugli altri, sui suoi collaboratori. Poi ti dirò che anche la sera a casa ero disturbato, ho fatto fatica ad addormentarmi, non sopportavo l’idea che uno stronzo raccomandato ignorante mi pisci in testa in quel modo.
I trascinamenti tra sessioni
Il trascinamento tra sessioni si forma in seguito ad esperienze negative avute in rapporti precedenti con lo stesso soggetto o con la stessa categoria di soggetti. Possiamo avere avuto esperienze spiacevoli con una categoria e allargare queste esperienze all’intera categoria, entrando con una disposizione sbagliata nella negoziazione.
Gli stereotipi che si formano debbono essere usati con cautela. Soprattutto, è indispensabile apprendere a fare “pulizia mentale” dagli atteggiamenti negativi frutto di sessioni precedenti e poter entrare nella negoziazione con la mente libera.
I trascinamenti tra stati emotivi della vita personale e le situazioni professionali
La vita personale genera inevitabilmente vissuti emotivi.
Le relazioni con amici, familiari, parenti, gli eventi vissuti fuori dal lavoro impattano immancabilmente la persona. Alcuni individui sono bravi nel mascherare quanto accade loro (di negativo, soprattutto) nella vita personale, ma il mascheramento non è la strategia migliore.
Le tecniche più evolute sul piano professionale prevedono – per chi ha necessità di negoziazione pressante e per chi negozia ad alto livello – il ricorso a strumenti di counseling e coaching professionale, in grado di supportare il soggetto nell’elaborare i fatti della vita personale e professionale, ed integrare in modo armonico il vissuto personale con quello manageriale.
Non si può far finta che un manager che abbia appena avuto un trauma familiare o professionale possa vivere il lavoro come nulla fosse ed essere egualmente produttivo. Una difficoltà nel matrimonio, con i figli, o a causa di malattie, riduce la concentrazione e le energie mentali disponibili.
Allo stesso tempo, sul piano opposto, è possibile apprendere ad alimentarsi delle emozioni positive che la vita privata può offrire e assorbire queste energie per nutrire il piano professionale.
Si può tranquillamente affermare che oggi uno dei punti più sottovalutati del management sia la condizione energetica e motivazionale del soggetto, la visione del manager o collaboratore come “essere olistico” che ha una vita sia psicologica che fisica.
La negoziazione interculturale può creare turbolenza emotiva e stress emotivo elevato. La negoziazione stessa (anche intraculturale) è un fenomeno che impegna a fondo i sistemi energetici della persona. L’addizione della variabile interculturale forte aumenta il costo cognitivo di attenzione, elaborazione, le probabilità di fraintendimento, di rottura, di riparazione.
È sul piano energetico quindi che i manager vanno aiutati a trovare e mantenere una condizione elevata, positiva, in grado di fornire loro il supporto necessario per le sfide negoziali interculturali.
Le tecniche per gestire e ridurre lo stress emotivo da negoziazione
Per gestire lo stress emotivo da negoziazione vengono utilizzate nel metodo ALM diverse strategie.
Le tecniche di training autogeno e meditative (tecniche passive) e altre tecniche di rilassamento (dissipazione fisica, sport, tecniche attive) sono estremamente utili per generare una buona predisposizione emotiva nel negoziatore, soprattutto se praticate nella stessa giornata, prima della sessione negoziale.
Sul piano immediato, la separazione tra vissuti emotivi personali e tempo professionale può essere facilitata da apposite tecniche di rilassamento, mentre a livelli avanzati e sul lungo periodo risulta più produttivo il ricorso alle professionalità di coaching e counseling manageriale, che aiutino il manager a rivedere in profondità sia gli elementi dello stile di vita (lifestyle training) che la modalità di gestire le emozioni (emotional management)[7].
Le tecniche utilizzabili sono:
- strategie di preparazione concettuale e desk-work: analisi culturale, delle obiezioni culturali latenti, preparazione alla gestione delle obiezioni;
- strategie di preparazione esperienziale: role playing situazionali per affinare e attivare gli schemi motori e conversazionali, creare readiness nelle le mosse conversazionali e creare sicurezza;
- strategie di preparazione emozionale e riassetto emotivo: tecniche di rilassamento, training autogeno, concentrazione e meditazione;
- tecniche fisiche di ricarica bio-energetica: lavoro fisico di rimozione dello stress tramite esercizio fisico finalizzato;
- tecniche di disidentificazione, come quelle proposte da Assoagioli nella disciplina della Psicosintesi, che “allontanano” emotivamente il soggetto dall’esperienza in corso, come se fosse qualcosa che stia capitando ad altri e non intacca il proprio Self;
- tecniche di ristrutturazione cognitiva, ad esempio passare dalla concezione della “negoziazione come scontro” alla “negoziazione come relazione d’aiuto” (aiutare la controparte a capire qualcosa o raggiungere un obiettivo);
- tecniche di debriefing post-trattativa: in grado di sciogliere lo stress da negoziazione, rielaborarlo e utilizzarlo per la crescita anziché lasciare che esso blocchi l’individuo e lo impegni concettualmente ed emotivamente, rendendolo inadeguato a fronteggiare nuovi obiettivi o sfide.
[1] Fonte: ns. elaborazioni basate su Riley, Kirk (2005). Risky Business: Involving the Public in Environmental Decision Making. Materiale didattico, Great Lakes & Mid-Atlantic Center for Hazardous Substance Research, Michigan State University, East Lansing, Michigan
[2] Schein, E. H. (1999). Process Consultation Revisited: Building the Helping Relationship, 1999, Addison Wesley. It.: La consulenza di processo: come costruire le relazioni d’aiuto e promuovere lo sviluppo organizzativo. Milano, Cortina.
[3] Ibidem.
[4] Vedi ad esempio Lin Y, Rancer AS. (2003). Sex differences in intercultural communication apprehension, ethnocentrism, and intercultural willingness to communicate. Psychol Rep. 2003 Feb;92(1):195-200
[5] Vedi Kealey DJ (2004). “Research on intercultural effectiveness and its relevance to multicultural crews in space”. Aviation Space Environmental Medicine2004 Jul;75(7 Suppl):C58-64.
[6] Ad esempio, non è difficile vedere uno studente statunitense anche adulto partecipare ad una lezione universitaria in canottiera e ciabatte d’estate, o ancora sentire “tirare sul col naso” frequentemente in una biblioteca americana ove molti abbiano il raffreddore, ma questi comportamenti provocano nella cultura italiana un notevole fastidio, per cui uno studente statunitense che si inserisca in un gruppo di studio italiano potrebbe generare fastidio e provocare emozioni negative, se non consapevole di questi micro-fenomeni.
[7] Esempi di servizi di lifestyle training, coaching e counseling manageriale, e temi di communication management training, sono riportati sul sito www.studiotrevisani.it
Altri materiali su Comunicazione, Coaching, Formazione, Potenziale Umano, Crescita Personale e Professionale, disponibili in questi siti e link:
- Sito Studio Trevisani Formazione Coaching Consulenza
- Sito Daniele Trevisani (Italian)
- Website Dr. Daniele Trevisani (English)
- Comunicazione Aziendale
- Medialab Research
- Intercultural Negotiation (English)
- Comunicazioneinterculturale.it
Altre risorse online
- Pubblicazioni e libri dott. Daniele Trevisani (Books published)
- Rivista online gratuita di Comunicazione, Potenziale Umano e Management
- Iscrizione gratuita al Blog Studiotrevisani.it tramite Email
- Canale YouTube
- Coaching World Federation (CWF)
- Linkedin Profile Dr. Daniele Trevisani
Siti in sviluppo
- www.coachingevolution.eu
- www.coachingworldassociation.com
- www.comunicazioneinterculturale.it
- www.healingacademy.it
- www.marketinginterculturale.it
- www.medialab-research.com
- www.negoziazioneinterculturale.it
Le parole chiave di questo articolo La gestione delle emozioni nella negoziazione interculturale sono :
- Coaching professionale
- Comunicazione interculturale
- Ecologia della comunicazione
- Emotional management
- Emozioni
- Lifestyle training
- Mental noise theory
- Negoziazione interculturale
- Performance negoziale
- Predisposizione emotiva
- Pulizia mentale
- Rumore mentale
- Stati emotivi
- Stimolo sensoriale
- Stress emotivo
- Strumenti di counseling
- Tecniche di rilassamento
- Tecniche di training autogeno e meditativo
- Trascinamento emotivo
- Vissuto emotivo
- Vita personale e professionale